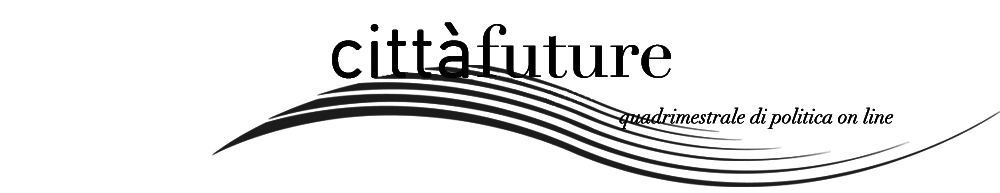Recensioni
DAVID HARVEY, IL CAPITALISMO CONTRO IL DIRITTO ALLA CITTà
Urbanità e marxismo
Alessandro D'Aloia
Il piccolo libretto pubblicato nel 2012
da Ombre corte, rappresenta un’occasione molto preziosa per cercare di
inquadrare meglio il rapporto, storicamente asimmetrico, istauratosi tra
marxismo e fenomeno urbano[1]. È un bene
che a fornire questa occasione sia un geografo, sociologo e politologo
che si definisce ancora un marxista senza timore di apparire fuori dal
mondo. Il libro si compone di tre parti che sono in realtà tre articoli
pubblicati in differenti occasioni: 1.
Il diritto alla città; 2.
Il diritto alla città. La visione di Henri Lefebvre; 3. Le radici urbane della crisi finanziaria. Restituire la città alla
lotta anticapitalista.
Senza ripercorrere ordinatamente la
successione dei numerosi spunti che l’autore fornisce, l’inten-zione è
qui quella di focalizzare l’attenzione sulle tesi che paiono emergere
con forza dall’insieme dei tre testi che compongono il libro.
La prima tesi è rappresentata dalla
stretta interdipendenza esistente tra speculazione edilizia e crisi
finanziarie. Per quanto i due fenomeni possano apparire indipendenti,
soprattutto nella lettura consolidata delle crisi cicliche del
capitalismo, Harvey fa notare come, al di là del fatto che l’ultima
crisi convergente sia partita dalla vicenda dei mutui
subprime americani, esista una
storia antica di “bolle immobiliari” che precedono sistematicamente le
crisi finanziarie a partire dalla Parigi di Haussmann. Questo perché
l’autore spiega i processi di grossa urbanizzazione forzata come uno dei
più importanti espedienti economici del capitalismo per impiegare
l’enorme eccedenza concentrata che esso produce[2]. Il fattore
tempo è l’elemento determinante nella finanziarizzazione dello spazio. I
processi architettonici ed infrastrutturali, come le grandi opere, ad
esempio, a differenza di altri processi produttivi, sono caratterizzati
dal fatto di richiedere grossi intervalli di tempo per essere portati a
compimento. Questo fatto permette di avere dei programmi di investimento
all’altezza delle eccedenze che la società nel suo complesso produce e
che naturalmente si concentrano in poche mani. Ciò che però rappresenta,
da un lato, un espediente per l’impegno di risorse, costituisce,
dall’altro, un problema. Infatti proprio a causa dei tempi lunghi
necessari per il compimento delle opere, accade che prima che tale
enorme massa di “investimenti” possa produrre degli effetti economici,
realizzando almeno il valore investito, il capitale impiegato resta, per
il grosso, improduttivo. Tale “periodo morto”, in termini di
produttività del capitale investito, richiede dunque l’intervento della
finanza, senza la quale sarebbe difficile evitare una andamento a
singhiozzo dei processi urbani di grosso cabotaggio, senza contare che
non è neanche detto che, in generale, l’eccedenza accumulata abbia
natura differente da quella finanziaria[3]. È però un
fatto che risolvere il problema delle eccedenze, cioè trovare un modo
profittevole di impiegarle, non significa ancora realizzare il loro
valore sul mercato. Capita anzi che tali valori si riescano a realizzare
anche decenni dopo aver avviato i processi. Per questo motivo la
componente finanziaria dell’eco-nomia viene a trovarsi puntualmente
coinvolta nel buco nero dell’improduttività degli ingenti capitali
anticipati nel settore edile ed è per questo che è quasi sempre
possibile stabilire una connessione diretta tra grossa urbanizzazione e
crisi finanziarie, al di là dello schema consolidato che vuole le crisi
economiche quali conseguenze quasi esclusive della semplice
sovrapproduzione di merci di consumo. Anzi è piuttosto facile rilevare
come le crisi da sovrapproduzione classica non coinvolgano
necessariamente risorse finanziarie, almeno in astratto. Di passata è
utile osservare un corollario del meccanismo descritto e cioè che dal
momento in cui si urbanizza il territorio soprattutto in relazione alla
necessità di trovare uno sfogo al problema dell’ecce-denza, va da sé che
i più grandi impegni costruttivi non rispondano certo ai reali bisogni
sociali, con l’effetto di anarchizzare all’estremo la crescita urbana
(infinita), senza certezza alcuna di poter realizzare profitti reali nel
breve periodo. La conseguenza diretta è un consumo insensato di
territorio sul piano delle risorse spaziali e di un rischio, sul piano
economico, tanto più grosso quanto più megalomane è il progetto urbano.
Il paradosso di questa situazione è che mentre fette sempre crescenti di
comunità urbane vengano espulse dalla città[4], porzioni
sempre maggiori di spazio urbanizzato sorgono per il solo scopo di
materializzare capitali in cerca di una ragion d’essere. Ma ancora più
problematico risulta essere l’aspetto del doppio controllo finanziario
sul mercato urbanistico, infatti può accadere che la risorsa di capitale
finanziario sia coinvolta sia dal lato della produzione edilizia, che da
quello del mercato edilizio, quando con il meccanismo dei mutui si cerca
di assicurare che le produzioni urbane vengano anche cedute in proprietà
mediante il debito socializzato degli acquirenti. Con questo espediente
si cerca di lavorare quasi su commessa, minimizzando il periodo morto al
tempo tecnico di costruzione. Questo duplice coinvolgimento finanziario
crea addirittura un doppio nodo tra dinamiche urbanistiche e flussi di
capitale finanziario.
È noto che ciò che rende irresistibile
l’impegno finanziario nell’urbanizzazione, al di là del problema
dell’improduttività immediata, è l’eccezionale rendimento degli
investimenti, che nessun altro settore è in grado di equiparare. Ma c’è
di più. Quanto più un’operazione urbana è impossibile per la stragrande
maggioranza dei fruitori e anche degli investitori, tanto più il ritorno
economico tende a caratterizzarsi, più che come semplice profitto, ad
esempio la differenza tra valore di mercato (o di scambio) e valore di
costruzione, proprio come rendita permanente. Per chiarire meglio, se il
valore di mercato di un immobile molto centrale, nuovo e ipertecnologico
è davvero inavvicinabile, allora esso sarà cedibile solo in locazione
per attività di prestigio o come residenze di lusso, producendo non
profitto ma direttamente rendita. È noto infatti che in periodi di crisi
mentre il mercato delle vendite immobiliari cala, il mercato dei fitti
si rafforza, almeno temporaneamente. Per questo motivo l’urbanizzazione
non solo rappresenta un modo come gli altri di realizzare profitto, ma
un modo di ricavare dalle eccedenze finanziarie sia plusvalenze sulle
aree interessate sia rendite permanenti, anche se magari a medio
termine. La produzione di rendite urbane gioca, infine, un ruolo
fondamentale nel contrastare con efficacia la caduta tendenziale del
saggio di profitto, che altrimenti potrebbe, a lungo andare,
disincentivare la dinamica di crescita economica in generale, ragione
per la quale la crescita urbana capitalistica è sostanzialmente
inarrestabile, indipendentemente dalla domanda reale.
Tornando però ai testi di Harvey, è bene
focalizzare l’attenzione sulla seconda tesi che ne emerge, ovvero che
prima di giungere al problema del profitto ed eventualmente della
rendita, la costruzione della città, delle sue infrastrutture e dei suoi
servizi, si caratterizza a tutti gli effetti come un processo di
produzione, anche se per strana abitudine, non considerato sullo stesso
piano della produzione industriale di merci. Al di là del fatto che
anche il settore delle costruzioni può essere, ed in gran parte è,
industrializzato, esso come tutti i processi produttivi impiega forza
lavoro, e in gran quantità, anche se magari in modo diffuso e poco
concentrato. Da questo punto di vista siamo dunque nel più classico dei
meccanismi capitalistici di produzione di valore e di plusvalore, a
maggior ragione oggi che persino la produzione industriale,
post-fordista, di merci assume i caratteri della dispersione e della
piccola dimensione. Si osserva quindi una sostanziale equivalenza tra
processi produttivi urbani, cioè edilizi, e industriali in generale.
Questo significa che passata l’era fordista non è stato tanto il modello
industriale, quello della grossa concentrazione produttiva, ad
egemonizzare la produzione, quanto piuttosto quello edilizio, per così
dire un modello toyotista ante
litteram, nel senso di piccolo e diffuso. Non sussiste dunque nessun
motivo razionale di continuare a leggere i diversi settori economici
come qualcosa di realmente separato, ma piuttosto il fenomeno urbano,
preso complessivamente, è un ambito che li contiene tutti, allo stesso
modo di come contiene il campionario completo degli aspetti legati al
valore, dall’estrazione di plusvalore nel processo produttivo, alle
plusvalenze dovute alle trasformazioni urbane del territorio, alla
formazione di rendite permanenti, al coinvolgimento di capitali
finanziari nella produzione e nel mercato edilizio. Il settore urbano è
cioè la summa dei meccanismi economici del capitalismo.
A partire da questa constatazione, la
terza, e politicamente più rilevante, tesi di Harvey, è quella
riguardante la trasformazione del concetto di “proletariato” in questo
contesto e dunque la nozione di soggetto di lotta per la transizione
oltre il capitalismo. Se l’operaio impiegato nell’industria
post-fordista è oggi un soggetto tra gli altri a causa della dispersione
produttiva e della dimensione sempre più sparuta delle sedi industriali,
non c’è motivo di considerarlo quale unico potenziale soggetto di lotta,
separato dagli altri operai, ad esempio, quelli edili, che sono
numerosissimi. Per questo motivo Harvey propone una lettura più
comprensiva del concetto di proletariato urbano[5], che allarghi
la propria geografia dalla fabbrica alla città, includendo operai,
precari della produzione e dei servizi, immigrati, e anche disoccupati,
in una parola la “comunità urbana” che mentre costruisce la città e la
mantiene con il proprio lavoro, è di fatto espulsa sistematicamente
dalla città stessa. Come a dire: se la fabbrica post-fordista non
concentra più forza lavoro come una volta esiste pur sempre un luogo che
concentra lavoratori di tutti i settori, se si è disposti ad allargare
lo sguardo oltre i cancelli del singolo sito produttivo e guardare alla
fabbrica per eccellenza che è la città. Su questo punto si apre tutto un
possibile dibattito[6]
sull’efficacia stessa delle forme di lotta che il sistema urbano, nel
suo complesso offre, rispetto allo sciopero del singolo settore
produttivo. Di passata non è superfluo osservare come, in periodo di
cassa integrazione, lo sciopero di fabbrica sia poco dannoso nei
confronti dei padroni, mentre il blocco organizzato di attività vitali
per la città potrebbe avere effetti realmente devastanti. Harvey fa
l’esempio dei trasporti e delle forniture di acqua, energia elettrica,
generi alimentari e così via, per evidenziare quanto il sistema urbano
sia in realtà totalmente dipendente dal lavoro. Harvey nota anche come
le rivoluzioni siano sempre state delle rivoluzioni urbane e come questo
fatto non sia mai stato una semplice conseguenza della localizzazione
urbana delle industrie, ma piuttosto un’interazione complessa tra operai
industriali e comunità urbane che permettevano e sostenevano attivamente
le lotte.
In questo senso è necessario recuperare
il tema Lefebvreviano del diritto
alla città che altrimenti rischia di restare un “significante
vuoto”.
Nelle analisi di Harvey lo slogan del
diritto alla città è considerato nella consapevolezza dei suoi limiti
storici. L’autore infatti assume come un dato il fatto che il termine
“città” si configura quale valore iconico di un’entità che oggi non
esiste più nel suo senso tradizionalmente inteso[7]. Per questo
motivo pur conservando lo slogan soprattutto per il valore simbolico di
inclusione sociale che ne deriva, in contrapposizione ad processo reale
di espulsione crescente della società dallo spazio urbano, sempre più
ambito esclusivo di un ristrettissimo ceto economico, egli spiega come
esso vada inteso più come diritto alla “produzione dello spazio”. In
questi termini la rivendicazione non concerne più un oggetto particolare
del fenomeno generale di urbanizzazione del territorio, ma l’ambito
complessivo della configurazione spaziale, in tutti i suoi aspetti. E
suggerisce questa evoluzione seguendo la genealogia stessa del pensiero
di Lefebvre, il quale ha progressivamente spostato il fuoco della
propria trattazione dalla città alla produzione dello spazio. In questi
termini, Harvey espande il significato della produzione dello spazio ad
ambito complessivo di azione politica[8]. Se infatti
il controllo operaio sulla produzione industriale implica la decisione
democratica sul cosa produrre e come farlo, allora il controllo delle
comunità urbane sulla produzione dello spazio implica la decisione
democratica su cosa, come costruire e per chi a partire anche dalla
consapevolezza che l’uomo costruendo il proprio ambiente, ricrea in
primo luogo se stesso.
APRILE 2013
[1]
«Nel commemorare il centenario della pubblicazione del
Capitale di Marx con
un saggio sul diritto alla
città, l’intenzione di Lefebvre era sicuramente quella di
sfidare il pensiero marxista ortodosso, che alla dimensione
urbana non aveva mai concesso molta importanza nella strategia
rivoluzionaria, benché avesse mitizzato la Comune di Parigi come
evento centrale della sua storia».
D. Harvey, Il Capitalismo contro il
diritto alla città, Ombre corte, Verona 2012, p. 47.
[2]
«La mia ipotesi è che essa [l’urbanizzazione capitalista] svolga
un ruolo particolarmente attivo (insieme ad altri fenomeni come
le spese militari) nell’assorbire le eccedenze che i capitalisti
producono costantemente nella loro ricerca di plusvalore».
Ibidem, p. 12.
[3]
«Ma proprio perché tutta questa sua attività – […] – è così a
lungo termine, per il suo funzionamento l’urbanizzazione
richiede una combinazione di capitale finanziario e impegno
statale». Ibidem, p. 72.
[4]
«I risultati della crescente polarizzazione nella distribuzione
della ricchezza e del potere sono indelebilmente impresse nelle
forme spaziali delle nostre città, che sono sempre più
costituite da frazioni fortificate, da comunità chiuse e da
spazi pubblici privatizzati e tenuti costantemente sotto
sorveglianza». Ibidem,
p. 25.
[5]
«Se cambiamo la nostra ottica nei confronti dell’ambiente in
cui avviene la lotta, il senso di cosa sia il proletariato e
quali siano le sue aspirazioni potrebbe uscirne trasformato».
Ibidem, p. 101.
[6]
«Dunque – […] – come ci si organizza nella città? Questa a mio
parere è una delle domande chiave alla quale la sinistra dovrà
rispondere se vuole rivitalizzare la lotta anti-capitalista
negli anni a venire».
Ibidem, p. 103.
[7]
«La città tradizionale è stata uccisa dal rampante sviluppo
capitalistico, vittima dell’incessante bisogno di circolazione
della sovraccumulazione di capitale, che ha condotto ad una
crescita urbana infinita e tentacolare, senza preoccuparsi delle
conseguenze sociali, ambientali e politiche».
Ibidem, p. 50.
[8]
«Rivendicare il diritto alla città nel senso che qui intendo
fare, significa rivendicare una forma di potere decisionale sui
processi di urbanizzazione e sul modo in cui le nostre città
sono costruite e ricostruite, agendo in modo diretto e
radicale». Ibidem, p.
9.