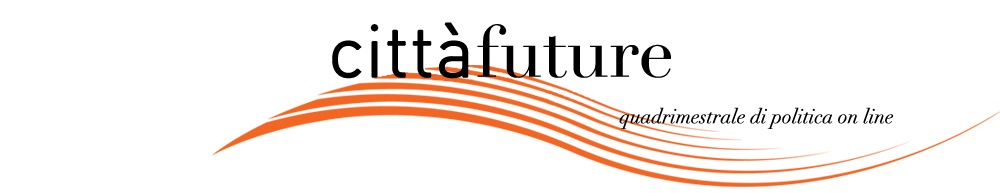Recensioni
IL COMUNE di M. Hardt e T. Negri
Uno spettro s'aggira
per il globo
Alessandro D'Aloia
Nel riportare alcuni, fra
gl'innumerevoli, dei punti salienti dell'ultimo lavoro di Toni Negri e
Michael Hardt, bisogna sgombrare subito il campo dalla pretesa di
rendere in poche pagine la ricchezza di un testo enciclopedico, che si
configura come una sorta di summa teorica del pensiero rivoluzionario
nell'epoca attuale. Si cercherà piuttosto una chiave di lettura in cui
tentare di evidenziare quei tratti di affinità con parte delle tematiche
che la rivista sta cercando di
portare avanti da un po' di tempo a questa parte e che il testo in
questione riesce a legare insieme in una coerente e convincente trama
teorica. L'indicazione è quella di cercare di apprezzare le categorie
interpretative presenti nel testo al di là delle distorsioni e
strumentalizzazioni cui alcune di esse sono state sottoposte negli
ultimi anni, da parte di sinistre
forze politiche, le quali in preda ad un “nuovismo” a tutti i costi
improntato ad una pura estetica
terminologica, perseguivano coscientemente l'unico obiettivo di
determinare l'abbandono delle chiavi analitiche affermate nella lunga
tradizione del movimento operaio, senza però essere in grado di fornire
un nuovo quadro teorico comprensibile da porre quale riferimento
dell'azione politica, al fine di giustificare il proprio
governismo più bieco, capace
di negare in toto tanto la
tradizione quanto l'attualità
di un'istanza rivoluzionaria a sinistra.
Il linguaggio utilizzato dagli autori è
invece evidentemente frutto di una sincera tensione a fornire un quadro
di azione ancorato alle condizioni variate in cui il capitalismo
contemporaneo ci colloca rispetto al passato, senza con questo negare i
capisaldi teorici classici, che restano validi nelle loro condizioni
storiche.
Gli autori posseggono un'indubbia
capacità di penetrazione delle problematiche contestuali attuali oltre
che una vastissima conoscenza del pensiero critico dal quale attingono
senza remore ideologiche di sorta, assumendo quell'utile atteggiamento
di trasversalità speculativa che non disdegna fonti “allargate” rispetto
alla tradizionale “ortodossia marxista”, pur dichiarando che il marxismo
rimane il principale angolo visuale dal quale costruire le
macchine concettuali con cui
comprendere i fenomeni che si osservano[1].
Lo stesso titolo del testo, Il Comune, è
straordinariamente simile e vicino all'evento della Comune parigina, il
quale pur avendo originato la possibilità di una concezione
completamente diversa della politica e della vita sociale è rimasto
stranamente il grande
riferimento mancato della politica di opposizione al capitale lungo i
140 anni che ci separano dalla sua apparizione. Il semplice artifizio
letterario di titolare al maschile non autorizza, a parere di chi
scrive, a pensare che si stia parlando di qualcosa di diverso
[2] ed è anche per
questo che il libro è interessante, nella sua riproposizione in chiave
attuale dell'enorme questione
della Comune. Se una “terza via” è contemplata nella visione degli
autori, questa terza via è appunto quella comunista, terza rispetto alle
opzioni storicamente egemoni del privato (dominio del capitale) e del
pubblico (illusione socialdemocratica nel governo politico del capitale
privato).
Non che gli artifizi non paghino
necessariamente in termini di chiarezza, infatti le scelte stilistiche
hanno le loro conseguenze. È il caso di una narrazione che si svolge
quasi come un thriller, costretta per questo ad una certa
frammentarietà, pur di lasciare alla fine il capitolo sulla
rivoluzione, o ancora
l'assimilazione tout court del
concetto di “socialismo” con la concezione di una gestione pubblica e
socialdemocratica dell'economia. Su quest'ultimo punto in particolare va
detto che chi legga il libro capirà benissimo in quale accezione gli
autori intendano la parola “socialismo”, ma che forse si poteva tentare
quanto meno una differenziazione fra il socialismo come ideale di massa
e la sua variante storica “reale” che negando il comunismo come
orizzonte, negava non di meno il socialismo come suo innesco, stando
almeno al Lenin di Stato e
Rivoluzione, ad esempio.
Allora ammesso che nel linguaggio comune
i termini conservano sempre una certa ambiguità non è poi difficile
ammettere che una prospettiva rivoluzionaria abbia oggi bisogno tanto di
costituirsi contro il capitale, quanto di superare le “illusioni
socialiste” intese appunto come la credenza che sia possibile un
governo, ancorché pubblico, del capitale. Il capitale è ingovernabile
per fini ad esso estranei, tantomeno se si pensa che ciò sia possibile
mediante le attuali forme di rappresentanza istituzionale.
Nondimeno resta possibile, a nostro
avviso, intendere per “socialismo” esattamente la necessità di un
orizzonte politico complessivo altro dal capitalismo, ed è questo il
senso della rubrica intitolata
«socialismo come fine», per quanto si renda senz'altro necessario
problematizzare la questione della “transizione” in termini di
continuità con il presente piuttosto che come fase nettamente definita
in termini temporali. È del tutto condivisibile infatti la
sollecitazione a pensare la rivoluzione come un
processo asintotico ancorato
nel presente e non separato da noi dal futuro, in quanto già
potenzialmente operante nelle modalità del lavoro biopolitico.
«[…] la nostra declinazione non
dialettica della transizione delinea un approccio asintotico il quale fa
sì che, se anche il movimento non giunge mai a conclusione, la distanza
tra la transizione e lo scopo finale, tra mezzi e fine, diventa così
infinitesimale che cessa di avere importanza. Questa declinazione della
transizione non va confusa con le vecchie illusioni riformiste che
puntavano ad un cambiamento graduale con cui procrastinare
indefinitivamente nel futuro l'avvento della rivoluzione»[3].
Questa presenza immanente nel presente
degli elementi di una nuova concezione dell'esistenza è talmente
condivisibile da portare a sostenere che, contrariamente a quanto
ritenuto dagli autori, le condizioni per una produzione autonoma di
valore e per un'autonoma “gestione del mondo” sono in essere almeno dal
1871, molto prima cioè della marginalizzazione del capitalista dal
processo produttivo maturata con il
lavoro biopolitico. Certo che
ammessa questa impostazione bisogna capire cosa farsene del termine
“socialista”.
È infatti del tutto ragionevole pensare,
con Lenin, che fino a quando i lavoratori avranno bisogno di capi per
lavorare essi sentiranno il bisogno di leader politici[4]
mentre «la democrazia si impara
solo facendola», e quindi
che se fino ad oggi la democrazia, come autonoma gestione della vita, è
stata negata, lo è stata non a causa dell'immaturità storica delle masse
subalterne, o della moltitudine, ma per precisa volontà politica del
capitale, che impone sempre separazione e quindi dei capi. Se così non
fosse, non si tratterebbe di criticare la storia delle dirigenze
politiche di sinistra ma direttamente l'incapacità politica della
moltitudine. Marx riteneva invece che il ruolo del capitalista nel
processo produttivo fosse storicamente superfluo già durante lo sviluppo
del Capitalismo e non pare di poter affermare il contrario, neanche con
il senno di poi.
Ma questo non vuol dire che dunque non
si possa essere, a maggior ragione, d'accordo con l'assoluta attualità
del problema dell'organizzazione autonoma del lavoro biopolitico, tanto
più al punto al quale ci troviamo oggi. Ma cerchiamo di procedere con
ordine, nei limiti del possibile.
Prima questione: l'essenza del lavoro
biopolitico e le diverse fonti del valore.
Se si ricorda la sostanziale
assimilazione dell'inconscio ad una fabbrica e ad una società in
costante moto produttivo, di cui siamo debitori all'anti-Edipo di
Deleuze e Guattari[5],
risulterà più facile concepire la produzione umana come “poiesi” ovvero
come potere creativo innato nello spirito dell'uomo. Ne consegue che
l'umanità produce continuamente ed instancabilmente indipendentemente
dalle forme storiche di appropriazione di tale produzione, tanto che la
storia è in definitiva la cronaca dei modi con cui il valore prodotto
viene estorto. L'uomo crea valore non perché sottomesso all'imperativo
della produzione, ma per indole creativa. La produzione di valore è data
in assoluto, la sua trasformazione in valore economico è storicamente
determinata. La produzione di valore eccede continuamente le forme
storiche di estorsione che non sono in grado di realizzare l'intero
valore potenziale. Gran parte di questo valore non è misurabile in
termini economico-quantitativi, anche per questo è difficile
monetizzarlo interamente. Il capitalismo si caratterizza nella sua fase
fordista, come processo produttivo che estrae plusvalore dal lavoro
salariato, in modo automatico. Questa la principale fonte di
accumulazione che caratterizza il capitalismo in quanto tale. Tuttavia
l'irrompere di questa nuova modalità di “estorsione pacifica” non
annulla, né sopprime naturalmente altre forme di estorsione dirette ed
indirette, che in qualche caso derivano da criteri di appropriazione
precapitalistici, in altri casi, rielaborati, determinano la nascita di
nuove forme di appropriazione post-fordiste, che vanno ad integrare le
modalità proprie del capitalismo, tanto che la rendita, di cui la
finanza è il principale organo di captazione, nelle sue diverse forme
torna prepotentemente al centro della scena. L'insieme di tutte queste
intercettazioni di valore economico rappresentano le
esternalità di cui il privato
beneficia senza merito alcuno ed indipendentemente dal suo ruolo nella
produzione di ricchezza. Il lavoro
biopolitico è questa produzione incessante di valore (in tutte le
sue forme), nonostante ed al di là del
biopotere che cerca di
controllare il mondo. Il biopotere, come il capitalista, ed in generale,
i capi, sono un ostacolo per la produzione di valore, oltre che gli
estorsori concreti. Il lavoro biopolitico per produrre è costretto ad
eludere in ogni modo possibile il biopotere, raffinando per questo
motivo le sue capacità di
organizzazione, di cooperazione e di autonomia. Il lavoro
biopolitico è la resistenza quotidiana al potere, che nell'atto della
resistenza produce più valore di quanto il biopotere osi realizzare in
termini monetari. L'incapacità del capitalismo di realizzare tutto il
valore è ciò che determina il paradosso di una creatività diffusa e
nondimeno dispersa, parcheggiata ai margini dei processi produttivi
perché assolutamente eccessiva per quello che il capitale se ne può
fare: uno spreco inconcepibile di talenti come fotografia
dell'inadeguatezza storica del capitale.
In realtà tutto ciò che le forme
storiche di appropriazione privata non riescono ad incamerare va a
costituire il Comune come essere, come ricchezza disponibile, che caratterizza la doppia
essenza del Comune, come prodotto del lavoro biopolitico oltre che come
insieme delle risorse naturali del pianeta.
Seconda questione: il soggetto
rivoluzionario, ovvero la moltitudine.
Ma quale è il soggetto del lavoro
biopolitico? È la moltitudine. Perché non dire “il proletariato” o “i
lavoratori” o “il popolo”? Perché le categorie storiche con cui si
designano in genere le masse oppresse, si basano sul presupposto della
possibilità di un'identità unica,
che in realtà non esiste.
Gli autori sulla scorta delle tesi di
chi già dagli anni settanta, lasciava notare come l'identità non sia
altro che una costruzione artificiale[6] sostengono che se
l'individuo stesso, o meglio una singolarità, è di per sé una
molteplicità (inconscio come una società) non riconducibile ad unità
della personalità, a maggior ragione una massa di singolarità non
risulterà mai rappresentabile in una categoria unitaria. L'essere è in
continuo divenire.
Ma l'impossibilità di un'identità
collettiva è lungi dal dare per spacciata l'opzione rivoluzionaria. Dire
che un soggetto è molteplice non significa infatti negarne l'esistenza e
le possibilità storiche, ma solo riconoscerne la natura. Il problema
perciò non è tanto chi fa la
rivoluzione, ma come la fa.
Dunque il soggetto della rivoluzione, è
lo stesso capace della produzione di valore, il quale non deve fare
altro che rendere politica la sua resistenza quotidiana.
«[…],
il centro del programma politico è il passaggio dalla resistenza alla
proposta e dalla jaquerie all'organizzazione. Si tratta di un passaggio
arduo e complesso […]»[7].
Il problema della moltitudine è infatti
il suo assoggettamento al capitale, ciò che rende la sua condizione
poietica, ma non ancora “auto-poietica”, e che allo stesso tempo
mantiene il Comune ancora al di qua di un “fare comune”, ancora
nell'abito di un prodotto dell'azione piuttosto che nell'azione stessa.
Terza questione: cosa rende la
moltitudine un soggetto politico? L'organizzazione.
Organizzarsi politicamente per la
moltitudine, che è sempre un assemblaggio di differenti movimenti di
oppressi a diverso titolo, significa innanzitutto lottare per la propria
soppressione.
Se l'identità non esiste, la lotta non
può essere in nome di un'identità, dato che questa si trasforma
inevitabilmente in una difesa della
proprietà di una certa identità.
La soppressione dell'identità come fine
della lotta recupera in pieno l'obiettivo marxista della soppressione
delle classi, mediante l'estinzione dello stato e l'eliminazione della
proprietà privata. Gli autori chiariscono la linea di demarcazione fra
una politica rivoluzionaria ed una politica non rivoluzionaria
attraverso la differenza fra “liberazione” ed “emancipazione”
stigmatizzando tutte le tendenze volte al semplice
«ottenimento di migliori
condizioni di lavoro, salari più alti, migliori servizi sociali, una più
larga rappresentanza nei parlamenti […] e perfino un certo grado di
emancipazione, ma solo a condizione di conservare l'identità di
lavoratori ed operai»[8].
Una politica rivoluzionaria non può conservare una separazione di ruoli
sociali, che è una differenziazione delle parti e una classificazione
delle identità. Di passata gli autori fanno notare come la difesa ad
oltranza delle identità costituisca in nuce la sconfitta, ad esempio,
dei movimenti di genere e antirazziali ogni qualvolta questi non
assumano l'obiettivo del superamento dell'identità di genere o di quella
razziale, come la finalità del loro moto. Non è inutile sottolineare che
il superamento dell'identità non va interpretato come un'uniformazione
sociale (tutti proletari o tutti borghesi), ma esattamente all'opposto
come la liberazione delle singolarità e delle diversità, alle quali
proprio la concezione dell'identità come un'unità non riconosce nessuno
statuto di esistenza.
«Le identità possono essere emancipate,
ma solo le singolarità possono liberare se stesse»… Ci tocca perdere
quello che siamo per guadagnare quello che possiamo diventare»
[9].
Quarta questione: le istituzioni della
democrazia rivoluzionaria.
Se l'identità non esiste essa non può
essere rappresentata politicamente, né dall'esterno, né dall'interno.
«Il nesso tra diritti ed identità è
un'arma dello schema rappresentativo per catturare tutte le identità in
una logica del riconoscimento e per sorvegliare il divenire delle
singolarità»[10].
Ne consegue che le istituzioni della
democrazia rivoluzionaria non possono in alcun modo basarsi sull'istituto
della rappresentanza.
«La libertà e l'uguaglianza chiamano in
causa la democrazia in contrapposizione alla rappresentanza politica. A
questo riguardo ci sono due istanze della rappresentanza […]. La prima
imponeva la costruzione della categoria del popolo sul presupposto
dell'esclusione della moltitudine. […], un popolo non è una formazione
spontanea o naturale, ma è costituito da meccanismi rappresentativi che
traducono la pluralità e l'eterogeneità delle singolarità in un'unità
tramite l'identificazione con un leader, un gruppo dominante o in certi
caso con un ideale. La seconda istanza rappresentativa, concernente in
particolare il livello costituzionale, opera una sintesi disgiuntiva tra
i rappresentanti e i rappresentati. […] La separazione tra rappresentati
e rappresentanti costituisce una delle pietre angolari del potere. In
entrambe queste istanze, la logica della rappresentanza detta che un
popolo esiste solo ed esclusivamente in relazione alla sua leadership e
viceversa. Questo artificio fonda una forma di governo aristocratico e
per nulla democratico e questo anche se il popolo elegge l'aristocrazia.
[…]»[11].
L'istituzione rivoluzionaria non sarà
mai statica, ma in continuo divenire, aperta permanentemente al
conflitto e agita in prima persona dalla moltitudine, realizzando in
questo modo la democrazia viva, in nome del
fare comune e in opposizione tanto al privato, quanto al pubblico,
vale a dire alla mediazione politica esterna e professionale. Se
l'opposizione al privato è scontata, importanza fondamentale assume
proprio la contestuale opposizione al pubblico, in quanto è questa a
fondare l'istanza “abolizionista”
dello Stato (lo stato deve essere abolito).
«La moltitudine ha interesse a mettere
le mani sugli apparati di stato solo per smantellarli»[12]
L'autonomia organizzativa come auto-poiesi della moltitudine e del
lavoro biopolitico sarà ad un tempo capacità produttiva e autogestione
politica.
«La democrazia dei produttori, oltre che
dall'uguaglianza e dalla libertà, deve essere corredata da un elemento
ancora più determinante: il potere di decidere l'organizzazione
produttiva, le forme della cooperazione, e della comunicazione e di
stimolare l'innovazione»[13].
La democrazia è lo strumento
dell'auto-poiesi della moltitudine, essa nella sua realizzazione è ad un
tempo mezzo e fine dell'azione rivoluzionaria. La democrazia non è un
istituto, essa è un fare, un atto sempre da rinnovare, in una parola una
prassi che dal fare si innerva
nel sociale informando la vita e le sue modalità organizzative.
«Nella pratica politica […] l'unico modo
per imparare è fare. […] La democrazia non è lo scopo di una moltitudine
che disporrebbe dei poteri necessari per autogovernarsi, ma uno
strumentario formativo, un dispositivo per espandere quei poteri, per
formare non solo la capacità, ma anche il desiderio di partecipare al
potere»[14].
Quinta questione: un governo del
divenire in permanenza. Il futuro ha i piedi nel presente
Lo stato nazionale non è più l'unica
forma di potere istituzionale (così come il lavoro salariato non è più
l'unica forma di produzione della ricchezza). Esso tuttavia permane
accanto a nuove forme di potere, continuando a fondare la radice della
follia capitalistica. Se le tesi imperiali volessero significare l'inutilità dell'attenzione verso lo
stato nazionale, non sarebbe necessario sostenere il suo abbattimento.
Invece l'analisi delle forme di potere sovra e sub nazionali torna utile
a sostegno della possibilità concreta di una nuova forma di autogestione
del potere fondata sul permanente divenire e sul conflitto. Negri ed
Hardt fanno notare come le dinamiche di controllo del biopotere da tempo
non hanno bisogno di stabilità per esercitare il proprio dominio. Il
nuovo disordine mondiale post-ideologico, da tempo si concretizza in
concentrazioni di potere “aristocratiche” non elette direttamente da
nessun elettorato nazionale, quindi del tutto svincolate persino
dall'istituto della rappresentanza che, a tutti i livelli, condizionano
le politiche nazionali ed internazionali. Questa evidenza caratterizza
l'attuale fase del dominio del capitale, che si svincola dal concetto di
governo democratico, in favore del concetto di “governance”
post-democratica. Il potere post-democratico si basa su una
“distribuzione di poteri” a tutti i livelli.
«La governance non ha alcun bisogno di
stabilità e regolarità per esercitare il potere dato che è assegnata
alla gestione delle crisi ed è chiamata a intervenire su uno stato di
eccezione permanente»[15]
Allora se il lavoro biopolitico è già
abituato a creare le condizioni per la propria esistenza e quindi per la
produzione, la governance rappresenta un metodo efficace già in opera
per gestire la complessità del mondo, a patto di sovvertirne la
declinazione imperiale per trasformarla nell'organo della democrazia e
della rivoluzione.
Sesta questione: alcuni elementi di un
moderno programma di transizione
1.
Accesso cognitivo. Fondato sulla convinzione che
è la cultura che forma le ossa,
il comune va inteso anche in termini di conoscenza. L'accesso al comune
inteso come insieme di cognizioni, saperi e connettività sociale è
indispensabile per la lotta contro la miseria intesa come
«la condizione che ci costringe ad essere separati da ciò che possiamo
fare, e soprattutto, da ciò che possiamo diventare»[16].
Nel concreto ciò significa: libero accesso alle reti comunicative,
protocolli e codici sorgente aperti, opere e ricerche scientifiche a
disposizione di tutti.
2.
Tempo. Senza liberare tempo dal lavoro coatto non è possibile né
partecipare alla vita sociale, stringendo relazioni e scambiando
informazioni, né avere la forza fisica di farlo. Tutta l'energia dei
singoli è assorbita nel lavoro, quindi l'istituzione di un
reddito minimo garantito su scala globale è contemporaneamente ciò
che permetterebbe una riserva di energie utili ad essere impiegate
(socio-politicamente) all'esterno del lavoro, e ciò che permetterebbe il
necessario “rifiuto del lavoro” coatto, soprattutto quando esso si
configura come precario ed indegno per l'uomo. Senza questo la
moltitudine è sempre ricattabile e impossibilitata a mettere in atto l'esodo dalla repubblica.
3.
Autonomia. Permettere a tutti di partecipare alla vita politica
equivale a rifiutare qualsiasi forma di gerarchia socio-professionale e
quindi qualsiasi delega politica a mediazioni professionali separate.
4.
Proprietà comune. La proprietà privata è il principale ostacolo per
la realizzazione autonoma del comune. Essa va abolita tanto nella forma
della proprietà privata dei mezzi di produzione quanto nella forma, ad
esempio, dei diritti d'autore sulla produzione intellettuale, tutte
declinazioni di un'appropriazione indebita di ricchezza generata in
comune.
Con quanto detto si declina qualsiasi
pretesa di esaustività dell'opera, invitando senz'altro alla sua lettura
diretta.
APRILE 2011
[1]
«Nel marxismo e nella
storia del comunismo rivoluzionario, che rappresentano i
principali punti di riferimento del nostro lavoro, il processo
rivoluzionario è inteso come un evento che accade innanzitutto,
sul terreno della produzione economica. Oggi, anche per chi non
intende rinunciare a questi riferimenti, la prospettiva
dell'azione rivoluzionaria è iscritta nell'orizzonte
biopolitico». M.
Hardt, T. Negri. Il Comune, oltre il privato e il pubblico.
Rizzoli 2010, pag. 242
[2]
«A un livello
esclusivamente concettuale, possiamo iniziare a definire il
comunismo in questo modo: ciò che la categoria del privato è per
il capitalismo e ciò che la categoria del pubblico è per il
socialismo, la categoria del comune è per il comunismo». Ibidem,
pag. 275
[3]
Ibidem, pag. 361
[4]
Ibidem, pag. 351
[5]
Cfr. Alessandro D'Aloia, Storia e (in)coscienza di classe, in Città Future 02
[6]
Cfr. G. Deleuze e F. Guattari.
L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia. 1972
[7]
M. Hardt, T. Negri. Il
Comune, oltre il privato e il pubblico. Rizzoli 2010, pagg.
248, 249.
[8]
Ibidem, pag. 331
[9]
Ibidem, pag. 337
[10]
Ibidem, pag. 345
[11]
Ibidem, pagg. 304, 305
[12]
Ibidem, pag. 353
[13]
Ibidem, pag. 305
[14]
Ibidem, pag. 375
[15]
Ibidem, pag. 370
[16]
Ibidem, pag. 378