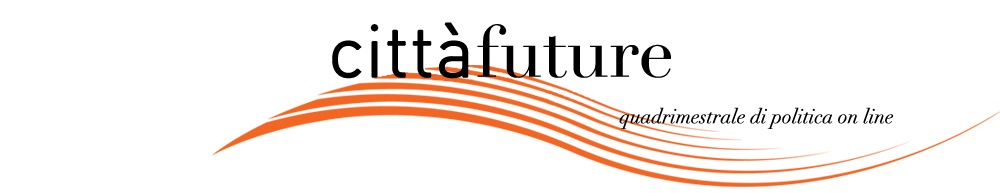
Maggio 2011
home - indice
Recensioni
LA ROULETTE DEL
CAPITALISMO
Luigi Bergantino
Nell’introduzione del volume dello
storico Lucio Villari, edito da Einaudi nel 1995, si ricorda
un’intervista di John Kenneth Galbraith del 1993 pubblicata su di un
quotidiano italiano: «Dobbiamo
riconoscere che il capitalismo, come tutti i sistemi, cambia. Abbiamo
più da temere ora dalla sua incapacità di quanto non si abbia da temere
dalla sua autorità e dal suo potere […] Non sono mai stato tanto colpito
dal capitale finanziario quanto, col passare degli anni, dalla sua
mancanza di intelligenza e, a volte, dalla sua stupidità. Quando ero
giovane mi preoccupavo molto del potere delle grandi società
capitaliste. Adesso mi preoccupo della loro incompetenza».
Al di là della leggera ironia tipica di
Galbraith, emergono chiaramente, in queste parole, dei concetti
fondamentali: il capitalismo è una formazione storica e, in quanto tale,
cambia; nella fase attuale, preceduta dalla fase dell’accentramento del
potere nelle grandi corporation, il maggior pericolo deriva dal
fatto che questo immenso potere, inseguendo unicamente un valore
disumano come il profitto, si è posto fuori dall’umanità, fino a
diventare “stupido”. L’avidità ha consumato anche quel particolare,
deviato tipo di intelligenza che le ha permesso di svilupparsi tanto.
In questo breve scritto ho concentrato
l’attenzione sulla svolta storica chiamata taylorismo: il culmine
«di quel processo storico di
identificazione tra capitalismo, razionalità e scienza che molto servì
all’ampliamento dell’egemonia politica e sociale della borghesia».
Non è niente di originale, ma ho scelto
di riportarlo ugualmente con l’idea di esporre la prima parte della
ricostruzione di un processo – quello economico degli ultimi 140 anni –
che oggi sembra giunto nei pressi di un ulteriore fase di svolta. Non ho
fatto altro che attingere a piene mani dal bel libro di Lucio Villari,
tralasciando, per il momento, la seconda parte delle suggestioni
fornitemi dall’intervista di Galbreith – sull’istupidimento del potere
economico – per limitarmi ad esporre i passaggi di un momento di grandi
cambiamenti interni al capitalismo.
Uno dei capitoli del libro di Villari è
intitolato al famoso ingegnere Taylor:
«Le ragioni della Macchina».
Subito si entra nel tema accennando a queste “ragioni”:
«A metà Ottocento era maturata nella borghesia americana quella tipica
mentalità (una vera ideologia) che vedeva nel consumo di beni
industriali e di servizi la condizione prima del progresso materiale e
spirituale dell’umanità».
Subito dopo si riporta l’emblematico
esempio di un messaggio di augurio che il
«romanziere Mark Twain» invia
al «poeta Walt Whitman per il suo
compleanno, congratulandosi con lui perché era vissuto in un’epoca così
ricca di benefici materiali, compresi “gli stupefacenti, infinitamente
vari e innumerevoli prodotti del catrame”. Se Whitman – continua Villari
– fosse stato cittadino europeo ci si sarebbe congratulati con lui per
l’altezza della sua poesia e non per essere questa poesia contemporanea
dei derivati del petrolio». Queste parole si potrebbero interpretare
come una battuta umoristica non troppo felice dello scrittore americano,
se non fosse accompagnata dalla riflessione di un ingegnere che nel 1888
così commentava il sistema economico americano
«che gli si trasformava sotto gli
occhi»: «I grandi mercanti, i
grandi fabbricanti, i grandi inventori, non hanno fatto forse per il
mondo più di tutti i predicatori e filantropi? […] La storia e
l’esperienza dimostrano che quando la ricchezza è stata accumulata e le
cose costano meno, gli uomini migliorano nel modo di pensare,
nell’atteggiamento verso gli altri, nelle idee di giustizia nonché di
misericordia. Prima bisogna che ci sia il progresso materiale e su
questo si fondano tutti gli altri progressi».
Tutto questo viene portato dall’autore
come una testimonianza «di una onesta attitudine intellettuale della borghesia americana verso
l’uso socializzato della ricchezza». È su questa attitudine positiva
che poi germinò «una visione
puramente tecnica delle attività economiche nella quale possono
identificarsi le premesse teoriche dell’organizzazione scientifica del
lavoro e della produzione venute alla luce negli Stati Uniti alla fine
degli anni ’80 [dell'Ottocento]».
Da qui nasce, quindi, l’importanza prima
e il dominio poi del tecnico anche sull’economico. Negli ultimi tre
decenni dell’Ottocento gli Stati Uniti devono fronteggiare una disparità
grave e crescente tra la geometrica ascesa dei volumi di produzione e la
capacità di assorbimento della «normale domanda di mercato». Le cause di questo squilibrio erano
individuate negli «alti costi di
produzione» e nell’«inefficiente
o inadeguato controllo e distribuzione della produzione». Il ruolo
dei tecnici e degli ingegneri, che in quel momento si affacciavano
dall’Accademia, fu immediatamente compreso dagli industriali americani
con tutto il suo carico di opportunità ed utilità anche, ma chiaramente
non solo, nell’abbattere il livello crescente di conflittualità tra
lavoratori e imprenditori passato alla storia come
«il periodo eroico della lotta
sindacale negli Stati Uniti».
«Fu appunto un industriale, Henry Towne
(proprietario della Yele and Towne Manifacturing Company), a presentare
all’American Society Mechanical Engineers una memoria dal titolo “L’ingegnere
come economista” nella quale si auspicava un interessamento dei
tecnici della produzione ai problemi di gestione delle imprese e
all’aspetto economico del loro lavoro. […] Il programma era troppo
ambizioso e affascinante perché i tecnici non lo facessero proprio.
Secondo Georges Friedmann, questi ingegneri, “pieni di sincera buona
volontà, immaginavano di poter tranquillamente sovrapporre al caos del
loro tempo un ordine quasi matematico, superare mediante un incessante
sviluppo del rendimento i conflitti tra padroni e operai, e portare così
il successo della ‘scienza industriale’ allo stesso livello dei trionfi
delle scienze meccaniche”».
È in questo contesto che compare la
figura di Frederik Winslow Taylor. Quest’ingegnere si inserì nel
dibattito del momento che verteva sul perfezionamento del sistema del
cottimo al fine di garantire al lavoratore un salario soddisfacente
ottenendo in cambio una buona prestazione lavorativa. Il problema era
urgente perché si rischiava di giungere ad uno squilibrio insostenibile,
a causa della crescente meccanizzazione, tra investimenti
imprenditoriale (in strutture, macchine, ecc.) e rapporto tra numero di
impieghi (in aumento) e profitti (che erano in stasi o regresso). Il
pericolo quindi era che scattasse
«il temuto ordigno della caduta del saggio di profitto».
Fu per sfuggire a questa contraddizione
che si concentrò tutta l’attenzione nel tentativo – poi riuscito – di
estrarre da una nuova organizzazione del lavoro una
«fonte autonoma di plusvalore che
si trasformasse immediatamente in profitto». Certo ci sarebbero
state le vecchie vie della prima rivoluzione industriale, dello
sfruttamento diretto del lavoratore attraverso l’aumento delle ore di
lavoro, ma questa, insieme alla via fin lì seguita dei bassi salari,
erano, in quel momento negli Stati Uniti, impraticabili. Il momento
tecnico sembrava l’unico àmbito sul quale lavorare per tenere insieme
tutte queste esigenze e viaggiare verso una produzione sempre crescente
di beni di consumo a basso costo.
Il programma prevedeva, nelle sue linee
essenziali, da un lato la definizione di quanto l’operaio produceva e,
soprattutto, di quanto avrebbe potuto effettivamente produrre;
dall’altro l’eliminazione dell’«attività
intellettuale […] dall’officina» per concentrarla
«nell’ufficio programmazione» (Taylor).
Per “eliminazione dell’attività
intellettuale” come presupposto dell’efficienza dell’azienda, ci si
riferiva non soltanto all’eliminazione della
«partecipazione attiva del
lavoratore con la sua intelligenza e fantasia artigianale alla
confezione degli oggetti», ma all’eliminazione della presenza
stessa di questa attività.
La teoria di Taylor rappresentò proprio
l’«anello mancante della nuova
impresa capitalistica» e un momento
«particolarmente qualificante
della storia del modo di produzione capitalistico» che Antonio
Gramsci definì come «“il maggior
sforzo collettivo verificatosi finora per creare, con rapidità inaudita
e con una coscienza del fine mai vista nella storia, un tipo nuovo di
lavoratore e di uomo”».
L’economista e sociologo americano
Thorstein Vablen nella sua Teoria dell’impresa (1904) ci offre le
ragioni aziendali per giudicare in questo modo il taylorismo, scrivendo
che «“La standardizzazione dei
processi, dei prodotti, dei servizi e dei
consumatori industriali,
facilita enormemente il lavoro dell’uomo d’affari nella riorganizzazione
delle imprese su scala più vasta [:] consente di uniformare il lavoro di
contabilità, di fatturazione, di stipulazione dei contratti, eccetera”».
Questa standardizzazione è ben lungi dal riguardare solo la semplice
modalità di lavoro dell’operaio nella fabbrica ma investì – come scrive
Taylor nel 1903 – «“tutte le
classi sociali”».
Non sono mancate le previsioni
ottimistiche degli esiti socialisti che “probabilmente” questa
standardizzazione avrebbe, con buone probabilità, generato (Veblen,
Lenin), sottovalutando il dato generale del non determinismo della
storia e il dato particolare dell’«ambiguità
di fondo» di questo sistema,
facilmente assoggettabile alla logica del profitto, ma del tutto
inefficace al governo di quest’ultima. L’inchiesta condotta negli
Stati Uniti (pubblicata nel 1921) per
«imporre l’adozione del taylorismo
a tutte le attività produttive del paese» rivelò che lo spreco
(inteso come il non raggiungimento dei massimi possibili di rendimento e
di efficienza) «era dovuto dal 50
all’81 per cento alla direzione delle imprese e solo dal 9 al 28 per
cento alla forza lavoro. Ma […] proprio nei settori chiave della
produzione industriale americana […] il peso del taylorismo era gravato
quasi esclusivamente sulla forza lavoro poiché tali industrie si erano
enormemente sviluppate nonostante che ai
managers
spettasse la responsabilità della maggior parte degli sprechi».
La maggior parte degli industriali –
complice la partecipazione degli Stati Uniti alla Prima guerra mondiale
– interpretarono a modo loro la razionalizzazione.
MAGGIO 2011