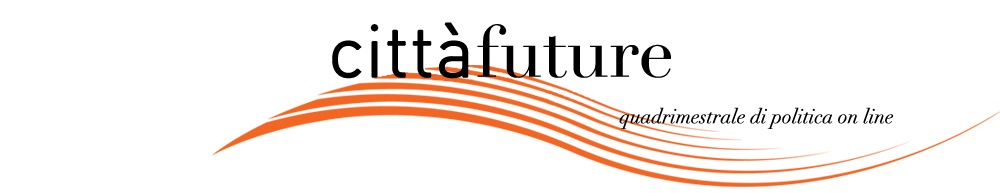La città dell'uomo
FALSE CITTA'
Alessandro D’Aloia
Introduzione.
Polis o agglomerazione?
Nessun discorso intorno alla città potrà
mai ritenersi definitivo e molti ne sono possibili. In questo scritto la
città è intesa come prodotto materiale,
e ad un tempo collettivo, della vita sociale, quadro generale
dell'esistenza.
Quest’idea di città come manufatto
collettivo è però in fortissima crisi, dal momento che essa non sembra
più configurarsi come opera comune,
ma come prodotto di pochi per la vita di molti. Chi costruisce la città
nel tempo è una domanda che ha molto a che vedere con la sua qualità,
con la sua capacità di essere uno spazio di libertà o, al contrario, uno
spazio del controllo.
La rottura del nesso, storicamente
esistente, fra cittadini-abitanti e costruzione del proprio spazio
urbano, è uno dei principali, anche se generalmente sottovalutati,
motivi della crisi della città, soprattutto quella vissuta (e non quella
delle riviste patinate) che nel proprio degrado crescente materializza
il segno di una ricchezza accumulata del tutto "fuori luogo".
Fra le analisi possibili della rottura
di questo nesso, si propongono due punti di vista, e alcuni loro
elementi, concettualmente separati ma concretamente relazionati, due
dimensioni tra loro inscindibili nell’esperienza che l’ambiente urbano
costituisce: lo spazio e
il tempo della città.
Uno spazio qualsiasi slegato
dall'esperienza è spazio archeologico, vale a dire morto e senza tempo.
La convinzione è che pur essendo la
città sostanzialmente un fenomeno spaziale, la sua esperienza e le
ricadute di questa sulla vita, non possono essere considerate astraendo
dalla dimensione temporale, intesa da un lato come storia delle forme
spaziali, ma dall’altro anche, e soprattutto, come risorsa sociale, che
nella sua disponibilità o indisponibilità detta, in ultima istanza, la
domanda circa la varietà delle tipologie di elementi urbani che la
società immagina per se stessa. In questo senso la ricchezza o la
povertà di spazi urbani, di cui la città si costituisce, risponde
direttamente alla ricchezza o povertà di tempo sociale dedicato
all’abitare, inteso in senso lato e non come la funzione precipua
dell’abitazione. La persuasione è infatti che la città dovrebbe
configurarsi come il luogo
dell’abitare quanto e di più dell’abitazione stessa.
Allora gli elementi di crisi della
città, quale materializzazione spaziale del tempo collettivo, sono da
indagare in quei condizionamenti che da un lato non permettono la
liberazione della forma nello spazio, dall’altro non permettono un
rapporto temporale equilibrato tra la struttura urbana e suoi
utilizzatori.
Il tempo considerato come risorsa, è il
dato immateriale la cui disponibilità, può essere in grado di cambiare
il rapporto dell'uomo con il proprio ambiente materiale e di
de-specializzare l'interesse collettivo verso quest'ultimo. Concepire,
al contrario, la questione urbana come completamente risolvibile
all'interno del solo dato spaziale, produce un effetto anodino per il
quale la forma dello spazio è percepita come un problema secondario,
estetico, di interesse accademico, riservato agli amanti di forme vuote.
Da qui anche una sostanziale
indifferenza della maggioranza della società riguardo gli esiti concreti
dell’involuzione spaziale del costruito, sempre più in preda ad un
dilagare del brutto e la convinzione conseguente, certamente fondata ma
nondimeno fraintesa, che tutto ciò che è bello non può che appartenere
al passato. Vedremo perché fondata, fraintesa perché ogni epoca produce
una propria forma, la quale non può in nessun modo essere
decontestualizzata temporalmente senza diventare immediatamente assurda.
Ogni epoca ha le forme che si merita.
Non sembrerà pazzesco allora sostenere
che la qualità della forma dello spazio, dipende sostanzialmente dalla
quantità di tempo che la vita recupera per se stessa. In quest’ottica il
problema della città, o del recupero del suo carattere positivo, più che
essere un tema da "esperti della forma" rappresenta un interesse che non
è possibile immaginare come indipendente dal più generale discorso sulla
democrazia e la cultura che quest'ultima è in grado di generare. Ma
questo non vuole significare in nessun modo che sia necessario affidarsi
agli "esperti della politica" in luogo di quelli della forma (meglio i
secondi che i primi a questo punto), semplicemente che si ammette che la
falsa città è il riflesso
materiale della falsa democrazia.
La
polis, dal quale deriva il termine "politica", stava, all'origine,
proprio a designare la città, quasi che i due fenomeni siano tra loro
inscindibili e interdipendenti. Una città in cui il rapporto fra
politica e fatti urbani sia, come avviene oggi, così drasticamente
negato, rappresenta una vera e propria contraddizione in termini. Se
anticamente la città è considerata quale "unità elementare" della
politica, pensare che essa possa darsi in una dimensione astratta dalla
partecipazione cittadina verso i fenomeni che la riguardano, significa
ammettere che la politica non riguarda l’esistenza materiale delle
persone e che queste debbano accettare una sua pratica implicante
l’indifferenza verso tutto ciò che da più vicino le coinvolge. Come non
notare che nella polis vigeva una sorta di ignoranza della separazione
fra governati e governanti[1] e che all’affermarsi
e al crescere di questa dicotomia nel tempo, si afferma e cresce la
separazione fra chi costruisce la città e chi la vive? Se la democrazia
è impensabile senza un tempo sociale della partecipazione attiva e
diretta, allo stesso modo lo è lo spazio urbano e dunque non si potrà
parlare di riappropriazione della città, del suo senso civile e della
sua esperienza collettiva, senza legare questa necessità a quella più
generale della riappropriazione della politica. Infine bisogna
considerare che la città, in quanto habitat dell’uomo, rappresenta
l’ambito in cui materialmente la coscienza può e deve misurare la
relazione reale fra politica e vita quotidiana, unica in grado di legare
in modo visibile cause ed effetti delle scelte politiche e perciò di
formare esperienza concreta di azione politica. Una politica di parole
mostra bene i suoi fatti, nella falsa città che produce. La città è
sempre politica pietrificata[2].
Tuttavia, come già si accennava,
l’ostacolo al recupero del significato positivo della città è duplice ed
operante in entrambe le dimensioni che ne formano l’esperienza,
cerchiamo di focalizzare alcuni elementi che impediscono una relazione
feconda fra l'attività umana e il suo ambiente.
1. Vincoli alla forma dello spazio
1.1 Il suolo e la sua storia dimenticata
È forse il caso di rispolverare
velocemente alcune questioni di "archeologia" politica, passate nel
dibattito veterocomunista della politica che fu, partendo dall'origine.
Al primo punto programmatico del
Manifesto del partito comunista compare “l’esproprio della proprietà
fondiaria e l’impiego della terra per le spese dello Stato”.
Tale punto, non necessita per gli autori
del Manifesto di particolari spiegazioni, esso è quasi scontato, una
sorta di premessa al cambiamento materiale dell’esistenza umana oltre il
capitalismo.
La cosa, suona anche un po’ strana, dato
che la terra, e i problemi della rendita fondiaria, sembrano infatti
appartenere alle epoche precedenti lo sviluppo capitalistico e pertanto
non essere elementi, in fondo, così importanti per l'esito della
transizione verso il comunismo. Forse per questo motivo nella successiva
storia dell'ideologia comunista (quella dei partiti), quando si parla di
esproprio, se ne parla quasi esclusivamente in riferimento ai mezzi di
produzione, come se l'unica preoccupazione vera sia soltanto quella di
impedire la principale fonte di estorsione del lavoro, il
plusprodotto derivante dal
meccanismo del plusvalore, per altro nuova forma di estorsione specifica
(ed automatica) del capitalismo come sistema economico. Ne deriva una
curiosa convinzione, per la quale basta negare al capitale la proprietà
dei mezzi di produzione per realizzare un programma rivoluzionario,
mentre si può sorvolare sull'eterno diritto dei privati di pretendere
rendite derivanti dalla proprietà dei suoli (che è la proprietà
certificata di una porzione del globo terrestre).
Se a questo si somma che l’avvento delle
varie "riforme agrarie", di stampo borghese, sembra aver risolto
definitivamente il problema della democratizzazione del suolo, sembra
chiaro che è del tutto superfluo parlarne.
Osservando però la "città" attuale,
sostanzialmente il più formidabile amplificatore conosciuto della
rendita fondiaria, si notano i medesimi problemi (ad esempio la penuria
di abitazioni accessibili a fronte dell'abbondanza di costruito)
enumerati da Engels nel suo La
questione delle abitazioni e non si capisce come mai su questo
punto, e non solo, non si sia fatto nessun passo avanti (allo stesso
modo di come non si riesce ad eliminare mai la disoccupazione). Anzi ad
una lettura più attenta si osserva come nonostante sia oggi (quasi)
realizzato lo scenario immaginato da Proudhon (il referente delle
critiche di Engels), anche se per vie differenti, ovvero la diffusione
(socializzazione) della proprietà della casa di abitazione (e della
terra su cui essa sorge), questo fatto non abbia sortito nessuna
soluzione ai problemi che attanagliano le condizioni dell'abitare
dell'epoca capitalistica.
L'Italia è, per molti versi, un punto di
osservazione privilegiato sulla questione, essendo uno dei paesi europei
con il più alto rapporto di vani costruiti rispetto alla popolazione
residente e uno dei paesi con la più alta diffusione di case di
proprietà[3], ma allo stesso
tempo uno dei paesi dove la pianificazione urbanistica è per lo più
disciplina accademica senza applicazione pratica. Come ha potuto il bel
paese, culla di cultura e di arte in tutti gli ambiti, (e modello
storico di pianificazione urbanistica) trasformarsi nello scempio
territoriale che abbiamo sotto gli occhi? Cosa è intervenuto nel
frattempo fra la città storica e la sua attuale negazione? Cosa si
oppone strenuamente ad ogni tentativo di ragionare attorno alla forma da
dare allo sviluppo urbano? Non sarà forse proprio l'immenso,
indistricabile garbuglio multistrato della proprietà diffusa?
Se Engels è contro la formazione di una
classe reazionaria di piccoli possidenti[4], significa che egli
prende in considerazione la mutazione sociologica che la proprietà
privata è in grado di innescare, e tanto gli basta per decidere
nettamente contro di essa, senza neanche voler considerare l'aspetto di
vincolo di conformazione che la proprietà rappresenta per le possibilità
di espansione del fenomeno urbano in sé e del significato che questo può
avere sul destino della città materiale.
Il grosso equivoco, di considerare
"democrazia" la spartizione particellare del globo, ha però un proprio
“nobile” conforto. Le cosiddette “riforme agrarie” non sono state
infatti solo il normale modo di procedere nelle diverse “rivoluzioni”
borghesi, ma anche quello affermatosi nell’esempio della prima
rivoluzione proletaria. Gli stessi bolscevichi, durante la Rivoluzione
d'Ottobre, pensarono, per ragioni di ordine tattico, di distribuire la
terra ai contadini, invece che tenerla in capo allo Stato per
pianificarne l'utilizzo, come notato in seguito dallo spirito critico di
Rosa Luxemburg, la quale, riprendendo in gran parte le osservazioni di
Engels sul potere della proprietà privata di mutare geneticamente lo
spirito rivoluzionario delle masse, separava l’opportunità tattica della
mossa bolscevica, dalla sua opportunità rivoluzionaria[5].
Se una necessità storica contingente ha
finito, da un lato, per determinare un decorso della rivoluzione
sovietica problematico, ha, dall'altro, generalizzato un approccio
positivo verso le cosiddette "riforme agrarie" di stampo borghese. Va
però detto che se la politica bolscevica sacrificò completamente la
sovranità statale sui terreni agricoli, essa si guardò bene
dall’applicare la medesima politica ai suoli urbani, operando dunque una
netta distinzione fra suoli urbani e extraurbani e fra suoli urbani
stessi a seconda che le città fossero superiori o inferiori alla
dimensione dei 10 mila abitanti[6].
In generale rispetto al problema della
terra, e per transizione, dei suoli urbani, l'occidente ha pensato
(parziale eccezion fatta per i bolscevichi) di risolvere la questione in
un modo del tutto univoco: la parcellizzazione infinita della proprietà
come unico modo di concepire la democratizzazione del dell'uso del globo
terrestre. In questo la visione del problema nell'ideologia dei partiti
comunisti occidentali si discosta poco o niente dalla visione dominante,
se negli anni '70 del secolo scorso Henri
Lefebvre, doveva ancora indagare la questione nei seguenti termini:
«Il radicalismo liberale (borghese) della
Belle Epoque si proponeva di
superare questi ostacoli alla crescita e allo sviluppo della società
ereditati dalla storia, e si proponeva di abolire la proprietà privata
del suolo, coltivabile o no. Pertanto, questo radicalismo mirava a
sopprimere, mediante l'azione politica, la vecchia classe dei
proprietari fondiari. Queste ambizioni, queste grandi intenzioni
politiche non sono state realizzate. La stessa rivoluzione francese si è
contentata di una "riforma agraria", la prima e una delle più ampie, che
si è tuttavia limitata a un trasferimento della proprietà (confisca dei
beni degli emigrati, acquisto di tali beni ad opera della borghesia in
piena ascesa).
Nel quadro della proprietà privata in generale, la proprietà
del suolo permane; sebbene abbia ceduto il passo di fronte a quella
mobiliare (il denaro, il capitale), la proprietà immobiliare permane;
anzi si consolida, rispetto all'epoca di Marx, giacché la borghesia
arricchita compra la terra e acquisisce una proprietà fondiaria (e
pertanto ricostituisce, sulla base di un nuovo monopolio, la proprietà
fondiaria e la rendita del suolo). La proprietà del suolo, rimasta
fondamentalmente intatta e ricostituita dal capitalismo,
pesa sull'insieme della società.
Il cordone ombelicale che legava la società alla natura è
stato tagliato male. Che cosa esigeva questo taglio e che cosa implicava
una rottura? La città. […] In particolare, anzi soprattutto,
subordinando il suolo al mercato,
facendo della terra un "bene" commerciabile legato al valore di scambio
e alla speculazione e non all'uso e al valore d'uso. Il cordone
ombelicale […], si è trasformato in una corda, in un legame arido e
duro, che impedisce i movimenti e gli sviluppi di questa comunità. Ne è
anzi l'ostacolo essenziale»[7].
In sostanza l'attuale assetto della
proprietà privata dei suoli, non è affatto un dato scontato o
“naturale”, ma la conseguenza di una rivoluzione borghese essa stessa
inconclusa, anzi "tradita", visto che è proprio nel passaggio tra
l'assetto proprietario feudale e quello capitalista, che la situazione
odierna si è venuta a creare, impedendo le stesse aspirazioni della
borghesia giacobina delle
origini.
Se tutto ciò riguarda la terra, è però
vero, che riguarda anche e soprattutto il mutamento storico del rapporto
dell'uomo con la terra e con ciò che su di essa sorge. Se per secoli
tale rapporto è stato sostanzialmente indifferente al problema della
proprietà, oggi esso è il risultato di un mutamento di interesse verso
la terra mediato dal possesso privato. L'interesse dell'uomo per la
terra non è più un interesse generale (verso la terra quale bene di
tutti), ma è tale solo in vista dello scopo finale del possesso
personale della stessa.
Questo rapporto, traslato in una
situazione urbana, si configura come un desiderio di possesso che
trasforma gli abitanti della città, nel migliore dei casi, in un insieme
coatto di proprietari, piuttosto che in cittadini. È una comunità
forzata (come quelle condominiali). E l'attuale assetto proprietario
maggioritario realizza una resistenza sociale a qualsiasi cambiamento in
favore della città, considerata nel suo complesso, generando una
mutazione genetica della categoria classica del "proletariato" e una
contraddizione irrisolvibile fra interesse collettivo e interesse
privato. Questi due interessi contrastanti non realizzano più una
disputa fra classi diverse, ma una disputa (interiorizzata) che
attraversa trasversalmente la maggioranza della popolazione di un paese,
indipendentemente dall’appartenenza di classe. Tutto ciò che di male
succede alla città e al territorio, seppure accade, è percepito come
qualcosa che non ci riguarda direttamente fino a quando non danneggia la
nostra proprietà, la quale dunque ci pone di fronte ad una
contraddizione insanabile fra il vettore privato e collettivo della
proprietà stessa. Tutti, ad esempio, trarrebbero vantaggio da più
parcheggi, più verde, più spazio pubblico ed attrezzature, meno
inquinamento e così via, ma tutto questo passa in secondo piano, se
significa sacrificare rendite di posizione dei propri fabbricati (o
anche solo della propria abitazione), perché in tal caso la maggiore
vivibilità urbana potrebbe favorire alcune proprietà a scapito di altre.
È evidente però che così ragionando nessun interesse collettivo, può
essere considerato come direttamente immanente al "proprio" interesse.
Più nello specifico del problema urbano,
è possibile, grazie all'opera dell'urbanista Hans Bernoulli, al cui
testo La città e il suolo urbano
si rimanda[8], delineare la
genealogia sia della proprietà privata dei suoli che della rendita
fondiaria e della trasformazione particolare di quest'ultima nel
contesto del mercato capitalista.
Vi è un'eclatante differenza, che
caratterizza nella città contemporanea, la sua parte storica, da quella
più recente. Ancora una volta l'Italia è un punto di osservazione
eccellente, per la particolare "caduta di stile" che si misura tra i
suoi centri storici (fra i più belli del mondo) e le sue informi
periferie. Nessun tipo di turismo culturale nazionale avrebbe senso in
presenza della sola parte recente delle città italiane. C'è una
differenza fra centro storico e tutto il resto, che non è semplicemente
la differenza fra vecchio e nuovo, ma una differenza fra modo di
concepire e costruire la città, nel passato e nel presente. L'Italia è
uno strano paese in cui ciò che di bello si è prodotto si è
materializzato prima che essa esistesse come Stato unitario.
Per Bernoulli la città medioevale (ma è
così anche per le città di fondazione antica, in epoca greco-romana, ad
esempio) sorgeva su suolo indiviso. Se la proprietà esisteva essa era del re e, per
transizione, del signore della città, era cioè quasi astratta. Ciò
faceva in modo che il terreno in generale fosse considerato, alla
stregua delle altre risorse naturali, come un
bene comune.
I fabbricati erano però privati, cioè
costruiti da chi li abitava su suolo non proprio, secondo le indicazioni
del "locator" (colui che delineava l'assetto concreto dell'impianto
urbano). Quindi il diritto urbanistico medioevale era un
diritto di superficie
(possibilità di costruire fabbricati privati su suolo comune),
contrapposto all'attuale diritto
di proprietà.
In poche parole la città medioevale,
nasceva dalla possibilità di una traduzione pratica dell'idea circa i
requisiti che essa deve possedere, al contrario di ciò che accade per la
"città" contemporanea frutto caotico della distribuzione della
proprietà, preesistente allo sviluppo urbano, senza relazione alcuna,
aderenza benché minima, ad una qualsiasi "concezione contemporanea"
della città. Ne deriva una quadro urbano contemporaneo
senza concetto e, in una
visione umanistica, è dubbio che questo possa definirsi
città[9].
Da Bernoulli in poi, il pensiero critico
sulla città ha sempre trattato il proprio oggetto come un fenomeno
specifico di un’epoca ormai passata. Per Lefebvre l’urbanesimo è
l’utopia del capitalismo, che per quanto costruisca non sarà mai in
grado di creare delle città. Per Vezio De Lucia l’interrogativo è:
Se questa è una città. Per
Mike Davis, parliamo di Città
morte. Per Stefano Boeri siamo di fronte a
L’anticittà. Per Francesco
Erbani e Leonardo Benevolo si tratta di elaborare
La fine della città, e altri
esempi si potrebbero fare. Sembra chiaro che il capitalismo come modo
costruttivo (modo di produzione edilizia), più che essere nemico
dell’urbanistica, si pone come negazione ontologica dell’oggetto stesso
dell’urbanistica.
Se la città è un organismo vivo, che
nasce e cresce, la proprietà privata dei suoli è come un'immensa rete
(griglia di striatura) a maglie troppo fitte, che strozzandola ne
impedisce uno sviluppo "naturale". La città è sotto scacco.
La proprietà privata dei suoli non è una
qualità metafisica, ma esiste con una sua struttura spaziale definita.
Ha una forma, che preesiste alla costruzione, cioè al divenire della
città, la quale ne è perciò condizionata. C'è, per questo, una
contraddizione insanabile fra città e proprietà privata che impone una
scelta: o l'una o l'altra.
1.2
La rendita fondiaria e la sua
fisionomia urbana
Ma cerchiamo di seguire, sempre con
l'aiuto di Bernoulli, la problematica della rendita fondiaria più da
vicino. In realtà essa esisteva nel Medioevo, ma in una forma del tutto
diversa da quella che assume con il mercato. La rendita era, in termini
urbani, il canone che gli abitanti pagavano per il diritto di superficie
al signore della città, che "rappresentava" la proprietà. La
caratteristica della rendita medioevale era del tutto diversa dalla sua
forma attuale, essa era immutabile, fissa e aveva un significato più
simbolico che altro, servendo a rimarcare la differenza fra abitanti
della città (diritto profano) e proprietario del suolo (diritto divino).
Fu infatti proprio la sua esiguità che fece nascere l'idea del riscatto
della proprietà del suolo da parte dei proprietari dei fabbricati. Con
il passare del tempo e il subentrare dei Comuni, che gestivano
pubblicamente le risorse collettive, e quindi con il venir meno del
diritto "divino" sulla proprietà del suolo, o se si vuole, con la
laicizzazione del problema, parve naturale che i proprietari dei
fabbricati si liberassero in un colpo del vincolo sovrano sui loro
fabbricati.[10]
In questo momento, senza che nessuno
fosse in grado di presagire le conseguenze colossali di tale "riscatto"
sul destino delle città e della società, si inverte del tutto il
rapporto fra pubblico e privato nella problematica urbana.
Dal riscatto della proprietà del suolo
su cui sorgevano i fabbricati, si giunge alla vendita dei "demani
pubblici" per far fronte ai debiti degli stati moderni. È infatti il
1808, quando su proposta di Adam Smith, in Germania viene varata una
finanziaria che autorizza il pubblico all'alienazione dei demani, pur
conservando un diritto su di essi attraverso l'imposizione di una tassa
che i privati erano ancora tenuti a versare, come durante il medioevo,
per lo sfruttamento dei terreni di origine pubblica. Nel 1850, in pieno
sviluppo del capitalismo, anche quest'ultimo vincolo venne eliminato.
Bernoulli riesce a ricostruire l'andamento delle rendite fondiarie di
tipo urbano in relazione alla città di Posen:
«Un esempio del come possa svilupparsi con l’andare degli anni la
rendita fondiaria di una città, lo può dare la città di Posen dove il
prezzo del territorio totale fabbricabile della città, fissato per
esempio col valore 1 al tempo della fondazione (1253), nel 1400 è già
3,5; nel 1.803 è 52; nel 1848 è 754; e nel 1910 è 2.713. Dalle cifre
surriportate si può dedurre che ogni cento anni il prezzo del terreno è
salito di quattro e anche sei volte, e che nel tempo in cui la
popolazione da circa 2.000 abitanti è aumentata a 150.000, il prezzo di
un metro quadrato, conteggiato per persona, segna un aumento da 1,65 a
1.083 marchi»[11].
Non è per niente inutile sottolineare come nonostante la rendita esistesse in epoca precapitalistica essa assume il suo andamento iperbolico esattamente in concomitanza con lo sviluppo del mercato capitalista. Per quanto dunque la rendita fondiaria venga trattata generalmente come un problema teorico non specifico del capitalismo, è proprio in questa fase storica che essa diviene un problema lungo lo sviluppo della città. È proprio in questa fase che essa assume un significato strutturale in un sistema economico che sembra invece alimentarsi esclusivamente d'altro. Infatti H. Lefebvre vede esattamente nella rendita fondiaria, il principale sistema di compensazione moderna della "legge della caduta tendenziale del saggio di profitto" nel processo produttivo[12]. Nessuno sviluppo iperbolico della rendita fondiaria poteva essere immaginabile in assenza del fenomeno di spostamento di massa delle persone dalla campagna alla città, indotto dalla rivoluzione industriale e dallo sviluppo del sistema capitalista maturo. In questo nuovo contesto la rendita fondiaria non è più un simbolico meccanismo del passato, ma uno strumento attualissimo di compensazione delle disfunzioni sistemiche[13]. L'inversione del rapporto pubblico-privato in accoppiata al meccanismo infernale della rendita fondiaria urbana, rappresenta la sostanziale impossibilità del pubblico di intervenire concretamente sulla città[14]. Non solo però tutto questo costituisce un vincolo privato al bene collettivo, del quale gli amministratori dovrebbero essere i rappresentanti, ma la speculazione fondiaria, comincia ad elaborare e sviluppare una propria forma urbana, che nega all'origine qualsiasi aderenza del costruito alle necessità stesse del costruire. Nella città di epoca borghese, si affermano concezioni costruttive il cui unico fine è quello di massimizzare le rendite. La costruzione non è più relativa al bisogno sociale di abitare, ma è, come tutto il resto, puro strumento di profitto. Essa non appartiene più all'uomo e perciò comincia a cambiare lentamente forma[15]. Basti pensare alla rivoluzione urbana hausmanniana, ai tagli diagonali dei preesistenti tessuti storici operati in tutte le ristrutturazioni urbanistiche di fine ottocento, di cui Parigi è modello, volte a creare nuove strade principali e miriadi di incroci, in cui con l'ideologia della salubrità sanitaria, si consentono ad un tempo la massimizzazione delle rendite e il controllo militare del territorio urbano. Gli assi stradali poi si riempiranno di traffico e inquinamento e le notti si accorceranno.
Ma l'altro
esempio eclatante è rappresentato dalla selva di grattacieli americani,
che se apparentemente sono il prodotto della tecnica dell'acciaio e del
cemento armato, in sostanza sono il risultato del costo spropositato
delle aree urbane centrali, che impongono la moltiplicazione infinita
dei piani, al fine di pietrificare una rendita che ripaghi
dell'investimento iniziale e dei costi di costruzione stellari,
realizzando il valore di scambio dell'area sulla quale sorgono.
Prima di chiudere questa seconda parte
sulla nascita e trasformazione della rendita fondiaria in ambito urbano,
sarebbe il caso di riflettere minimamente sulla legittimità della
stessa. In altri passi del testo di Bernoulli è descritto il modo
attraverso il quale, mediante opere pubbliche, viene gradualmente
assicurato l'intero territorio urbano alla morsa della rendita. La
deduzione generale è che i privati, in virtù della sola proprietà dei
suoli, si trovano a beneficiare di aumenti di prezzi, sui quali non
hanno in realtà alcun apporto attivo. In termini attuali, la rendita
costituisce la privatizzazione di esternalità positive del tutto
autonome rispetto ai beneficiari. E per questo la collettività, nel suo
insieme, porta interamente addosso il doppio peso del carattere
vincolistico della proprietà privata e del costo sociale del suo
mantenimento, del tutto ingiustificato sul piano della legittimità
economica, mentre lo diventa sul piano giuridico.
In termini spiccioli si pensi
all'enormità di questo peso, che economicamente può arrivare a
rappresentare anche il 40% del salario mensile di una famiglia
monoreddito e comunque è difficile che assorba, in media, meno del 25%
di un salario (1/4 di ciò che si guadagna). Se qualcuno pensava che "la
trattenuta", in termini di prodotti del suolo, che il padrone terriero
operava sul lavoro del contadino, fosse qualcosa di appartenente al
passato, come considerare invece la parte del proprio lavoro che
volontariamente si devolve al padrone di casa per avere un tetto? In
sostanza in rapporto al monoreddito, il fitto rappresenta una seconda
tassazione, anche più pesante di quella statale (un secondo e privato
"apparato di cattura" della ricchezza sociale), che rappresenta in
termini complessivi qualcosa come almeno 11,5-12 miliardi di Euro
all'anno[16].
La media nazionale delle case in proprietà scende notevolmente se si
considerano le grandi città e le fasce d'età sotto i 40 anni, come
salgono di molto le incidenze sul reddito netto dei costi per
l'abitazione. In città gli under quaranta che vivono in affitto
rappresentano il 47,5% del mercato dell'abitazione (quasi la metà) della
loro fascia d'età. E così si capisce anche da chi è costituito quel 30%
di popolazione che non possiede casa di proprietà: da giovani.[17]
Che dire, infine, della libertà di
scelta? In questa situazione è possibile ritenere che la scelta
dell'abitazione sia libera? Non si tratta piuttosto della libera scelta
dell'abitazione che costa meno? Non è questo il più potente zoning
sociale concepibile? Non siamo noi a scegliere la città, il quartiere,
la casa, ma esattamente il contrario. In questo modo, le classi abbienti
non hanno bisogno di nessuno sfratto violento degli indesiderati, la
città è un sistema auto-segregativo.
1.3 Diritto di proprietà o diritto di abitare?
Addentrandoci nelle vicende urbane più
vicine nello spazio e nel tempo, possiamo partire dal notare come in
Italia, la vera e propria esplosione del fenomeno urbano sia
sostanzialmente storia recente, grosso modo legata alla politica e alla
concezione del diritto urbanistico della seconda metà del '900. Alcuni
storici dell'urbanistica[18],
tendono a sottolineare la sostanziale differenza concettuale che separa
nettamente l'urbanistica fascista, da quella democristiana, confortata
dall'osservazione che fino al 1950 circa, l'estensione delle città
italiane non era molto maggiore di quella della loro porzione storica.
Gli stessi ampliamenti di epoca borghese, anteriori alle riforme
agrarie, avevano un carattere diverso da quelli posteriori alla infinita
parcellizzazione proprietaria. Così si ha che in Italia, per le vicende
storiche che hanno caratterizzato la vita nazionale, gli ultimi
detentori di una visione urbanistica (distorta ma complessiva) siano
stati i fascisti, mentre la democratizzazione repubblicana si è basata
in gran parte sulla rinuncia a qualsiasi idea circa lo sviluppo urbano
al di fuori dell'autoregolazione del mercato capitalista, secondo una
pura applicazione del pensiero liberista, rinunciatario e nichilista il
cui prodotto urbano è lo sprawl,
ovvero il dilagare amorfo in ogni direzione possibile di ammassi di
costruzioni private, che pretendono di realizzare l'urbanesimo mediante
la somma di fabbricati senza alcun nesso organico tra loro e senza
nessuna relazione, né formale e tantomeno produttiva (e feconda) con il
territorio circostante. Pura casualità cementificata, a costo di un
enorme sperpero di territorio, secondo un astratto e del tutto
irrealistico principio di illimitatezza, in nessun modo sostenibile,
tanto energeticamente, quanto socialmente. Lo
sprawl è la materializzazione
urbana del concetto di consumismo.
L'oggetto del consumo è il territorio. Lo stesso termine di origine
americana, denuncia come la cultura europea, ed italiana in modo
particolare, anziché fornire modelli di sviluppo urbani collaudati
storicamente, assorbe, americanizzandosi, disfunzioni in grado di
erodere ciò che resta della propria cultura millenaria e profondamente
urbana.
Le metropoli diventano grossi buchi neri
che assorbono persone ed energia, risucchiando il territorio circostante
(con il quale sono in conflitto e non in equilibrio), in un processo di
continuo accentramento di popolazione, che se da un lato si
iperconcentra in enormi ammassi disurbani, dall’altro svuota e
desertifica i centri minori e i loro territori, i quali si vengono a
trovare su una soglia di sussistenza molto prossima alla morte. Se la
diversità biologica è messa a dura prova dal sistema produttivo
capitalista, sul terreno dell’urbanesimo, è la varietà urbana ad essere
cancellata da questa tendenza infinita all’imperialismo
urbano delle grandi metropoli, non soltanto in termini di erosione
sociale dei piccoli centri, ma anche in termini di uniformità generale
nel modo di concepire la periferia globale, così simile in tutte le
città del mondo, al punto da rendere irriconoscibile un luogo urbano
qualsiasi a partire dalle sue forme insediative contemporanee. A partire
da una immagine di periferia, si ha sempre quella strana sensazione
familiare, di trovarsi a casa propria, in nessun luogo del mondo.
«Invece di un assorbimento e di una riassunzione della
campagna ad opera della città, e del superamento della loro
contrapposizione, si ha un deterioramento reciproco: la città esplode
nelle sue periferie e il villaggio si decompone; un incerto tessuto
urbano prolifera sull'intero paese. Il risultato è un magma informe:
bidonvilles, megalopoli. Per usare la terminologia di Marx, si ha la
minaccia di una ruralizzazione della città, che si sostituisce
all'urbanizzazione della campagna, come ai tempi del declino delle città
antiche».[19]
Nella prefazione di Antonio Cederna al
fondamentale testo di Vezio De Lucia,
Se questa è una città, si
sottolinea come l'Italia sia l'unico paese europeo a non essersi ancora
dotato di una legislazione sui suoli, in grado di permettere, al
pubblico, una moderna pianificazione urbanistica senza doversi svenare
per l'acquisto delle aree. Nel far notare come la ricostruzione
post-bellica sia stata condotta sospendendo, a causa dell'emergenza
post-bellica (non la guerra ma la riconquistata pace rappresenta
l'emergenza!), la legge urbanistica fondamentale (fascista) del 1942,
questa sì esistente in Italia (e prima che negli altri paesi), si fa
capire bene quale fosse l'aspetto più odiato di tale legge, che,
all'articolo 8, prevedeva lo strumento dell'esproprio generalizzato a
prezzi che non tenessero conto delle previsioni di piano e dunque senza
incremento di rendita privata derivante da scelte pubbliche. Il
risultato è stato quello per cui la ricostruzione post-bellica italiana
è avvenuta in completo stato emergenziale, a differenza che negli altri
paesi, dove essa è partita solo dopo la messa a punto di leggi
urbanistiche come guida per la ricostruzione. Senza entrare troppo nello
specifico della eroica (ma sconfitta) lotta dell'urbanistica
"riformatrice", basti dire, che in Italia si è costruito del tutto
allegramente fino al 1967, quando in seguito allo scandalo della frana
di Agrigento, si è deciso di regolamentare in qualche modo l'espansione
urbana delle città, ma a quel punto gran parte del danno era già stato
consumato.
Si dica che quello che l'urbanistica
riformatrice ha ottenuto di porre come problema è la separazione fra
diritto di proprietà e diritto di costruire, il primo
privato il secondo pubblico,
senza che questo però abbia significato qualcosa di più che permettere,
nel migliore dei casi, il controllo pubblico sull'attività dei privati,
senza cioè che questo abbia permesso al pubblico di decidere attivamente
ed effettivamente circa le sorti della città. In sostanza quello
che Bernoulli individua come un vincolo concreto ed internazionale alla
possibilità di pianificare, il prezzo dei suoli urbani, in Italia si
formalizza proprio come un'opposizione sancita giuridicamente in modo
molto rigido, in cui la possibilità di decidere lo sviluppo urbano non
può vincolare la proprietà privata per più di 5 anni. Non solo cioè, non
è né affrontato, né risolto, il problema del costo dei suoli urbani, ma
proprio imposto giuridicamente che il diritto proprietario privato è
intoccabile anche in presenza dell'interesse collettivo, laddove questo
non si realizzi in 5 anni, ma d’altra parte non si può da un lato
accettare la proprietà privata e dall’altro fare come se non ci fosse.
Al di là comunque delle vicende, anche
interessanti, dell'urbanistica riformatrice (si veda la questione del
progetto di legge urbanistica Sullo, ad esempio), ciò che colpisce è la
esasperata dialettica pubblico/privato, ma completamente interna al
diritto di proprietà. In sostanza l'intera concezione del diritto
urbanistico nazionale è basata sull'assunto che intanto si può parlare
di diritto di costruire, in
quanto si ha già una proprietà (fondiaria)[20]. Basti pensare
all'enorme, kafkiana, macchina catastale e notarile. Tutto ciò non è mai
in discussione. L'unico tentativo di opposizione a questa realtà è stata
la abrogata legge sull'equo canone
(1978-1992), che se da un lato tentava la calmierazione dei fitti,
dall'altra prevedeva una mai avviata opera di costruzione, da parte
dello Stato, di abitazioni da riservare a chi non possedeva una casa. Ma
con il ritorno al mercato puro e la rinuncia all'edilizia pubblica, al
di fuori del presupposto implicito della proprietà, nessun diritto alla
casa è assicurato. Ecco perché sarebbe pur necessario cominciare a
parlare di diritto ad abitare,
piuttosto che diritto di avere una proprietà. La proprietà è vincolante
tanto per l'iniziativa pubblica, quanto per il piccolo privato, che in
tempi di mercato dei fitti impazzito, in generale non dispone mai di una
proprietà localizzata in modo confacente alle proprie esigenze
lavorative (sempre meno stabili, tra l'altro, con la precarizzazione del
mercato del lavoro), con la qual cosa se è pur vero che il 70% delle
famiglie italiane è proprietaria di casa, è anche vero che ognuno di noi
è allo stesso tempo, per motivi contingenti, tanto proprietario quanto
affittuario. Inoltre, sempre a causa del mercato fondiario, i fitti
risultano in generale, per nulla interscambiabili, per cui neanche la
(piccola) proprietà garantisce un diritto (se non a pagamento) ad
abitare il paese, senza dover sottostare al ricatto dei fitti. La
piccola proprietà non fa altro che vincolare le persone ad un
determinato territorio, ad una certa località, rendendole cittadine di
quella località e non di un ambito almeno nazionale e dunque con
interessi e preoccupazioni che non superano l'orizzonte immediato del
proprio giardino. Spesso è possibile notare un certo provincialismo
degli italiani. L'estorsione rappresentata dal fitto, che s'impone in
genere per motivi lavorativi o di studio, rappresenta una vessazione, a
cui, chi può, cerca di sfuggire attraverso la soluzione individuale
dell'acquisto mediante il mutuo. Da un certo punto di vista è come
cadere dalla padella nella brace, ma da un altro punto di vista il mutuo
rappresenta la possibilità di riscattare la proprietà dopo anni di rate,
che, a seconda dei casi, possono essere anche vicine, in termini
monetari, a quelle dei fitti, in modo che la scelta sostanziale divenga
quella fra un "fitto a perdere" ed uno che lascia quanto meno l'agognato
tetto in proprietà. Il mutuo è per certi versi una pratica proudhoniana
individualista, peraltro riservata a una fetta di popolazione estesa in
ragione inversa a quella dilagante sottoposta alla precarizzazione del
mercato del lavoro. Inoltre da questo punto di vista, la rendita
fondiaria diventa parte del più generale meccanismo di rendita
finanziaria, come ampiamente dimostrato dalla crisi dei
subprime esplosa nel 2008, e
le case, quando le cose non vanno bene, sono delle banche, che non ne
hanno bisogno. Dal problema della rendita fondiaria come leva di quella
finanziaria non si esce pacificamente né a livello individuale, né a
livello di gruppi organizzati con le pratiche di "autocostruzione"
(cooperative ed altre forme di associazione il cui primo atto è la
stipula del mutuo per l'acquisizione dei terreni), né a livello pubblico[21], senza porre fine
alla legittimazione giuridica del "fitto eterno", senza riconoscere cioè
la necessità di una riarticolazione strutturale del diritto urbanistico
non più fondato, anche costituzionalmente, sulla proprietà privata.
2. Vincoli al tempo.
2.1 Struttura del tempo. Astrazione o ciclicità biologica?
La città è la stratificazione
immobiliare successiva dei prodotti della cultura umana dei diversi
periodi storici. Le differenti concezioni urbane che è possibile
individuare spazialmente sulla mappa topografica di un insediamento,
sono anche il prodotto di una differente struttura del tempo che
informava le diverse epoche. Ma il modo concreto di vivere una certa
struttura urbana è sempre il risultato dell'interazione della forma data
con la struttura del tempo di
una certa epoca. Allora la medesima forma urbana cambia i suoi effetti
sulla vita quotidiana anche in relazione ai mutamenti delle strutture
temporali dominanti nelle diverse epoche. Si tende a dare per scontata
l'oggettività del tempo e di conseguenza ad immaginare che il modo di
vivere la città sia indifferente al modo di misurare e comunque
percepire lo scorrere del tempo. Il problema è che c'è un tempo
oggettivo ed esterno ed un
tempo soggettivo ed interno e
che gran parte della qualità della vita dipende dal rapporto concreto
fra queste due nature del tempo. Un'epoca dominata dal tempo esterno
implica una subordinazione ad esso dei tempi interni, il che significa
un adattamento forzato dei ritmi biologici e dei cicli vitali ai ritmi
della produttività sociale. E la differenza fra un'epoca autoritaria e
un'epoca libera risiede, in ultima analisi, proprio in questa domanda:
quale delle due nature del tempo subordina l'altra?
Siamo in un'epoca dell'oggettività o
della soggettività? La risposta è resa evidente anche dal modo che una
società ha di misurare il tempo. Esso, essendo considerato oggettivo,
viene diviso, e di conseguenza misurato, in unità astratte, slegate
dalla ciclicità dei processi biologici o legate a questi in modo del
tutto formale. Ad esempio la divisione del ciclo giorno-notte in 24 ore
e la divisione delle ore in 60 minuti e così via, che relazione hanno
con i ritmi biologici dell'uomo? Cosa rappresenta lo scorrere di un'ora
di tempo in rapporto alle attività umane? Quanto dura in effetti la
capacità umana di svolgere un'attività con la stessa attenzione e
rendimento? In che modo gli intervalli temporali stabiliti (successione
continua di ore di lavoro, di riposo, di svago e così via) si adattano
al metabolismo umano, e alle sue differenze soggettive? È meglio pensare
che la società nel suo complesso svolga gli intervalli di attività e
riposo in fase, o si potrebbe pensare ad un loro sfasamento? Uno degli
ambiti in cui è evidentissimo il totale non rispetto dei ritmi biologici
è quello industriale, in cui le turnazioni lavorative sono stabilite
subordinando i ritmi dell'uomo a quelli della macchina,
indipendentemente dalla capacità di qualcuno di lavorare meglio di notte
che di giorno e viceversa e tanto più che questi turni vengono anche
continuamente alternati.
Ma non è proprio questo modello che
dall'industria è stato esteso a tutte le attività umane? Lo stress
fisico non è sempre prodotto dalla difficoltà di regolare i propri ritmi
interni con quelli esterni?
Che cos'è una settimana? Per quale
motivo è composta di sette giorni (lo ha deciso Dio)? Essa è una pura
convenzione, come d'altra parte i mesi di trenta giorni. Che significato
ha un ciclo ripetuto di attività-riposo lungo sette giorni? In che modo
esso risponde o si concilia con le capacità umane di sostenere un certo
numero di ripetizione delle attività?
In poche parole, la struttura del tempo
che regola la nostra esistenza, considerata come somma delle unità di
misura del tempo a che logica risponde, se vi risponde?
Qualcuno è magari convinto che
l'orologio sia sempre esistito, senza considerare che la sua diffusione
di massa, con l'orologio da polso, è cosa molto recente, sostanzialmente
relativa al primo quarto del '900. Ora si provi ad immaginare come
cambierebbe il modo di vivere la città senza la possibilità di misurare
esattamente i minuti e i secondi del flusso temporale. Molte transizioni
temporali si sfaserebbero, alcune attività sarebbero aperte, altre già
chiuse, le ore di punta potrebbero scomparire, gli ingorghi pure, non ci
sarebbero appuntamenti ma incontri, la catena di montaggio sarebbe
impossibile e con essa il moderno coordinamento delle azioni militari.
La produttività individuale non risulterebbe misurabile
quantitativamente e gli spostamenti urbani non sarebbero conteggiati in
tempo ma in distanza, e chissà quant'altro.
In alcuni film di fantascienza si
rappresentavano delle società future in cui il controllo sui criminali
avveniva tramite l'apposizione di un bracciale elettronico in grado di
permettere sempre alle forze dell'ordine di monitorare spostamenti e
posizione in "tempo reale" dei soggetti incriminati, per la qual cosa la
città diventava il luogo di reclusione, superando la necessità di
dedicarvi delle strutture apposite. Con il bracciale elettronico il
criminale poteva liberamente essere controllato. Se pensiamo a come
tutti noi siamo dotati di un bracciale con delle lancette e a come
volontariamente decidiamo
delle nostre azioni quotidiane in base alla posizione che le lancette
hanno sul quadrante, di colpo anche il bracciale elettronico controllato
dall'esterno appare un concetto superato. La realtà è più dura della
metafora.
L'orologio da polso è evidentemente uno
dei principali agenti di Edipo. Il controllore è dentro di noi. Ma la
città pre-capitalista non era regolata dalle lancette dell'orologio.
Il paragone del tempo feriale con quello
festivo può essere utile a ragionare sulla relatività dell'importanza
della misurazione precisa del tempo. Nei giorni feriali l'importanza
della misurazione precisa diventa ossessiva, sono importanti tutti i
minuti e quindi la scala fondamentale della misura si sposta dalle ore
ai minuti (in alcuni casi addirittura sui secondi). In sostanza la
misura elementare del tempo ha una dimensione piccola, rispetto al tempo
festivo in cui diventa più importante lasciare che la giornata sia
regolata sui ritmi necessari al riposo, all'appetito, allo svago. Si può
osservare allora una striatura
molto fitta (grana[22] fine) del tempo
produttivo, rispetto ad una relativa
lisciatura del tempo (grana grossa) festivo, in cui le azioni si
contano ad ore piuttosto che in minuti. In un orologio per la festa la
lancetta dei minuti potrebbe essere superflua o scattare con intervalli
di mezz'ora. Consegue che anche il tempo, come lo spazio, può essere
letto come più o meno liscio o striato[23]
e che tale qualità sia direttamente influente sul nostro concreto modo
di vivere.
La stessa città è diversa il lunedì
rispetto alla domenica. Cambia il nostro rapporto con essa. E una città
può avere dei ritmi relativamente differenti da un'altra città,
soprattutto se diversa è la loro dimensione e la loro importanza come
centri produttivi, il centro e la periferia hanno tempi diversi. Non si
sfugge alla striatura del tempo, ma la sua fittezza (o grana) può
cambiare relativamente da luogo a luogo, ma anche da cultura a cultura,
o da un gruppo sociale all'altro, tanto che un gruppo sociale e il suo
quartiere può anche essere definito da una concezione di tempo diversa
rispetto ad un altro. Più che parlare di differenti luoghi e differenti
tempi si potrebbe parlare di differenti configurazioni di "luoghi-tempo"[24].
L'esempio estremo è ovviamente quello
dei nomadi, che oltre ad avere un rapporto indefinito con lo spazio,
hanno anche un concetto del tempo molto poco striato, rispetto alle
civiltà rigidamente territorializzate. Ma non sempre luogo e tempo
definiscono condizioni ambientali coerenti. Un clochard non si cura di
nessuna griglia temporale diversa da quella dei propri bisogni
elementari per sopravvivere, pur abitando una città completamente
imbrigliata. Un disoccupato lo si incontra in giro o a manifestare. A un
"occupato" bisogna dare un appuntamento preciso per potergli parlare. I
diversi tempi individuali e di gruppo sono una barriera alle interazioni
fra gruppi diversi, costituiscono dei filtri sociali. Non sarà un caso
che chi è esterno da una griglia spaziale definita si trova ad essere
ugualmente esterno da una griglia temporale definita. La griglia di
striatura è un meta-condizione della nostra epoca. Essa ha una forma
spaziale definita sostanzialmente dalla configurazione della proprietà
privata e una struttura temporale definita sostanzialmente dai cicli
produttivi. Queste forme spazio-temporali sono da un lato indifferenti
ai luoghi, dall'altro indifferenti agli individui, esse sono astratte
come l'accumulazione infinita che tutto subordina.
2.2 Ciclicità rigida o flessibile? Poli temporali concentrati o diffusi?
Seppure il tempo non fosse astrattamente
suddiviso esso sarebbe comunque subordinato ad una necessaria ciclicità
delle azioni, dalla quale non si può prescindere. Ma l'astrazione della
misura determina, in diversi modi, l'astrazione delle ciclicità o se si
vuole la rigidezza del loro susseguirsi. In una temporalità concreta, al
contrario, sarebbe molto più naturale far seguire le misure alle
ciclicità biologiche, il che implicherebbe una flessibilità
dell'organizzazione sociale dell'attività relazionata concretamente alla
predisposizione biologica all'attività, secondo un concetto per cui non
è più tanto importante quanto tempo si impiega a fare qualcosa, ma il
risultato complessivo (taylorismo vs toyotismo). La città non avrebbe
tempi predeterminati, ma si configurerebbe come un'infrastruttura a
disposizione del libero succedersi della produttività sociale. Gli
spostamenti urbani non sarebbero concentrati ma diffusi, il che equivale
a dire che si guadagnerebbe spazio.
Se si osserva il modo in cui si utilizza
l'infrastruttura urbana oggi, si nota come gran parte dei suoi problemi
derivi dalla rigidità di cicli forzatamente in fase. Il ciclo
riposo-attività è forzato rispetto a quello notte-giorno. Ma si sa bene
che ci sono persone che sono più produttive dopo il riposo ed altre che
lo sono di più prima, è una questione di metabolismo, e anche di
tipologia delle attività che si svolgono. L'unica eccezione che si fa a
questa regola fissa, non è determinata da esigenze delle persone, ma da
esigenze delle macchine (turni notturni in alcuni tipi di lavoro). Tutto
ciò costringe a fare tutti le stesse cose nello stesso momento, il che
si trasforma in un enorme sperpero di tempo sociale dovuto alle
disfunzioni che questa contemporaneità genera (ore di punta).
La rigidezza delle ciclicità implica nel
tempo anche una semplificazione e forte polarizzazione dei fulcri
temporali di un ciclo, per cui si tende ad una concentrazione anche
spaziale dei poli di attività e di riposo. Un luogo di lavoro tende a
prevedere semplicemente spazi di attività e nessuno spazio di pausa e
relazione, il luogo del riposo viene assimilato sostanzialmente
all'abitazione, dove però si è anche isolati. Il resto dello spazio è
funzione di moto a luogo fra i
due poli principali di attività e riposo. Viene a mancare quasi del
tutto lo spazio ed il tempo relazionale. Promiscuità in luogo di vita in
comune, isolamento in luogo di intimità. Si genera un'atrofizzazione del
concetto di abitare, ridotto all'abitazione e sottratto dall'ambito
dello spazio pubblico, quest'ultimo ridotto a pura circolazione.
Nell'orgia circolatoria si realizza il delitto della passeggiata. Il
soggetto è mosso dalla necessità di incastrare tempi rigidi e tende a
considerare gli altri soggetti come ostacoli lungo il proprio cammino.
L'incontro diventa scontro, l'interno un rifugio e l'esterno una lotta
quotidiana. L'uomo si muove isolato e corazzato, portandosi ovunque in
giro il proprio ambito "interno", protetto dall'esterno nella sua
automobile o dal suo iPod e
dal suo telefonino. In questo modello dello spostamento forzoso, lo
spazio pubblico ereditato da città di altri tempi (e con altri tempi)
appare sempre più come qualcosa di inutile e ingombrante (piazze vuote).
L'ossessione per la propria individualità e la protezione che questa
sembra garantirci è visibile anche nell'attenzione allo spazio solo
interno della propria esistenza. Interni pieni di gadget confortevoli e
quanto più possibile curati, soprattutto se di proprietà, ed esterni
abbandonati all'incuria ed alla sporcizia. La città come una somma di
interni impenetrabili giustapposti in un ambiente esterno indifferente,
che può essere tanto un ambiente storico, quanto una periferia, un
suburbio, una campagna oppure un deserto. Ma il punto è che la qualità
della vita che si svolge in un qualsiasi agglomerato urbano dipende
sostanzialmente da ciò che avviene sotto il cielo, dalla qualità
dell'esterno e non da quella dell'interno, o, se si vuole, dalla
capacità dell'esterno di conformarsi come un interno. Se così non fosse
la città non avrebbe nessun significato, non esisterebbe. Anzi le città
anche molto belle o molto fortunate nella storia, sono proprio quelle in
cui la qualità dello spazio pubblico è preponderante rispetto allo
quella dello spazio privato, quest'ultimo a volte anche molto
sacrificato. Una struttura temporale che interpreta lo spazio pubblico
semplicemente come veloce moto a luogo, e non come combinazione di più
funzioni possibili e anche molto diversificate, implica un concetto di
spazio collettivo impoverito. Se la collettività non ha però un suo
tempo e un suo spazio, essa non esiste. È forse anche per questo che la
collettività tende a virtualizzare il proprio spazio relazionale
impiegando però il proprio tempo reale e desertificando ciò che resta
del proprio spazio pubblico.
Nella misura in cui non è ancora
possibile, nonostante tutto, ridurre la città alla polarità temporale
casa-lavoro, non è neanche possibile eludere la funzione del consumo.
Quello che si osserva facilmente è che l'attività è in generale consumo,
di tempo ed energie, e che quando non si tratta di consumare per
produrre, si tratta di consumare per consumare.
Così la rigida strutturazione dei cicli
temporali urbani ammette poche grosse esperienze urbane diverse dalla
produttività, anche se relegate ad un secondo livello di ciclicità più
lunga e sostanzialmente polarizzata verso il finesettimana. Queste sono
riassunte nel concetto di "svago a pagamento". La fetta preponderante
dello svago è assimilata all'acquisto di beni e servizi, cioè al centro
commerciale di massa dotato di amplissimi parcheggi, o in alternativa
allo stadio, al cinema multisala, alla discoteca. La piazza in sé, non
prevedendo permeabilità subordinata al consumo, non rientra in generale
nel moderno concetto di svago. Ciò che non si paga, non ha
considerazione in una macchina da rendita.
In questo modo la polarità temporale che
detta l'attività circolatoria urbana è finalmente triangolata ed
edipizzata (lavoro-riposo-svago), su un modello che non implica alcuna
necessità relazionale fra i gruppi in gioco e in cui qualsiasi spazio
capace di offrire altro è superfluo.
Detto di passata la precarizzazione del
mondo del lavoro essendo stata interpretata da parte dell'imprenditoria
unicamente come libertà di disporre a piacimento della produttività
sociale, con il risultato concreto che si lavorano le stesse ore
quotidiane per una retribuzione minore, non ha nessuna ricaduta di
qualche influenza sui tempi della città. I precari quando lavorano lo
fanno quanto e più degli altri, e quando non lavorano non lo fanno, ma
in nessun modo riescono a stabilire un proprio ritmo esistenziale
svincolato dalla produttività loro imposta a singhiozzi. Questo non ha
nulla a che vedere con una la flessibilità dei tempi interni
(soggettivi) quotidiani, ma semmai, e comunque solo alla lontana, con
una flessibilità dei tempi esterni ai quali il tempo interno va
subordinato sempre più selvaggiamente.
È anche chiaro che una completa
soggettivizzazione del tempo si configura anche come elemento di
disgregazione familiare, ad esempio, ma solo se non si vuole vedere come
la famiglia sia già asservita completamente al tempo esterno,
configurandosi, da quando non è più unità produttiva elementare, come
semplice vincolo temporale spazialmente confinato.
2.3 Estensione spaziale e segregazione temporale.
La crescita illimitata delle grosse
metropoli, l'aumento dei tempi di percorrenza fra punti sempre più
distanti, sono elementi che inseriscono delle soluzioni di continuità
temporale nella continuità spaziale. Quando le distanze e le dimensioni
crescono a dismisura, le diverse parti urbane comunicano sempre più
difficilmente fra loro fino a diventare estranee l'un l'altra, allo
stesso modo di come potrebbero essere estranee fra loro città
completamente diverse. In questo senso l'illimitatezza della crescita
urbana diventa un elemento che favorisce la separazione e la
disgregazione di una collettività e uno strumento di controllo delle
relazioni sociali più efficace delle barriere materiali. Ogni relazione
possibile diventa non fisicamente impossibile ma temporalmente ed
energeticamente poco opportuna. Il tutto urbano si divide, pur restando
individuabile come organismo più o meno definito territorialmente. Da
questo punto di vista nonostante l'apparente unità urbana delle grosse
conurbazioni, ci troviamo di fatto di fronte a parti formalmente uguali
(le periferie sono quasi tutte uguali) ma di fatto scisse.
Ma se questa inopportunità condiziona
potenziali relazioni libere, si impone come non eludibile nella
relazione spaziale fra riposo e lavoro, ad esempio, imponendo alla
casualità delle collocazioni spaziali dei due poli temporali
(riposo-attività, casa-lavoro) un consumo energetico sempre crescente.
Le relazioni umane nei moti a luogo necessari, sono relazioni fra
persone che non condividono quasi mai lo stesso spazio. Se nella città
più rigidamente zonizzata di epoca fordista le concentrazioni produttive di tipo
industriale fornivano una grossa condivisione spaziale tanto nel polo
abitativo (i grossi quartieri operai) quanto nel polo lavorativo (la
catena di montaggio), con la microframmentazione delle unità produttive
post-fordiste, la dimensione spaziale condivisa diventa progressivamente
meno massificata a fronte della crescita dell'organismo urbano. Le
interazioni avvengono fra gente sempre più lontana, prive di esperienze
comuni extra-circolatorie, che sono esperienze conflittuali.
Dove non arriva lo zoning spaziale,
giunge quello temporale. Una striatura temporale cala su quella
spaziale.
Di passata è facile osservare anche come
le città che sono maggiormente pianificate, in genere sono anche quelle
in cui tutto risulta più regolato. Una produttività razionalmente
organizzata richiede uno spazio altrettanto organizzato. Il nuovo tipo
umano della produzione fordista non doveva disperdersi in mille circuiti
temporali, ma avere un’esistenza regolata da ritmi ben precisi e
cadenzati, e precisamente individuati nello spazio e nel tempo. Da
questa rigida dislocazione dell’esistenza deriva anche l’immagine poco
festosa delle città produttive, nelle quali tutto si svolge
ordinatamente.
A livello soltanto intuitivo, e non
suffragato da dati, si può senz’altro notare come i centri produttivi
maggiori, essendo basati su una più lunga tradizione di lavoro garantito
e regolato, siano anche quelli più razionalmente organizzati dal punto
di vista della disposizione spaziale degli elementi urbani e della
dotazione di infrastrutture per una circolazione quanto più ordinata ed
efficiente. Il fordismo portava con sé anche la pianificazione
urbanistica. Laddove invece l’organismo urbano non costituisce un centro
produttivo di una certa importanza, lo spazio resta in generale poco
organizzato e sostanzialmente determinato al grado zero dalla
frammentazione anarchica della proprietà privata dei suoli. Pare, in
questo modo, che ad un certo livello, la frammentazione della proprietà
è chiaramente un ostacolo alla produttività, ma anche che la
pianificazione urbanistica è, in certo qual modo, legata alla
pianificazione più strutturata della produttività. Non è difficile
notare come le grosse metropoli dei paesi capitalisti con una minore
tradizione fordista siano anche quelle in cui la spontaneità dei
processi di sviluppo urbano siano prevalenti rispetto ad interventi
pianificati, al punto che questi siano a volte talmente fuori contesto,
da generare effetti sociali e formali addirittura peggiori della città
"informale". Così nel mondo, proprietà privata e produttività sociale
costituiscono due poli dialettici fra loro opposti sul piano
dell'organizzazione dello spazio urbano, ma che non collocandosi
all'esterno di un modello di vita subordinato alla produttività, non
sono, ugualmente, in grado di generare una nuova concezione dello spazio
urbano, finendo per rappresentare semplicemente due diversi gradi di
sviluppo del capitalismo come modo di organizzare l'habitat urbano.
Da un altro punto di osservazione è
chiaro che il beneficio organizzativo dei principi del fordismo,
richiederebbe, in un'ottica riformista, la totalizzazione del controllo
pubblico sul privato, che però non avrebbe alcun senso senza
l'eliminazione di quei rapporti sociali e di produzione che fanno dello
Stato e di tutte le istituzioni degli strumenti del privato[25]. In sostanza o il
pubblico è controllato collettivamente dalla popolazione secondo
modalità democratiche completamente nuove, oppure la dialettica
pubblico/privata è obiettivamente priva di qualsiasi senso. E se questo
sembra essere solo un problema politico, esso si traduce direttamente
anche in un problema urbano.
3. Conclusioni
Da quanto detto emerge, si spera, un
dato importante: per quanto la città sia una questione sostanzialmente
spaziale, il problema della sua degenerazione non è risolvibile mediante
misure di semplice configurazione spaziale. Non è solo una faccenda di
"disegno". L'urbanistica non basta. La pianificazione urbanistica non è
un'invenzione dell'epoca moderna, ma una pratica antichissima, eppure i
moderni quartieri frutto di interventi pubblici pianificati, non vanno
(quando riusciti) oltre una maggiore qualità formale dello spazio ed
un'organizzazione più razionale delle funzioni, restando comunque
imbrigliati in un funzionamento complessivo incapace di realizzare
l'utopia. Il libro di Tommaso Moro nel descrivere Utopia non parla tanto
di forme urbane, quanto di una diversa organizzazione sociale, di un
diverso rapporto fra persone, implicando con ciò un diverso tempo
globale in cui una specifica forma socio-urbana si inquadra.
Una "new town" inglese, al pari delle sterminate periferie del
nord America (o di Londra) è ordinatamente disegnata, ma questo non
rende più libere (meno assoggettate all'imperativo della produttività)
le persone che vi abitano, né le rende meno individualiste, ossessionate
come sono dal proprio recinto in legno bianco, il proprio prato verde,
la propria casa-capanna. Uno sprawl ordinato non differisce
sostanzialmente da uno "spontaneo" per la vita che vi si conduce. Le
disordinate conurbazioni metropolitane, non sono meno vitali delle
ordinate capitali del capitalismo avanzato. Una città sovietica, sorta
certamente su suolo indiviso, non pare essere più invitante di una
qualsiasi altra città cresciuta in modo caotico, né liberata da
striature di ogni sorta. Con questo non si vuole relativizzare la
necessità della pianificazione urbanistica, o negare la generale
preferibilità delle città pianificate, come non è facile sostenere che
il fordismo fosse inferiore alla destrutturazione attuale del mercato
del lavoro e dello Stato sociale, ma semplicemente significare che se è
difficile pensare di tornare al fordismo, forse è altrettanto difficile
pensare di continuare ad opporre semplicemente la città pianificata a
quella spontanea (e il pubblico al privato), come unica possibilità di
recuperare la ragione, senza cercare di porre il discorso su basi nuove
in grado di non eludere l'enorme questione dell'azione diretta delle
masse nel governo del proprio destino, attraverso la sostanziale
liberazione della risorsa temporale e la definizione degli strumenti
pratici della partecipazione, che è come dire: va bene pianificare, ma
il vero problema è chi
pianifica cosa.
«Il livello dell'architettura è quello
dell'abitare; quello dell'urbanistica riguarda la società nel suo
insieme, e la sua soluzione dipende da una trasformazione di questa
società».[26]
Si è voluto fare riferimento ai concetti
di liscio e striato, perché pare che la striatura, intesa come
apposizione di barriere artificiose lungo le possibilità del movimento
generico, sia una sintetica modalità di raggruppamento di problemi. E
che al contrario la lisciatura come ideale da contrapporre allo stato di
fatto, sia una caratteristica intuitivamente capace di riassumere un bel
po' di soluzioni. Il concetto di
striatura è applicabile tanto allo spazio (confini catastali, muri
di recinzione, lati dei fabbricati, delimitazioni di quartieri, limiti
amministrativi, zone militari, zone interdette, zone residenziali e così
via), quanto al tempo (secondi, minuti, ore, settimane, mesi, distanze
temporali), quanto, in definitiva, alle istituzioni politiche (e al
potere separato) che si configurano come chiuse, poco accessibili, non
trasparenti, interdette al pubblico (il palazzo), alle classi sociali e
i vari gruppi e caste, alle discipline settoriali, alle culture e via
dicendo. Allora la tensione verso una progressiva
lisciatura di spazio, tempo,
politica, società, sembra essere una valida indicazione di obiettivi da
conseguire, con una ricaduta positiva in un vasto settore di realtà,
onde giungere alla distruzione di quelle barriere artificiali che di
fatto condizionano negativamente l'esperienza collettiva, la cui scena
centrale è riassunta nella vita urbana. La polis futura o è liscia
(senza barriere materiali e virtuali) e contemporaneamente nello spazio
e nel tempo o è falsa (confinata nelle rappresentazioni opposte di
spazio senza tempo, come la città pianificata, e di tempo senza spazio,
come la periferia suburbana, la favela, la bidonville). La collettività
o è liberata dagli ostacoli alla propria essenza comune, oppure è
atomizzata e coagulata attorno alle proprie divisioni esteriori ed
interiori.
Esistono o possono esistere spazi, tempi
e istituzioni completamente lisci o striati? Probabilmente no, ma non è
difficile distinguere un oggetto relativamente striato da uno
relativamente liscio.
Cos'è uno spazio liscio? È uno spazio
comune cioè permeabile, accessibile e continuo. La città, pur essendo lo
spazio striato per eccellenza presenta una serie di spazi pubblici: le
vie, la metropolitana, le piazze, un lungofiume, una battigia, un parco,
una pista ciclabile, un centro sociale. Una serie di spazi semipubblici
(permeabili, ma non sempre accessibili e non continui): il teatro, il
cinema, il municipio, l'ospedale, le scuole, l'università, il tribunale,
il centro commerciale e così via. Un resto di spazi privati, cioè
impermeabili, inaccessibili e discontinui (o discreti e isolati) come
l'abitazione/cella della famiglia/singolo. Di passata va notato che lo
spazio pubblico, non produce rendita, quello semipubblico a seconda dei
casi e quello privato sempre. Anche la prima casa se non produce rendita
perché ricondotta al proprio valore d'uso, produce il beneficio della
sottrazione al debito infinito del fitto. Non a caso l'attenzione allo
spazio comune (non remunerativo) è in via di estinzione.
Cos'è un tempo liscio? Un tempo
sottratto all'imperativo della ciclicità rigida, della produttività
misurabile, dell'inopportunità energetica e della scansione astratta. È
il tempo della festività, della vacanza, della passeggiata, della
rinuncia, della lentezza, della pausa, ma anche della creatività,
dell'invenzione, dell'imprevisto, dell'esplorazione, della scoperta,
dell'amicizia e dell'amore. Il tempo in grado di mutare il senso dello
spazio vissuto.
Cos'è una democrazia liscia? Lo
strumento di gestione del tempo e dello spazio comune, liberato da
recinti, dalla separazione fra rappresentati e rappresentanti, dalle
pieghe di potere, dall'autorità degli organi superiori, dalle
competenze, in poche parole: uno spazio continuamente accessibile a
tutti, in cui la manifestazione spaziale di una decisione comune non sia
più (infinitamente) differibile nel tempo.
La
polis come luogo politico della riconquista dello spazio e del tempo
dell'esperienza.
SETTEMBRE 2011
[1] La polis fu un modello di struttura tipicamente e solamente greca che prevedeva l'attiva partecipazione degli abitanti liberi alla vita politica. In contrapposizione alle altre città-stato antiche, la peculiarità della polis non era tanto la forma di governo democratica od oligarchica, ma l'isonomia: il fatto che tutti i cittadini liberi soggiacessero alle stesse norme di diritto […]. Ognuno trovava la propria realizzazione nella partecipazione alla vita collettiva e nella costruzione del bene comune […]. La nozione di città stato, elaborata dai moderni, sarebbe troppo rigida per esprimere le diverse realtà locali in cui era frazionata la Grecia antica: questo termine sembra infatti far riferimento ad una grande varietà di forme di insediamento e di comunità politiche, a livelli cronologici oltretutto diversi. L'idea della polis senza stato è stata anticipata da alcuni interventi volti a sottolineare il carattere prevalentemente sociale della città greca. Robin Osborne ha sottolineato la mancanza di una autorità statale nella polis e un potere esecutivo vero e proprio. Paul Cartledge ha osservato che essa ignorava la distinzione tra governanti e governati come le nozioni dei diritti dell'individuo e di tolleranza, mentre conosceva una serie di forme di controllo sociale per il mantenimento dell'ordine costituito. La riflessione è stata approfondita da Moshe Berent, il quale sostiene che la polis non corrispondeva ai criteri necessari per poter parlare di "stato", in quanto non presentava una adeguata distinzione tra popolo e potere esecutivo, non aveva il monopolio della coercizione e affidava la tutela dell'ordine pubblico all'iniziativa individuale. Per lui era dunque una "stateless comunity", nel senso di una comunità di guerrieri la cui coesione dipendeva dalla tattica di combattimento politico. Recentemente Oswyn Murray ha sottolineato che il suo carattere era fortemente politico, identificando quest'ultima come "città della ragione" in cui ogni decisione era presa in seguito alla applicazione della procedura razionale della discussione; ossia si presentava come un contesto nel quale si esprimeva pienamente una forma di razionalità politica e si offriva la possibilità di vivere secondo ragione in base ad un ordine non imposto dall'alto, ma concordato dalla comunità. Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Polis
[2]
«L'architettura è anzitutto l'espressione di una volontà
politica. La scelta politica condiziona tutte le decisioni a
livello dello spazio costruito». B. Zevi,
Profilo della critica architettonica,
Newton & Compton Editori, Roma 2003, pag. 43.
[3]
Dalla rilevazione dell’Istat, relativa al 2008, risulta che
circa 7 famiglie su 10 sono proprietarie della casa in cui
vivono. Si tratta di circa 16,9 milioni di famiglie, vale a dire
il 68,5% dei nuclei familiari di tutto il Paese. Sono invece 4,7
milioni – due ogni dieci – le famiglie che vivono in affitto,
per una percentuale del 18,9% sul campione di riferimento. Il
restante 12,6% delle famiglie (3,1 milioni di nuclei familiari),
invece, abita in case in usufrutto o in uso gratuito.
[4]
«Gli esponenti più accorti delle classi dominanti hanno sempre
indirizzato i loro sforzi ad accrescere il numero dei piccoli
proprietari, allo scopo di allevarsi un esercito contro il
proletariato. Le rivoluzioni borghesi del secolo scorso hanno
diviso la grande proprietà fondiaria della nobiltà e della
chiesa in piccola proprietà particellare, come vogliono fare
oggi i repubblicani spagnuoli con il latifondo che è ancora in
essere, ed hanno creato così una classe di piccoli proprietari
fondiari, che da allora è divenuto l'elemento ultrareazionario
della società e il costante ostacolo contro il movimento
rivoluzionario del proletariato urbano. Napoleone III divisò di
creare nella città una simile classe mediante la diminuzione
delle singole obbligazioni del debito pubblico, e il signor
Dollfus e i suoi colleghi, vendendo ai loro operai piccole
abitazioni da ammortizzarsi mediante rate annuali, tentavano di
soffocare in loro ogni spirito rivoluzionario e
contemporaneamente di inchiodarli con le catene della proprietà
fondiaria alla fabbrica nella quale essi già lavoravano». F.
Engels, La questione delle
abitazioni, Editori Riuniti, Roma 1974, pag. 42.
[5]
«I bolscevichi sono gli eredi storici dei Livellatori inglesi e
dei Giacobini francesi. Ma il compito concreto, che ad essi
spettava nella rivoluzione russa dopo la conquista del potere,
era incomparabilmente più difficile di quello dei loro
precursori. […] Certo la parola d'ordine dell'occupazione
immediata e diretta e della suddivisione della terra da parte
dei contadini era la più sbrigativa, la più semplice e la più
lapidaria formula per raggiungere contemporaneamente due
obiettivi: frazionare il latifondo e legare subito i contadini
al governo rivoluzionario. Come provvedimento politico per i
consolidamento del governo proletario socialista, questa era una
tattica eccellente. Ma essa aveva purtroppo due facce e il
rovescio della medaglia stava nel fatto che l'immediata
occupazione della terra da parte dei contadini non ha per lo più
nulla di comune con l'economia socialista […]. La parola
d'ordine, data dai bolscevichi, della presa di possesso
immediata e della divisione della terra da parte dei contadini,
doveva operare addirittura in senso contrario. Non solo non è un
provvedimento socialista, ma taglia la strada che vi conduce, ed
accumula difficoltà insormontabili sulla via della
trasformazione dei rapporti agrari in senso socialista […]. Si è
creata così non una proprietà sociale, ma una nuova proprietà
privata, vale a dire lo spezzettamento della grande proprietà in
proprietà piccole e medie, della grande azienda relativamente
progredita in piccole aziende primitive che lavorano con mezzi
tecnici del tempo dei Faraoni». R. Luxemburg,
La Rivoluzione russa,
in Scritti politici,
Editori Riuniti, Roma 1969, cap. 3, pag. 572.
[6]
«Il 20 agosto 1918 un altro decreto si univa a completare le
prime disposizioni […] e concerneva il diritto di proprietà
fondiaria e immobiliare.
Art. 1.
– Il diritto di proprietà individuale è abolito per ogni
appezzamento di terreno, senza alcuna eccezione, compreso nei
limiti di agglomerati urbani siano essi costruiti o no, sia che
appartengano a privati, o a imprese produttive o a istituzioni.
Art. 2.
– Nelle città di più di 10.000 abitanti, il diritto di proprietà
individuale è abolito per ciò che riguarda tutte le costruzioni
che, compreso il terreno sul quale sono edificate, eccedano un
prezzo o producano un profitto maggiore ai limiti fissati dagli
organi amministrativi locali.
Art. 5.
– Tutti i terreni e gli edifici che, in applicazione del
presente decreto, cessano di essere proprietà individuale sono
messi a disposizione delle autorità locali.
Art. 6.
– Nelle città di più di 10.000 abitanti, il diritto di costruire
appartiene esclusivamente alle amministrazioni locali. Nelle
città la cui popolazione è inferiore alla cifra di cui sopra
questo diritto può essere concesso ai privati dalle autorità
locali.
Art. 12.
– Le autorità locali possono destinare fino ad 1/3 delle risorse
così ottenute alle spese di gestione legate alla esecuzione del
presente decreto così come alla soddisfazione dei bisogni della
popolazione. Le autorità locali hanno l'obbligo di destinare il
10% dei proventi al "fondo abitazioni" centrale dello Stato che
è incaricato della creazione di nuovi insediamenti urbani». A.
Kopp, Città e rivoluzione, Feltrinelli, Milano 1987, pag. 56.
[7]
H. Lefebvre, Il marxismo e
la città, Mazzotta, Milano 1973, pag. 138.
[8] Leggibile per intero al link: http://www.urba.unifi.it/docprog/Venturaf/library/classicallibrary/Bernoulli/Bernoulli_Index.htm
[9]
«Così il signore della città era padrone del suolo urbano, e
ogni singolo abitante era padrone della propria casa. Con questi
procedimenti, il concetto che il medioevo nutriva intorno alla
città ideale poteva trasformarsi in legname o pietra; la città
doveva sorgere sicura sopra un dorso di montagna o protetta da
un fiume; doveva avere un mercato, una via principale lunga e
larga oppure un ampio quadrato, nel centro. Il suo sistema
stradale doveva essere comprensibile a prima vista, segnare
comodi quartieri, inconfondibili distinzioni fra le vie
principali e le secondarie, fra quelle antistanti e quelle
retrostanti. La chiesa col suo camposanto doveva sorgere
appartata dal traffico, ma in modo tale che la navata maggiore e
il campanile, emergendo dalle altre case, dominassero la piazza
e la via principale». H. Bernoulli,
La città e il suolo urbano,
Antonio Vallardi Editore, Milano 1951, pag. 25.
[10]
«I fondatori delle città medievali avevano distribuito agli
abitanti le aree fabbricabili per un tempo indeterminato: e il
canone da pagarsi era stabilito immutabile […]. Non farà quindi
meraviglia se già nel 14° secolo alcuni proprietari di casa si
liberarono dell’importuno balzello col pagare in una sola volta
un capitale press’a poco corrispondente a quello del tasso
periodico. In tal modo il Comune che quasi dappertutto
era subentrato al Signore – Principe o Vescovo – si lasciò
prendere la mano per un piatto di lenticchie e perdette la
sovranità sul suolo». Bernoulli,
cit., pag. 46.
[11]
Bernoulli, cit., pag.
58.
[12]
«Tardivamente, ma in modo sempre più netto, il settore
immobiliare diventa un settore subordinato al grande capitale,
[…] con un rendimento attentamente precostituito sotto la veste
dell'organizzazione del territorio. […] I profitti risultano
immensi e la legge (tendenziale) della caduta del saggio medio
di profitto viene contrastata con grande efficacia». Lefebvre,
cit., pag. 141.
[13]
Questo senza dimenticare che non c'è realizzazione di rendita
urbana senza "processo costruttivo", il che da un lato significa
che la rendita è in qualche modo il vero motore della produzione
edilizia, dall'altro che l'enormità dei capitali necessari,
costituisce tutt'oggi una preponderanza produttiva nei sistemi
economici nazionali, rispetto alla produzione industriale di
beni mobili. «In Francia, nel 1965, con 1.200.000 salariati e
una cifra d'affari di circa 430 milioni di franchi, l'industria
delle costruzioni era, e resta, la più importante dell'economia
nazionale; l'industria automobilistica non rappresenta che un
terzo di questa cifra». Zevi,
cit., pag. 38.
[14]
«Qualora la città fosse stata la proprietaria del suolo, avrebbe
avuto libero campo per concedere o rifiutare le aree a
destinazioni edificatorie non desiderabili. Ma, avendo essa già
alienato i terreni, dovette bandire ogni diritto in proposito.
Ora invece, quando la città, per una miglioria che deve servire
a tutti, per esempio un nuovo parco, un campo sportivo, una
scuola, una caserma per pompieri, un cimitero, deve rivolgersi
al proprietario privato del terreno o dell’edificio, questi si
mette sorridendo a disposizione della comunità, ma dà
gentilmente a comprendere che l’affare sarà un po’ costoso.
Comincia un contrattare, un mercanteggiare che non ha mai fine;
e tanto più l’area conviene per lo scopo che la città si
prefigge, tanto più si eleva il prezzo che il proprietario
richiede. Spesso il rappresentante del Comune se ne deve andare
scuotendo deluso le spalle. La ricerca del terreno per molti
edifici pubblici diventa spesso una faccenda dolorosa, poiché
con ritagli casuali di terreno non si possono costruire né un
teatro, né un museo, né un municipio. Per simili costruzioni
occorrono località di primo ordine, una situazione di monopolio
e quindi anche cifre di monopolio. Al pronunciarsi del prezzo
naufragano tutti i progetti. È per questa ragione che le nostre
città difettano di ampie località libere per il riposo delle
persone anziane e di ampi campi di gioco per i bambini. L’alto
prezzo delle aree spaventa tutti». Bernoulli,
cit., pag. 69.
[15]
«Non tutti questi terreni erano però favoriti dalla fortuna: ma
la fortuna stessa poteva essere a sua volta modificata. Siccome
le aree fabbricabili lungo le strade principali erano valutate
assai più di quelle lungo le strade secondarie, la delicata
pressione della proprietà fondiaria ottenne che i nuovi
quartieri fossero riccamente dotati di strade principali. Quindi
il concetto di strada secondaria scomparve per decenni
dall’ordine del giorno. E siccome nella serie delle case
d’affitto, la casa d’angolo si addice particolarmente per
negozi, vetrine, ristoranti, locali d’affari di alto reddito, le
avvedute amministrazioni civiche si impegnarono ad incrociare
affrettatamente le vie in modo che le case d’angolo vi potessero
sorgere numerose» Bernoulli,
cit., pag. 68.
[16]
Stando ad un calcolo sommario e medio, basato sul reddito medio
di 1.200 euro al mese, il cui 25% è pari a 300 euro mensili,
vale a dire 3.600 annuali, che moltiplicati per lo stock di 3,2
milioni di case private in affitto (2005), dà appunto 11,5
miliardi di Euro l'anno, quasi quanto una finanziaria
"ordinaria".
[17]
Per approfondimenti:
http://www.altroconsumo.it/il-mercato-dell-affitto-in-italia-s304533.htm
[18]
Piero e Roberto Della Seta,
I suoli di Roma, Editori Riuniti, Roma 1988.
[19]
Lefebvre, cit., pag.
145.
[20]
«Il sistema contrattuale (giuridico), mantenuto e perfezionato
dallo Stato in quanto potere (politico), si fonda sulla
proprietà privata del
suolo (proprietà immobiliare) e del denaro (proprietà
mobiliare)». Lefebvre, cit., pag. 118.
[21]
Neanche cioè, se il pubblico costruisse, come non fa, case da
cedere agli affittuari dopo un certo numero di anni (quello che
auspicava Proudhon), in modo da rientrare dai costi
dell'operazione. Questo per la sostanziale ragione che la
proprietà immobiliare, come suggerisce la parola stessa, essendo
immobile,
implicherebbe una stabilità dell'attività lavorativa almeno di
qualche decennio e si trasformerebbe comunque immediatamente in
nuova proprietà privata una volta riscattata e perciò di nuovo
soggetta agli andamenti del libero mercato.
[22]
Per il concetto di "grana temporale" e altre dimensioni del
tempo si veda: K. Lynch, Il tempo dello spazio, Il Saggiatore, Milano 1977, pag. 97.
[23]
Per i concetti di "liscio" e "striato", si veda: G. Deleuze e F.
Guattari, Il liscio e lo
striato, in
Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma
2010.
[24]
Lynch, cit., pag. 287.
[25]
«Nazionalizzazione? Municipalizzazione del suolo? Ne conosciamo
più i limiti che i vantaggi». Lefebvre, cit., pag. 139.
[26]
H. Lefebvre, in Zevi, cit., pag. 38.