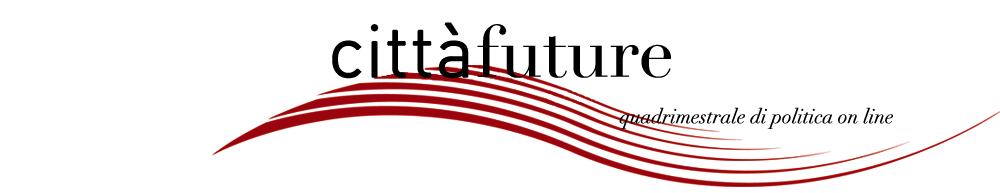La città dell'uomo
SPAZIO ED ESPRESSIONE
Partecipazione
urbanistica, esperienza chiusa o possibilità aperta?
Alessandro D’Aloia
Luogo e soggettività
Riprendiamo con questo numero della
rivista il discorso della rubrica
La città dell’uomo inaugurata con l’articolo
False città apparso sul numero 05 di Settembre 2011. Si tratta non
solo di fare il punto relativo ai problemi dello spazio nella società
contemporanea ma anche di intersecare i discorsi possibili su questo
tema, con altre problematiche affrontate lungo il percorso delle
Città Future fin qui svolto. In particolare, prima di trattare
dell’argomento specifico di questo articolo, risulta opportuno accennare
brevemente al perché si ritiene il tema della città e più in generale
dell’ambiente, o dello spazio esistenziale, qualcosa degno di
riflessione. Nell’editoriale del numero precedente si poneva la
questione della de-materializzazione dello spazio e della compressione
del tempo, alla cui base ci sarebbe l’accelerazione dell’esperienza
umana nell’epoca della comunicazione elettronica cui la contemporaneità
sottopone gli eventi che la caratterizzano. Il ritmo infernale con il
quale la coscienza individuale viene bombardata dall’esterno ha
l’effetto di disancorare certezze, riferimenti, e obiettivi. L’edificio
di dati acquisiti nel tempo è sottoposto ad una radicale
ristrutturazione in cui nulla degli antichi capisaldi permane come base
dell’avvenire. Una delle caratteristiche della condizione presente è
data dalla sospensione, dalla incompiutezza dei processi e
affievolimento di ogni intenzione iniziale. In sostanza ogni volontà
espressa non dura il tempo necessario alla propria materializzazione ed
in genere gli obiettivi iniziali diventano vecchi durante lo svolgersi
dei percorsi che essi stessi richiedono, restando per lo più abbandonati
nello stato di tentativi che non hanno neanche la possibilità di
fallire. In un quadro di questo genere è inevitabile che la soggettività
si ritrovi permanentemente disancorata da riferimenti che mutano in
continuazione. Il senso dell’immateriale e dell’evanescenza domina il
nostro ambiente sociale. Se c’è stato un tempo in cui il lavoro forniva
quantomeno un orizzonte d’ancoraggio all’identità dell’individuo, oggi
non si sa più chi si è anche perché, nella maggioranza dei casi, non si
sa più che senso ha quello che si fa per vivere. Potremmo dire che
l’identità individuale derivante dall’occupazione è divenuta un
privilegio per una cerchia sempre più ristretta di “soggetti”, mentre
per il resto neanche il lavoro può più parlare per loro. Allora cosa
parla per te e di te, se non le tue scelte circa gli oggetti di cui ti
circondi? Una pubblicità di una nota casa automobilistica dice che “noi
siamo ciò che scegliamo” e per questo noi siamo la “nostra” merce, la
nostra automobile, il nostro cellulare, il nostro vestito e persino le
nostre applicazioni per l’i-phone. Senza merce niente soggetto, il che
equivale a dire che il soggetto è diventato una produzione industriale.
La coscienza non cessa di cercare
identificazione, e lo fa laddove pensa di poterla trovare. Se prima la
costruiva su terreni comunque poco sicuri (ma edificabili) oggi la fonda
sulle sabbie mobili.
Ma cosa resta al di là del lavoro prima
e della merce poi, come base per un riconoscimento di se stessi? Esiste
in tutto questo mutamento coatto ed iper-accelerato, qualcosa che invece
permane alle burrasche quotidiane che spazzano la coscienza individuale?
E c’è una modalità diversa dalla semplice scelta per potersi esprimere?
Giancarlo De Carlo, che rappresenta il
riferimento teorico di questo articolo[1], diceva che:
Inconsciamente o consciamente si comincia a riconoscere che non si
può fare ameno delle coordinate spaziali, perché sono le ultime difese.
L’ambiente è
l’unica cosa in cui riusciamo ancora a riconoscerci, perché il resto sta
diventando incorporeo, non ha più materia: solo lo spazio fisico ha
materia, solo la città, la campagna, solo l’ambiente, solo le case hanno
materia[2].
Si delinea quindi uno scenario, di
problematica speranza, in cui al di là della mercificazione dell’io, non
resta che lo spazio, l’ambiente urbano o extra-urbano che ci circonda.
Il problema è però che non si può acquistare (scegliere) un ambiente
urbano o un territorio al supermercato come si fa per qualsiasi altro
oggetto. Anche affrontando l’enorme impresa dell’acquisto o della
costruzione della propria abitazione, ad esempio, non si incide che su
uno spazio infinitesimo di ambiente che ci circonda. Per questo le
nostre “coordinate spaziali” possiamo solo subirle o costruirle
(certamente non sceglierle), intendendo per “costruzione” anche la
modifica possibile su di esse, in meglio o in peggio, e nello stesso
tempo questa “costruzione” è operazione che non può ritenersi in nessun
modo “individuale”. La definizione delle coordinate spaziali della vita
è nel migliore dei casi solo una possibilità di “partecipazione” ad un
discorso corale. C’è sempre uno spazio di vita, ma soprattutto nel caso
dello spazio urbano, esso non è mai un dato naturale, ma all’opposto il
frutto dell’azione diretta dell’uomo sulla natura, quindi il frutto di
opere successive nel tempo compiute lungo il percorso della civiltà da
parte di un numero significativo di attori. Questa “stratificazione”
successiva crea le condizioni ambientali presenti in cui alla fine tutto
si svolge e nella sua persistenza temporale forma un contesto per la
soggettivazione collettiva in grado di fornire un quadro di riferimento
anche all’individuo. Aldo Rossi, altra personalità di spessore teorico
in campo architettonico, parlava infatti nel suo testo
L’architettura della città di “memoria collettiva”, analizzando le
leggi della struttura materiale di tale memoria, individuata appunto
nella città. Questa essendo costituita di “fatti urbani”, presenta nel
percorso della propria evoluzione storica, da un lato parti nuove
appartenenti al presente di ogni epoca successiva e dall’altro
“permanenze” appartenenti invece al passato di ogni epoca, le quali in
ragione di questa loro profondità temporale presentano la capacità, ad
un tempo, di caratterizzare l’unicità di un certo contesto urbano e un
particolare tipo di esperienza collettiva ad esse legata. I fatti urbani
permangono e tanto più saldamente quanto più velocemente tutto il resto
muta.
Il “tempo architettonico” si oppone per
statuto alla velocità crescente delle mutazioni contestuali alla
coscienza individuale. Un fatto di pietra, di cemento oppure di acciaio,
perdura per lunghi periodi, a volte eccezionalmente lunghi (nel caso dei
monumenti) ma comunque quasi sempre più longevi di chi presiede alle
decisioni che stanno allo loro origine. L’architettura sopravvive sempre
ai propri ideatori ed esecutori e costituisce una materializzazione
dell’operato umano che comporta conseguenze di lungo periodo per più di
una generazione. Nient’altro sembra possedere questo stesso potere.
È evidente che anche i fatti urbani sono
soggetti ad un’accelerazione incredibile della propria dinamica sotto la
pressione fortissima delle leggi di mercato e che il capitalismo ha
determinato quantitativamente una porzione incredibilmente estesa di
ambiente tanto da condizionare la vita di molte generazioni e di
miliardi di persone, ma neanche esso sembra avere il potere di
cancellare nel giro di qualche decennio quanto realizzato, nel bene e
nel male, in due secoli di sviluppo vertiginoso e caotico. Ogni fatto
urbano presente è, positivamente o negativamente, un condizionamento per
le generazioni future.
Linee melodiche soliste o sezioni
armoniche corali?
Allora sembra chiaro che tutto quanto
concerne la conformazione dello spazio fisico è questione di rilievo
sociale, anche se invece sembra che possa essere trattato, come ogni
altra cosa, in modo settoriale, affidato ad esperti della forma e dello
sviluppo urbano e determinato da esigenze particolari e contingenti di
chi investe risorse in esso.
Alla fine, secondo questo schema
dominante, sembra normale che lo spazio fisico sia definito e
determinato da una serie successiva di fatti urbani contingenti decisi
da un numero di attori (magari anche numeroso) ma comunque infinitamente
limitato rispetto a quanti saranno, in un modo o nell’altro, coinvolti
dalla presenza nello spazio di tali fatti. Non è stato sempre così. È
noto infatti che prima dell’avvento delle specializzazioni e della
rigida divisione del lavoro capitalista, le costruzioni erano opera di
chi le avrebbe abitate, o più in generale, utilizzate. Era questo il
modo attraverso il quale le persone partecipavano alla definizione dello
spazio collettivo e che permetteva oltre alla partecipazione,
l’espressione individuale in un fatto urbano collettivo. Per questo
motivo chi viveva lo spazio urbano non ne era alienato. Persino nella
realizzazione di opere monumentali, in qualche modo dirette da grandi
personalità e commissionate da grandi istituzioni, per lo più il potere
temporale e quello spirituale, la popolazione aveva voce in capitolo.
«Si dice che Filippo Brunelleschi,
mentre lanciava la cupola di santa Maria del Fiore, discutesse con la
popolazione di Firenze che seguiva i lavori dalla piazza sottostante»[3].
Al di là comunque dei casi specifici sembra abbastanza evidente che
seppure già nell’antichità o nel medioevo esistesse una cerchia
ristretta (e quindi “professionale”) preposta alla progettazione e
direzione della realizzazione di grandi opere, queste costituissero, nel
tessuto urbano, l’eccezione rispetto alla regola dell’autocostruzione
residenziale, che rappresenta comunque, in ogni tempo, la parte
quantitativamente maggiore dello spazio urbano. Questo faceva sì che la
città fosse il risultato di un processo costruttivo largamente condiviso
e diretta espressione produttiva dei suoi abitanti.
È importante sottolineare che lo spazio
è, in potenza, un fondamentale supporto di “espressività socializzata”.
All’opposto oggi, l’utenza degli spazi
urbani è deprivata di ogni ruolo nella definizione della città, terreno
per scorribande di speculatori che dettano i fini e caste di specialisti
che lavorano al servizio dell’unica committenza quantitativamente
determinante. Chi mette i soldi decide tutto e qualsiasi apporto
professionale successivo è esterno al momento decisionale. L’estrema
parcellizzazione delle fasi lavorative non permette a nessuno degli
attori coinvolti nel processo realizzativo di conoscere l’insieme
dell’opera alla quale si contribuisce, eccezion fatta per la fase
progettuale che non può prescindere dalla conoscenza complessiva
dell’evento architettonico, ma che ugualmente non è in grado di mettere
in discussione i presupposti che stanno alla base del progetto. In più,
dato che il progetto non riguarda mai la città, ma solo sue singole
parti, ne consegue anche che proprio l’insieme urbano si configura come
somma di parti sconnesse, che sfuggono completamente alla valutazione
critica e collettiva. La città di oggi è come un puzzle infinito che non
restituisce però nessuna immagine definita, neanche se i pezzi risultano
tutti “incastrati”.
Si dirà che però c’è il piano regolatore
generale e la disciplina che ne governa la logica, l’urbanistica,
che assicurano il controllo pubblico su quanto si realizza in
città, ma pur ammettendo che questa visione rassicurante abbia qualche
concreto fondamento, è difficile nelle condizioni in cui agisce oggi la
pianificazione urbana, immaginare la sua libera ed autonoma agibilità.
Bisognerebbe allora chiedersi che senso ha parlare di urbanistica in un
mondo dominato dal mercato e dagli interessi privati e minoritari che vi
stanno dietro. In questo contesto la disciplina del governo razionale
del territorio si trasforma nel suo opposto, perdendo di vista i suoi
fini e lasciando sul campo solo un sistema intricatissimo di “vincoli” e
un supporto ideologico alla proliferazione di apparati burocratici di
ogni tipo.
Nel caso
dell’organizzazione dello spazio fisico, l’abolizione dei vincoli appare
creativa perché i vincoli nella generalità dei casi sono ottusi e perciò
vessatori, generano conflitti e richiedono energia, sono odiati da chi
specula sul territorio ma anche da chi non specula e vuole semplicemente
costruire quello che gli serve o cambiarlo per riadattarlo ai bisogni
mutati[4].
Finisce che tutti odiano i vincoli, e
che solo una ristretta cerchia di urbanisti ed amministratori li
difendano con l’argomento, che essi rappresentano l’unico argine alla
potenziale devastazione del territorio di cui il capitalismo è più che
capace. Purtroppo è difficile dare torto a chi sostiene questa tesi, ma
come non vedere che, in primo luogo, questa è una visione del tutto di
retroguardia rispetto ai problemi del territorio e, in secondo luogo,
che alla fine i vincoli esistono davvero solo per i comuni mortali? Come
non valutare che l’amministrazione territoriale, in quanto separata
rispetto alla comunità ed individuata in un corpo burocratico è per ciò
stesso soggetta, nel migliore dei casi, al condizionamento esterno da
parte di attori finanziari capaci di colossali pressioni economiche e
politiche? Come non osservare che l’ottusità del sistema di controllo
finisce per spingere sul medesimo versante di contrarietà ai vincoli sia
gli speculatori che gli abitanti e ancora più spesso a fare dell’abuso
edilizio l’unica possibilità concreta per il bisogno elementare
dell’abitare? Non è proprio questo meccanismo a generare il brodo
culturale in cui le destre pescano consensi appena spingono sul tasto di
una demagogia ultraliberista?
Allora la questione è: si può continuare
a parlare di utilità dell’urbanistica come disciplina senza rifondarne
profondamente la missione sociale? Chi è il “cliente” dell’urbanistica?
Benché la società
contemporanea sia più pluralistica di quanto non sia in passato, accade
che la gente comune venga sempre più esclusa dalle grandi decisioni. Nel
campo dell’organizzare e formare lo spazio fisico, dove un tempo ogni
essere umano era protagonista, nessuno può decidere non solo
come sarà la sua abitazione,
ma neppure dove potrà abitare.
Tutto è già stato prestabilito da chi controlla i suoli, indirizza
l’espansione della città, apre autostrade, distrugge foreste, inquina
[…]. Il problema è nella sua sostanza politico ma riguarda anche
l’architettura che a questo punto deve decidere se il suo
cliente è l’anonimo potere
economico o burocratico, oppure gli esseri umani che la esperiscono come
un’essenziale componente della loro scena ambientale[5].
In sostanza o l’urbanistica, intesa come
disciplina utile a prendere decisioni circa il governo del territorio,
diventa strumento di “espressione” diretta della collettività nel suo
insieme, oppure essa, in quanto mero dispositivo di controllo sociale,
non riveste nessun interesse per la gente comune, divenendo fortemente
“impopolare”.
Sistema aperto o chiuso?
Basti pensare alla formazione di un
qualsiasi piano regolatore cittadino, nel migliore dei casi la città
(cioè i giornali) ne dibatte per conoscenza, ma chi agisce davvero sulle
scelte? In che modo i cittadini possono intervenire sostanzialmente nel
processo decisionale? Quale strumento di espressione è loro riservato
nella formazione del piano? Il destino della propria città, entra nelle
preoccupazioni delle persone?
In tutto questo incredibile modo di
gestire i fatti urbani, quello che viene a mancare è il senso stesso
delle scelte. Secondo lo schema dominante, infatti, la finanza decide
“il cosa” e il pubblico decide, o si figura, di decidere “il come”,
mentre si perde completamente di vista “il perché”. Se questo vale per
la città, vale anche in generale per il territorio, per le
infrastrutture e così via. Ed è esattamente questo schema ad essere
entrato in cortocircuito nella questione delle grandi opere come il
ponte sullo stretto, oppure la vicenda, molto più avanti nella
realizzazione, delle Tav Torino-Lione, in cui al di là dell’opera in sé, ciò che è
finalmente in discussione è il senso stesso dell’operazione e perciò
anche il modo con cui si prendono le decisioni che riguardano il destino
del territorio in generale. È questo il nodo politico della vicenda, ed
è proprio questa perenne “deviazione dal perché” che finisce per
collocare sistematicamente a valle dei processi urbani e territoriali il
capitale al posto dell’uomo come referente. In sostanza nulla si muove
più al fine di migliorare l’esistenza urbana delle persone, ma tutto si
fa o meno in funzione di un ritorno economico da parte di chi ha il
potere di governare le scelte e questo non solo nel caso della
Tav.
Si tratta di un sovvertimento completo dei fini stessi delle discipline
di conformazione spaziale. La città non è più uno spazio di vita, ma un
generatore colossale di profitti privati, di cui il pubblico (gli enti
territoriali) è semplice mezzo di realizzazione, che si accontenta di
costituirsi come mero “apparato di cattura” di quota parte del valore
derivante dai processi di costruzione ed urbanizzazione (oneri
concessori e tasse su redditi derivati). Questo è possibile a causa
dell’espulsione totale dell’utente finale dal momento decisionale. È
ancora De Carlo, in relazione all’evento architettonico, in generale, a
sintetizzare il meccanismo nel modo seguente:
l’architettura, che in teoria è un “sistema aperto”, diventa di
fatto un “sistema chiuso” quando uno dei suoi “sottoinsiemi” è mutilato
o adulterato da abusi di potere.
[…] Infine si può osservare che quando accade che il “sottosistema delle
decisioni” venga mutilato o sopraffatto, analoghe mutilazioni e
sopraffazioni si manifestano in tutti gli altri “sottosistemi” di cui il
“sistema” dell’architettura è costituito. […] l’imposizione dei valori
portati dal committente, condizionano decisamente un evento
architettonico: nell’impianto organizzativo, nella configurazione
morfologica, nelle scelte tecnologiche, nella manipolazione dei
materiali, nei rapporti con l’ambiente naturale, nella predisposizione
ai comportamenti dell’utente, perfino nelle decisioni circa la sua
impostazione strutturale e il suo equipaggiamento impiantistico.
[…] L’utente,
espulso dal “sottosistema” delle decisioni, non ha più ruolo nella
definizione del carattere dell’architettura. Ma anche l’architetto, dopo
l’espulsione dell’utente, finisce col trovarsi chiuso in una trappola
dal collo biforcuto, dove non gli resta altra scelta che accettare o
rifiutare[6].
Dunque l’espulsione dell’utente dai
processi urbani, finisce con il mettere l’intera disciplina in una
situazione difficile, dove anche ammesso che gli esperti di fatti
spaziali siano animati e guidati da forti motivazioni etiche è dubbio, e
allo stesso tempo iniquo, che essi “da soli” possano in qualche modo
garantire esiti positivi delle operazioni immobiliari in cui sono
coinvolti. In queste condizioni si finisce, nel migliore dei casi, a
“rappresentare” un interesse collettivo, ma senza alcuna verifica
condivisa delle ricadute delle proprie scelte “tecniche”. È evidente che
il sapere tecnico non può che farsi portatore delle istanze che dominano
immancabilmente i processi urbani ed è così che si realizzano infiniti
esempi
di come una
minoranza possa sfruttare il territorio a svantaggio della maggioranza e
anche di come l’urbanistica possa esercitare un ruolo di copertura dello
sfruttamento facendo apparire progressivi interventi che dovranno
rivelarsi densi di conseguenze nella sostanza negative[7].
La partecipazione si configura quindi
come l’unica possibilità ad un tempo della disciplina urbanistica ed
architettonica e dell’utenza finale degli eventi urbani, di uscire da
questo “collo di bottiglia” rappresentato dall’attuale configurazione
chiusa del sistema di definizione dello spazio.
Partecipazione o cooptazione?
Ma cosa si intende quando si parla di
“partecipazione urbanistica”? Si tratta di uno fra tanti sistemi di
costruzione artificiale del consenso attorno a scelte calate dall’alto,
e in tal caso sarebbe meglio non perderci proprio del tempo, oppure di
uno strumento di efficacia concreta per la discussione sullo sviluppo e
sul futuro della città e del territorio?
De Carlo, che oltre ad aver sperimentato
concretamente l’esperienza della partecipazione, ha anche valutato
criticamente quanto praticato, pone una precisa condizione affinché ci
si possa aspettare qualche cosa di positivo dalla partecipazione.
Il “sistema” dell’architettura è oggi modellato dalla prevaricazione del
committente; di chi ha il potere – nell’organizzazione capitalistica o
nella burocrazia di Stato – e perciò controlla le risorse, i
finanziamenti, la produzione, l’educazione, l’informazione, ecc. Se
l’architetto non accetta questa situazione e gli si rivolta contro,
allora di fatto si estrania e provoca un conflitto […].
È irrilevante che
l’architetto vinca o perda nel conflitto che suscita quando rivendica le
prerogative della sua “individualità” perché si perviene ad un reale
successo soltanto quando l’intero “sistema” architettonico e tutti i
“sottoinsiemi” che lo compongono raggiungono uno stato di totale
compiutezza, coerente con gli scopi fondamentali del processo
architettonico. Uno stato di totale compiutezza […] implica la radicale
ristrutturazione del “sottosistema delle decisioni”, quindi la
riconferma dei diritti dell’utente, quindi la coincidenza tra utente e
committente: nel senso che l’utente diventa lui stesso committente.
Questa sembra la condizione necessaria più importante per portare
l’architettura ad essere un “sistema aperto”[8].
Ma che significa “coincidenza fra
committenza ed utenza” in termini pratici? Nient’altro che un differente
contesto sociale e culturale per il sistema dell’architettura, in cui
siano i bisogni della popolazione e non del mercato a dettare le linee
di intervento, eventualità che equivale a riposizionare l’uomo al centro
del sistema produttivo mediante il potere non solo di decidere cosa si
realizza, ma di elaborare proprie proposte e perciò una propria visione
attiva circa l’utilizzo del territorio.
Non si può
escludere, e anzi si può assumere come limite veniente, che in futuro il
processo della progettazione dell’ambiente fisico possa essere
interamente governato dalla collettività: che lo svolgersi delle fasi,
dalla elaborazione delle decisioni alla creazione delle configurazioni
formali, possa compiersi attraverso una sequenza di scelte, verifiche e
invenzioni, capace di autoregolarsi all’interno di un confronto
polifonico continuo. A quel punto l’ambigua e insidiosa funzione degli
specialisti (dell’architetto) verrebbe esautorata. Ma si tratta di un
punto assai lontano il cui tempo di raggiungimento dipende non solo
dalla velocità della trasformazione libertaria della società ma anche da
quanto rapidamente l’esercizio della libertà potrà distruggere le
barriere di alienazione erette dell’esercizio del potere[9].
Ma se la partecipazione urbanistica
fosse realizzabile solo, a cose fatte, cioè percorribile solo in una
società già trasformata, faremmo l’errore di considerarla come mero
strumento settoriale, utile al più a consentire la partecipazione della
popolazione alle decisioni di tipo urbanistico il giorno in cui la
democrazia avrà trovato per suo conto un diverso modo di essere
praticata, senza considerarla invece come potenziale strumento attivo di
“transizione”, capace cioè, come pratica operativa, di innescare a sua
volta la transizione necessaria verso un futuro in cui l’uomo possa
considerarsi produttivo nei confronti del proprio destino in generale.
Infatti la sensazione è che il tema della partecipazione al destino
urbano sia una questione di estrema attualità (come dimostra la vicenda
della Tav), anche se non
sembrerebbe, proprio in un momento in cui la crisi finanziaria
(innescata proprio a partire dal bisogno di abitare delle classi
subalterne americane) determina un avvitamento su se stessa della
consueta attività umana sul territorio, crisi che si potrebbe
sintetizzare mediante l’evidenza di un sistema costruttivo, concentrato
soprattutto in grossi eventi architettonici e infrastrutturali, che
mentre edifica milioni di metri cubi destinati a restare vuoti, o grosse
opere senza utilità evidenti, non è più in grado di offrire spazio
abitabile alla società. A ben vedere questo significa nient’altro che
l’espulsione dell’uomo dalla città e non metaforicamente. Oggi quasi
nessuno può permettersi neanche più di indebitarsi a vita per avere un
tetto, eppure i tetti esistenti basterebbero ad accogliere tutti, pur
continuando a non farlo. I centri si svuotano e le periferie si
allargano nel degrado crescente. Intanto “la colata” continua, ma non si
capisce davvero per chi. Si pone per questo un doppio problema da
risolvere, un primo di mera ragioneria (quanto tetti, quante persone),
un secondo di qualità dello spazio (che tipo di spazio immaginare per
una società non annichilita sulla claustrofobia della cella/prigione e
del ciclo lavoro-riposo), ma nessuno dei due risolvibile decisamente
senza mettere in discussione lo schema dominante di conformazione e
assegnazione dello spazio ai componenti della società. È del tutto
evidente che nessuna aderenza fra esigenze di vita individuali e
collettive possa trovare compimento senza diretta partecipazione della
società nel suo complesso al problema dello spazio. E dato che si tratta
di una questione basilare per l’esistenza, si può percepire come
probabilmente la rimodulazione del processo edificatorio sociale
contenga in sé i caratteri salienti di un diverso sistema decisionale
relativo all’intero funzionamento della società stessa. In altre parole
il problema aperto dell’abitare (inteso in senso lato) è probabilmente
uno dei terreni a partire dal quale sarà possibile intravedere modi
diversi di dare obiettivi concreti all’attività dell’uomo in generale,
nella consapevolezza che nessun obiettivo che non sia anche largamente
condiviso possiede oggi la forza per essere accettato. Di passata non
sarà inutile osservare che la città non ha solo bisogno di crescere,
anzi, mentre ha molto bisogno di essere migliorata, aggiustata,
adeguata, curata e questo è un lavoro molto più vasto della costruzione
di un nuovo quartiere, una nuova opera o una nuova strada. Insomma
mentre il lavoro si smaterializza sembra proprio che ci sia,
all’opposto, molto da fare materialmente e molto vicino a noi. Altro che
ricerca o creazione di nuovi mercati.
Esperienze di partecipazione urbanistica
Ma come può essere immaginato
praticamente un processo di coinvolgimento pubblico dei diretti
interessati nella discussione sui destini della propria città? Sarà
utile a questo punto riportare la descrizione che De Carlo fa di una
delle prime esperienze di pianificazione partecipata alla quale, da
pioniere, egli prese parte. Si tratta dell’occasione della redazione del
piano per il nuovo centro di Rimini nella prima metà degli anni ’70.
Si è cominciato con
una serie di incontri aperti a tutti i cittadini nell’Arengo comunale. I
temi affrontati si riferivano all’analisi critica delle varie componenti
che costituivano il sistema territoriale riminese. […] Per ogni soggetto
di analisi l’ottica era sempre costante: quale uso veniva fatto dei vari
sottosistemi territoriali da parte delle varie categorie di utenti;
quali categorie di utenti avevano ricavato e continuavano a ricavare
vantaggi dalle successive trasformazioni di ciascun sottosistema e del
sistema complessivo, e quali invece ne avevano ricavato esclusione e
sfruttamento. […] Il successo degli incontri era enorme. La sala del
consiglio comunale così spesso disertata (e non solo a Rimini, di certo)
dai cittadini assuefatti a arzigogolate elucubrazioni della politica
internazionale, era straboccante di operai, intellettuali, impiegati,
professionisti, studenti e perfino contadini, appassionatamente
interessati a un discorso nuovo sul reale significato della loro città e
del loro territorio. […] Il problema del futuro della città e del ruolo
che il nuovo centro avrebbe dovuto svolgervi ha assunto una concretezza
che non avevo mai prima sperimentato: il discorso urbanistico è
diventato quello che sempre dovrebbe essere e cioè un aspetto
particolare e specifico di un discorso politico più generale dal quale
non può scollarsi senza diventare regressivo e accademico, senza perdere
la carica di immaginazione che gli è indispensabile.[10]
Nessuna delle esperienze riportate da De
Carlo è terminata nei modi attesi, per il semplice motivo, che la
portata della partecipazione urbanistica, quando fatta seriamente, è
tale da trascendere sempre il carattere specifico del proprio ambito e
tirare in ballo problemi ben più ampi, direttamente legati al
funzionamento stesso della società data.
L’ultima condizione[11]
– della partecipazione degli utenti – forse non era stata interamente
capita. Anzi all’inizio può essere stata intesa come una delle tante
astuzie dell’architetto per cooptare i vari destinatari del suo progetto
portandoli a decidere su aspetti di dettaglio per far passare
inosservate le decisioni di fondo prese da chi finanzia e amministra. Ma
presto tutti dovevano accorgersi – tra stupore e malumore – che si
sarebbe fatto sul serio, e la partecipazione a un evento architettonico
ha forza contagiosa, che la spinge a diffondersi anche nelle sfere
ineffabili della gestione del potere economico e politico.[12]
Ma al di là del rapporto fra politica e
disciplina la riflessione teorica, direttamente mutuata dall’esperienza,
di De Carlo sulla partecipazione urbanistica dà spunti di interesse
anche su aspetti collaterali del fare umano. Nell’esperienza di Terni
infatti il processo partecipativo, fino a quando si è realizzato con
successo, ha dato risultati positivi anche sul piano formale e della
migliore aderenza fra bisogni e spazio conformato, al punto che la
varietà di soluzioni di alloggio messe in campo, sarebbe stata
inimmaginabile senza il confronto fra “esperti” e utenti finali, a
dimostrazione che è il processo creativo stesso ad attingere dalle
maggiori risorse di immaginazione che una modalità di collaborazione
collettiva è in grado di offrire rispetto ad un approccio più
“autoriale”[13]. E piuttosto che
mettere la firma all’opera è importante che sia il risultato a
guadagnarne. Questo tipo di impostazione è lontana anni luce, ad
esempio, dallo spazio-marketing
affermato oggi, quando anche interventi consistenti vengono affidati
esclusivamente a “tecnici” che vengono sempre da troppo lontano per
poter avere un qualche interesse all’impatto concreto delle loro opere
sul funzionamento della città che le accoglierà e i quali spesso mettono
la loro firma su operazioni del tutto improntate alla logica della pura
spettacolarizzazione dell’architettura, per non dire altro.
Ma un'altra riflessione riguarda anche
la relazione stretta che esiste sempre tra forma costruita e “regime
giuridico” dello spazio conformato, al punto che gran parte della
qualità degli spazi e delle relazioni sociali che essi permettono o
negano sono determinate dalle premesse generali da cui gli “eventi
architettonici” sorgono.
Purtroppo questo coinvolgimento è andato attenuandosi man
mano che l’operazione si avviava al termine – soprattutto quando gli
utenti sono stati esclusi del controllo dell’economia del cantiere nel
nome di una loro presunta incompetenza tecnica – e ha avuto il colpo di
grazia quando è stato deciso che gli alloggi sarebbero stati ceduti in
proprietà, anziché in affitto. Era stata messa a punto una procedura
assai complessa per determinare un modo di affitto che garantisse
l’affittuario sia in termini di diritto all’uso dell’alloggio che in
termini economici, lasciando all’azienda la proprietà, e quindi anche i
costi di manutenzione. La procedura era stata discussa e aveva convinto
sia la direzione che i consigli di fabbrica; senonché inopinatamente la
Cisl alzava la bandiera della proprietà e la Cgil, temendosi scavalcata,
gliela strappava di mano facendosene l’alfiere. Così ogni altra ipotesi
venne accantonata e gli utenti diventarono proprietari prima ancora che
gli alloggi fossero finiti. Da allora si cominciò a parlare di elevare
recinzioni, di sezionare i percorsi pedonali per trasformarli in
balconi, di eventuali diritti di sopraelevazione. Ma la cosa più grave è
che da allora si aprì un baratro tra il gruppo di operai che avrebbe
posseduto l’alloggio e quello ben più numeroso di coloro che avrebbero
dovuto aspettare a lungo: venne a cessare così la spinta di solidarietà
che aveva portato al successo l’operazione.[14]
Qui De Carlo spiega in altri termini ciò
che abbiamo già indicato come differenza fra “spazio striato” e “spazio
liscio”[15], rendendo palese
anche come questa diversa qualità dello spazio, pur nell’ambito dello
stesso oggetto architettonico, sia in strettissima relazione, da un lato
con la questione della proprietà, dall’altro con lo “spirito” che anima
tutta una visione del rapportarsi agli altri nell’esperienza della vita
urbana, rappresentando una connotazione essenzialmente in grado di
invertire completamente il segno dell’operazione architettonica e delle
relazioni umane che essa è in grado o meno di instaurare.
Per un’utilità sociale delle discipline
di conformazione spaziale
Prima di concludere però, sembra
opportuno rimarcare, come la pratica della partecipazione possa
rappresentare oggi, pressoché l’unica possibilità rimasta a disposizione
delle discipline di conformazione dello spazio, per tentare di
recuperare un loro ruolo sociale che altrimenti non sussiste che in via
del tutto marginale. Le masse di nuovi “esperti” che l’università sforna
ogni anno, impreparate rispetto alle enormi difficoltà di un contesto
culturale completamente supino al mercato e alla burocrazia, oltre che
votato ad una totale incultura riguardo ai concetti di qualità e di
aderenza delle scelte ai bisogni concreti delle persone, non avranno
altro modo di operare se non auto-costruendo preventivamente le
condizioni per riconquistare il terreno di un interesse attivo verso la
città concreta, fatta di case, di luoghi pubblici, di quartieri, di
centri storici e di periferie, ma soprattutto di persone che ci vivono.
Nessun mercato e nessuna istituzione starà lì ad offrire la possibilità
di espressione individuale alla capacità di ogni nuovo esperto pronto e
voglioso di operare. Allora questo spazio va conquistato e riconquistato
ogni volta e siccome nulla risulta conquistabile individualmente, ogni
nuova “figura professionale” sfornata dall’accademia dovrà rieducarsi al
confronto nell’obbiettivo di conquistarsi un’agibilità rispondente alla
propria formazione. Nessun progetto, per quanto geniale, ottiene solo
per questo il posto che merita e la conseguente possibilità di
realizzazione, al contrario, ogni progetto, per essere tradotto in
evento materiale, deve saper diventare uno strumento di pressione
politica e ciò è impossibile senza costruzione condivisa dello stesso.
Allora un territorio, una città, un quartiere bisognoso di intervento
deve essere capace di esprimere da sé le proprie necessità e le proprie
proposte progettuali. Gli esperti, se vogliono avere un ruolo, devono
mettersi al servizio di questo tipo di istanze, elaborare griglie di
proposte mai già definite (individuare problemi piuttosto che fornire
soluzioni), sottoporle ai diretti interessati, da pari a pari, per la
loro definizione, il che significa, allo stesso tempo, costruire il
supporto sociale a tali proposte, mediante il quale fare pressione
politica sulle amministrazioni territoriali. Ogni progetto è una lotta,
una costruzione collettiva e un obiettivo politico oltre che l’occasione
di migliorare l’esistente. Se non si intraprende questo tipo di modalità
operativa, le opposizioni ai disegni del potere sul territorio, non
potranno che restare in una dimensione di pura negazione e di semplice
resistenza, ancora incapaci di elevarsi sul piano dell’espressione
attiva di una propria visione autonoma, anche questa tutta da costruire,
del territorio e della città.
APRILE 2012
[1]
Autore di numerosi scritti, parte dei quali raccolti nel testo a
cura di Livio Sichirollo,
Giancarlo De Carlo. Gli spiriti dell’architettura. Editori
riuniti, 1992, il quale costituisce la fonte del presente
articolo. Come architetto ha realizzato molte opere e piani
regolatori, fra i quali quelli per Urbino, nell’ambito del quale
ha progettato e realizzato la nota cittadella universitaria.
[2]
De Carlo, cit., pag. 201
[3]
De Carlo, cit., pag. 240
[4]
De Carlo, cit., pag. 15
[5]
De Carlo, cit., pag. XVI
[6]
De Carlo, cit., pag. 242
[7]
De Carlo, cit., pag. 269
[8]
De Carlo, cit., pag. 244
[9]
De Carlo, cit., pag. 232
[10]
De Carlo, cit., pag. 274
[11]
Posta dall’architetto per l’accettazione dell’incarico.
[12]
De Carlo, cit., pag. 313
[13]
«Nella prima fase di attuazione, […], la definizione delle
abitazioni ha fatto parte del processo di partecipazione. Sulla
base di una prima classificazione dei bisogni, messa a punto con
tutti gli utenti potenziali, si è pervenuti alla definizione di
cinque diverse cellule, ciascuna composta di tre nuclei diversi
ai tre diversi piani; per cui si sono ottenute complessivamente
quindici soluzioni alternative. Successivamente, con gli utenti
reali (che si era riusciti a far designare quando le costruzioni
erano ancora al rustico) è stata messa a punto una seconda
classificazione di bisogni che ha portato ad introdurre ancora
tre varianti all’interno di ciascun nucleo. Si è perciò arrivati
a poter disporre di quarantacinque soluzioni alternative per i
duecentocinquanta alloggi che si stavano costruendo. […]. La
partecipazione degli utenti è stata costante lungo tutto il
percorso che ha portato alle decisioni sulla struttura e sulla
forma dell’evento che si stava progettando». De Carlo,
cit., pagg. 315, 316
[14]
De Carlo, cit., pagg. 317, 318
[15]
Cfr. False Città sul
numero 05