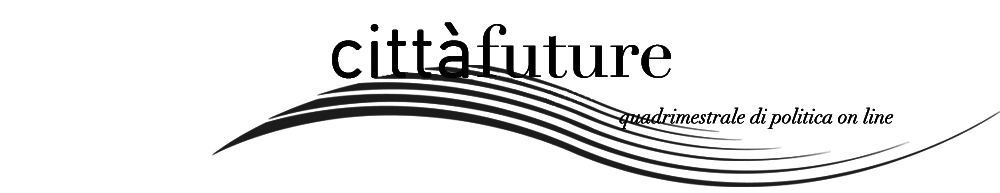Esperienza e rappresentazione
ESPERIENZA E RAPPRESENTAZIONE NEL MONDO SENZA TEMPO
Il dibattito
Giulio Trapanese
Riportiamo qui la trascrizione, con
alcune correzioni e aggiunte del dibattito avutosi al termine del
seminario del Maggio 2011, Esperienza e rappresentazione nel mondo senza
tempo. Riportiamo alcuni degli interventi più significativi di quella
giornata tra cui, nell’ordine in cui compaiono, quelli di Raffaele De
Stasio, Vincenzo Del Core, Anna Fava, Nanni e le relative risposte. Con
questo testo concludiamo la serie degli interventi pubblicati relativi
al seminario.
Raffaele:
La mia domanda riguarda, anzitutto, il modo in cui credi di procedere
con questa ricerca. Per quanto il discorso abbia, senza dubbio, dei
tratti apocalittici, credo, però, esistano e vadano cercate le
contraddizioni interne al sistema che hai descritto. Tra i vari concetti
messi in campo esistono passaggi logici quasi immediati, e alcune
contraddizioni possono essere sviscerate meglio.
Giulio:
Posso dirti che al momento attuale è la prima volta che propongo questo
discorso ad un pubblico; qualche mese fa scrissi un articolo su
Città future dal titolo
appunto Esperienza e
rappresentazione nel mondo senza tempo, ma quel testo rappresentò
più un inizio e un insieme di spunti suggestivi, lo considero un germe
di pensiero, più che uno studio compiuto. Al momento non so, o non so
ancora, come continuare la ricerca. Spero comunque di averne la
possibilità, e di trovare il tempo e il modo di riuscirci.
Quello di cui sono, tuttavia, fermamente
convinto è che una tale ricerca andrebbe svolta in modo collettivo;
diciamo alla maniera di come ci organizziamo con la rivista
Città future o, anche, di come
stiamo provando, con difficoltà, a muoverci con quest’associazione
Scuola critica.
Il discorso sul presente è un discorso
complesso; e non solo, forse, perché è la nostra storia. Tra coscienza
ed interpretazione, da un lato, e realtà storica, dall’altro, si va
disfacendo lo stretto nesso che sussisteva fino a qualche anno fa. Sarà
anche perché siamo europei e l’Europa e le categorie su cui noi ci
fondiamo non sono più le categorie “del
mondo” (d’altro canto la terza rivoluzione industriale è la prima
non “europea”), sarà che la realtà, intesa come forma informatica del
mondo attuale, presenta un tempo altro dai tempi del nostro pensare
tradizionale; fatto è che non riusciamo (o riusciamo solo per pochi
momenti) a soffermarci in una data interpretazione del reale e ad
approfondire quella. Tutto ci sfugge, ma soprattutto tale fuggevolezza
non costituisce più un problema.
Già parlare di collettivo al lavoro,
forse, può apparire antiquato, superato. Quando si dice oggi di fare le
cose insieme, s’intende principalmente di farle “in
connessione” gli uni con gli altri, di creare una rete; chiaramente,
tuttavia, ciò non significa farle insieme. Significa, soprattutto,
invece, scambiarsi informazioni, o mettere insieme pezzi prefabbricati
di lavori di individui isolati gli uni dagli altri. Significa sostituire
ai vecchi concetti di individuo e di gruppo, la nuova configurazione
della rete.
Quindi, discorso collettivo sì; tuttavia
essendo consapevoli dell’ambiguità che riveste questo discorso per noi,
oggi, inseriti come siamo nella società della comunicazione e
dell’informatica.
Credo di poterti rispondere, quindi,
dicendo che personalmente ho delle linee di sviluppo in mente per questa
ricerca, così come credo che alcuni dei collaboratori della rivista e i
membri di Scuola critica
abbiano delle loro; e sono convinto che in giro per il mondo ci sia chi
discute di queste cose; ma credo, pure, che il destino della ricerca
sulla trasformazione repentina di alcuni tratti dell’esperienza umana
dipenda molto dalla forza e dalla debolezza interiore di chi si sta
volgendo a pensare a queste cose, da quanto il dolore inconsapevole per
la perdita dell’umano non sia più forte della volontà di comprendere
cosa stia accadendo.
Vincenzo:
Io, invece, rispetto ad uno dei temi, in particolare, che tu hai
trattato, la virtualità intesa come astrazione dall’esperienza, ti
chiederei di porlo, se possibile, in connessione con la più ampia storia
del capitalismo. A me sembra esserci una certa relazione fra i due…
Giulio:
È una domanda difficile, anche perché presupporrebbe un’essenza unitaria
presente fin dall’inizio in un fenomeno, invece, complesso e variegato
(in quanto fenomeno storico) quale è il capitalismo. Direi, quindi, sia
difficile desumere dalla natura immateriale (cioè informatica) della
rivoluzione industriale in corso, uno spirito primordiale di tale natura
già nel primo capitalismo. D’altro canto se pensiamo al carbone, oppure
alla siderurgia o alla trasformazione del petrolio nei suoi derivati, è
difficile sostenere che il capitalismo sia andato sviluppandosi sul
binario dell’astrazione dalla materialità del mondo. Tuttavia, se una
connessione vogliamo stabilirla (per quanto detta così non so se sia
corretto) dovremmo probabilmente introdurre, piuttosto, il concetto di
reificazione. Cioè la terza rivoluzione industriale pone le basi per una
nuova – ed ulteriore – forma di reificazione dei rapporti umani, la
rappresentazione del loro essere sociale su d’un piano virtuale
dell’esperienza, dove con virtuale dovremo intendere una riproduzione
simulata d’un’esperienza originariamente umana.
Vincenzo:
Che intendi con riproduzione simulata?
Giulio:
Penso al fatto che la virtualità (dal telefono cellulare agli ultimi
social networks) riproduce qualcosa che non è estraneo all’umano (ad es.
chiacchierare, scambiarsi notizie, mettersi in mostra, cercare un
fidanzato o fidanzata, fare politica), ma lo fa in una maniera simulata,
cioè imita un aspetto della relazione umana, lo traspone su di un piano
altro, astraendo dal fenomeno alcune determinate caratteristiche e
lasciandone da parte altre. Così facendo, e, cioè, fornendo una
traduzione della relazione umana, sostenendo tuttavia di riprodurla
semplicemente per come è, e magari su scala più ampia, finisce con il
dare della relazione una certa rappresentazione la quale, a sua volta,
diviene modello per ogni altra relazione. Per cui l’astrazione compiuta
a partire da un modello di base diviene essa stessa un modello
dell’esperienza che ne era all’origine, e, dunque,
tout court “ideale d’ogni
relazione”.
Non è nulla di così complesso e, d’altro
canto, non è una mia idea originale: si tratta di pensare a come la
nostra esperienza si riconosca ormai in una forma che è sempre più
“rappresentazionale”, cioè legittimata di diritto ad astrarre da alcuni
tratti cui siamo stati abituati a considerare essenziali rispetto
all’umano.
Vincenzo:
Ad esempio? Pensi al corpo?
Giulio:
Sì, ma non solo; adesso, ad esempio, pensavo solo al fatto che nessuno
si rende più conto che le parole sono solo la superficie del mondo, così
come della personalità di un individuo. O meglio, dovrei dire degli
individui, per come essi erano…
Vincenzo:
Cioè tu adesso consideri che le persone si siano trasformate… le vedi
come sola astrazione, parole, immagine di se stesse… e nient’altro?
Giulio:
No, o non solo. Però io credo che la trasformazione della relazione
umana dipendente dalla virtualità rischi di portare ad un vero e proprio
rimodellamento dell’umano, in cui l’esperienza condivisa non è più un
sentire insieme, ma un rappresentarsi da soli un certo significato del
mondo.
L’esperienza condivisa di due o più
individui contemporanei, temo, sia più prossima a quella di softwares
elettronici connessi fra loro che a quella di un gruppo di animali, ad
esempio, facenti parti di un branco… Qualcuno potrebbe aggiungere che
non è detto che sia peggio… io mi sentirei di rispondere che, forse, non
è né meglio né peggio, ma di sicuro esprime un senso dell’esistere molto
diverso da quello del passato.
Vincenzo:
Però bisogna dire che le macchine sono state create dagli uomini, quindi
in quanto prodotto umano, hanno un che di umano...
Giulio:
Sì, infatti, il problema non sono le macchine, o almeno non
lo sono quanto gli uomini che le creano. Cioè, lo studio delle
macchine semplicemente ci interessa in quanto esse sono il prodotto del
nuovo uomo. Bisognerebbe soffermarsi su questa simbiosi fra uomo e
strumento elettronico e guardare al fatto che a me sembra evidente che
la macchina elettronica “servendo” l’uomo, lo cambia e, come dicevo,
trasforma alcune delle sue funzioni essenziali.
L’uomo che si fa servire, per quanto da
strumenti che egli ha inventato, cambia la sua posizione nel mondo,
diviene inabile come soggetto, e, abdicando al suo ruolo,
progressivamente s’indebolisce, limita i suoi orizzonti, accontentandosi
solo di non estinguersi fisicamente, quando nei fatti, invece,
culturalmente lo sta già facendo…
Raffaele:
Io vorrei aggiungere un elemento che, in apparenza, è in controtendenza
rispetto a questo discorso. A me sembra che, almeno da un certo punto di
vista, il sistema attuale producendo umanità sulla base di
rappresentazioni, determini più che un appiattimento sulla realtà data,
uno slittamento continuo verso il piano delle possibilità. Sparendo la
realtà, dunque, tutto diviene possibile. Per essere propositivi
bisognerebbe capire se e come è possibile che gli individui si rendono
conto di questo processo…
Giulio:
Credo di poterti rispondere che non sopravvaluterei l’aspetto della
coscienza nel rapporto fra l’uomo e la società del suo tempo. Credo vi
sia piuttosto un rapporto di opacità, in cui solo raramente penetra un
po’ di luce. È difficile che una gran parte degli individui giunga a
realizzare cosa muova alla radice la società in cui vive; ma non è
questo, a mio avviso almeno, il punto. Si tratta di valutare quale sia
la disponibilità “istintiva” ad opporsi ad un certo stato di cose. In
particolare osservando quali siano, in una certa società, le diverse
forze in campo, i diversi gruppi e la consistenza delle loro idee, la
loro capacità di perseguirle, l’efficacia della loro organizzazione
etc... Questo in via generale…
In modo specifico, rispetto al nostro
mondo, credo che uno dei principali ostacoli all’assunzione d’una certa
consapevolezza sia da ascrivere, come ho detto, alla nuova forma di
intelligenza che si va diffondendo tra le nuove generazioni.
Un’intelligenza, come abbiamo detto, slegata dalla dimensione della
fisicità e della finitezza. Un’intelligenza, quella dell’uomo, ormai
artificiale, fondata quasi solo sull’associazione di rappresentazioni
già date, e incapace di porle a critica.
La creatività stessa dell’espressione è
così sottoposta a dura prova: basti pensare alla creatività connessa al
nostro parlare quotidiano. Nei filmati vedremo domani, ce n’è uno di
Pasolini (tratto dal suo film documentario
Comizi d’amore del 1965) in cui egli intervista alcuni siciliani. Ad un certo punto
uno degli intervistati, non riuscendo ad esprimersi correttamente, per
comunicare il suo pensiero inventa una parola. A proposito dei giovani
degli anni sessanta, per indicare la loro intraprendenza, pronuncia la
parola “prontismo”. “Oggi c’è più prontismo” dice, intendendo con questo
la maggiore intraprendenza della generazione dei giovani. Dunque,
all’assenza di un vocabolario completo egli provvede con una vera e
propria invenzione linguistica.
Raffaele:
Vorrei proporre ancora un’altra suggestione, che riguarda la
superproduzione di rappresentazioni. In
Uscite dal mondo, Zolla sostiene che il ricorso continuo di oggi al
piano della virtualità potrebbe comportare come effetto il
perfezionamento della capacità di elaborare le proprie esperienze
interiori, rendendo possibile un passaggio collettivo ad un livello più
alto di consapevolezza. Io credo che questa contraddizione che stiamo
analizzando fra l’esperienza e la rappresentazione, potrebbe anche, in
ipotesi, provocare una rottura del sensorio condizionato ed aprire ad
una nuova possibilità di sentire. Dunque l’iperproduzione che si fonda
su un flusso continuo di notizie, informazioni, potrebbe anche,
contrariamente a quanto sta avvenendo adesso, favorire l’instaurarsi di
un livello più elevato di coscienza sul mondo…
Giulio:
Devo dirti che il concetto di uscita o fuga dal mondo, per come mi
sembra la intenda Zolla non mi convince molto, né mi sembra – ma lo dico
a partire dalla mia esperienza – che la sovrapproduzione di
rappresentazioni stia portando ad un affinamento della sensibilità
comune.
Certo, è innegabile che un giovane
d’oggi abbia una capacità di tollerare un alto numero di informazioni (e
quindi di stimolazioni) più che un uomo del passato; e, pur tuttavia,
sono dubbioso che ciò sia qualcosa di più che una risposta d’adattamento
e che comporti un ispessimento reale della sua personalità. Diciamo pure
che tutto mi sembra vada nella direzione opposta, in quella della
semplificazione.
Detto questo, devo ammettere che
assistiamo a qualcosa che ancora non riusciamo a decifrare in modo
chiaro... c’è in atto un cambiamento radicale della vita che le stesse
“categorie di ieri” rischiano di deformare, nel tentativo di fornirne
un’interpretazione…
Vorrei ora porre alla vostra attenzione
un elemento ulteriore. Ricordo come Toni Negri in un’intervista del 2003
discutesse di come le forme della nuova tecnologia siano state frutto
del desiderio delle masse di instaurare forme nuove di comunicazione; in
base a ciò la rete di internet e l’informatica, in generale, sarebbero
sorte grazie all’espressione d’una creatività latente presente fra le
masse. In più circostanze, anche in alcuni suoi testi scritti, egli ha
esposto questa tesi. Vorrei dirvi che, per quanto interessante, non
sento di poter condividere questa posizione. Una cosa è, infatti, il
dato del desiderio di costruire nuove relazioni (ed anche nuove forme di
relazione) che infrangano i limiti oppressivi dei rapporti sociali
precostituiti dalla tradizione; altro è discutere il modo in cui
oggettivamente tali forme si siano venute creando, anche
indipendentemente dalla volontà dei singoli attori (ma non certo
indipendentemente dall’egemonia di pensiero dei ceti dominanti). E sulla
base di questo mi trovo in disaccordo con Negri.
Tornando alla tua domanda iniziale,
Raffaele, rispetto a come questa ricerca potrebbe proseguire, mi
sembrerebbe molto utile allora discriminare singoli campi di indagine,
anche un po’ ristretti, a che possano rendere bene il tipo di
trasformazione antropologica cui siamo di fronte. Mi viene da pensare a
volte a come sarebbe interessante svolgere uno studio sui tempi del
linguaggio quotidiano, prendendo in esame l’accelerazione in atto che si
verifica rispetto solo a qualche decennio fa. Il nostro discorso ha
interiorizzato il frame della
pubblicità; e mi sembra, d’altro canto, che noi oggi parliamo, nei
fatti, imitando la pubblicità...
Raffaele:
In effetti non è solo il frame tipico della pubblicità, è proprio la distruzione
dell’articolazione sintattica...
Ma vorrei anche aggiungere un elemento
che non è stato ancora approfondito. In Italia, come negli Stati Uniti,
il passaggio alla società dei consumi compiutosi in modo pressoché
definitivo a metà degli anni settanta, si pone lungo una linea di
continuità con l’epoca successiva, la nostra, caratterizzata dalla
tecnologia e dall’informatica. Dunque gli anni ottanta e novanta non
sono affatto caduti dal cielo, ma sono la prosecuzione di un processo
già compiutosi nella sua essenza negli anni settanta. Bisogna, dunque,
saper proporre un’analisi della realtà adeguata al cambiamento dei
tempi. L’uso, ad esempio, che la scuola di Francoforte fece della
psicoanalisi, oggi va integrato con i nuovi apporti delle neuroscienze,
le scienze biologiche e la psicologia sociale e del profondo. Questo
studio così articolato ci permetterebbe di comprendere anche meglio la
drammaticità della nostra condizione. Ci permetterebbe di giungere alla
consapevolezza che la colonizzazione oggi si va compiendo su tutti i
livelli dell’esperienza umana.
Giulio:
Sì, coscienti del fatto che alcuni aspetti dell’innovazione tecnologica
procedono a passi spediti. Oggi
facebook, ad esempio, utilizza un certo numero di applicazioni;
domani saranno il doppio.
Tra queste probabilmente spiccherà
quella che renderà possibile la localizzazione degli utenti connessi
tramite un telefono cellulare. In un prossimo futuro non solo potrò
leggere tutti i messaggi sulle bacheche virtuali dei miei contatti, ma
potrò anche sapere dove questi si trovano in un dato momento. Come
dicevamo, il mondo diviene sempre più qualcosa che mi è “a
disposizione”…
Raffaele:
D’altra parte il capitalismo se non espande il campo della propria
influenza non può continuare ad esistere, per questo il suo è un moto
perpetuo, continuo.
Inoltre, va sottolineata un’altra
questione: la questione demografica. Da quando si è affermato, con la
rivoluzione industriale, il trend dell’esplosione demografica, questo
non si è più fermato, e, nei fatti, oggi la questione demografica è uno
dei parametri essenziali per poter ragionare di società e politica. La
popolazione mondiale cresce perché sono aumentate la tecniche di cura
della salute, e si è innalzato il livello medio, ma cresce anche perché
è necessario alla produzione che cresca.
Giulio:
Fai bene a porre l’accento sulla questione demografica, perché è una
questione centrale; però credo non sia così sicuro che gli strateghi del
capitalismo mirino oggi ad una crescita demografica esponenziale.
D’altro canto è vero che rispetto al passato e alla civiltà contadina
c’è una gran differenza: anzitutto prima il tasso di mortalità infantile
era molto più alto, dunque concepire un figlio era una speranza, e non
una certezza; in secondo luogo un individuo non si sentiva mai del tutto
fuori luogo, “in più”, dal momento che le sue braccia potevano essere
comunque braccia di lavoro utili. La differenza con il mondo tardo
industriale fu messa bene in luce da Pasolini quando considerò alla base
del senso di colpa dei giovani degli anni settanta lo spaesamento di
essere di troppo, senza un posto nel mondo. Se fare un figlio in passato
poteva avere davvero il senso di mettere al mondo, cioè di donare una
vita nuova, oggi i figli…
Raffaele:
…i figli oggi sono maledetti.
Giulio:
Sì, nel senso che il mondo non ha bisogno di nuovi individui. L’umanità
non vive più ponendosi dei veri e propri compiti, e, dunque, non ha
bisogno che vi siano nuove generazioni che continuino e compiano l’opera
dei padri.
Raffaele:
Passando ad una discussione più specificamente politica, vorrei
chiederti di dire qualcosa in più rispetto alla differenza fra le
rivoluzioni di ieri e le possibili rivoluzioni di oggi, rispetto al tema
dello spazio, e del rapporto fra locale e globale.
Giulio:
Quello che intendevo è che un cambiamento storico del passato avveniva
necessariamente all’interno di un contesto circoscritto, determinando
solo successivamente, ed eventualmente, effetti su una scala più ampia.
Questo rendeva possibile (e necessario) un processo di mediazione delle
idee, e di assimilazione delle stesse da parte dei soggetti interessati.
Oggi tutto questo si pone in termini diversi, ed è difficile immaginare
oggi un processo analogo a quelli più classici che la storia ha
conosciuto. La realtà in cui viviamo sembra piuttosto presentarsi come
un insieme di tante provincie facenti capo ad un centro che, però, è
immateriale.
Raffaele:
Credo, d’altra parte, che dopo aver detto quello che stiamo dicendo, non
sia scandaloso considerare l’impossibilità della rivoluzione al momento
attuale.
Giulio:
Beh, bisognerebbe intendersi prima sul concetto di rivoluzione e cosa
intendiamo quando pronunciamo questa parola. In ogni modo, se teniamo
fermo il principio che esiste una contrazione degli spazi in cui si
coniugano esperienza politica e teorizzazione creativa, e in generale
una tendenza all’ibernazione della storia come processo culturale,
rimane da dire, certo, che una rivoluzione è difficile da immaginare.
Almeno una rivoluzione del sistema capitalistico in quel senso che fino
agli anni sessanta sembrava avere ancora una possibilità d’attuazione.
Una rivoluzione leninista, in quel senso lì, direi di no, se non altro
per il ruolo che può avere oggi un’ideologia o un partito.
Nella storia del Novecento lo stesso
concetto di egemonia ha subito un’evoluzione: quella classica, pensiamo
a Lenin, è quella di un gruppo o un partito che conquista con la sua
azione il popolo ad una certa visione del mondo e della politica. Questa
concezione è stata, in parte, corretta da Gramsci, il quale, anche nel
testo che vi ho riportato nella dispensa[1], propone in
effetti una teoria più complessa delle società occidentali. L’egemonia
oggi non si presenta nella forma di processo: il sistema in quanto
produttore di rappresentazioni, riesce ad astrarsi dalla storia e il
capitalismo non è più un sistema percepito storicamente. Su questa base
oggettiva, e non più, quindi, solo ideologica, esso fonda il suo
dominio.
Nanni:
Io vorrei, in riferimento anche agli eventi degli ultimi mesi del
Maghreb, sottolineare, invece, la centralità della questione della
comunicazione. Perché nonostante lo strapotere informativo di oggi, in
questi paesi si è creato un movimento che ha mantenuto una propria
autonomia. Allora io mi chiedo: è possibile trovare dei mezzi che
contrastino questo dominio incontrastato, trovare una prospettiva
alternativa? È possibile, cioè, utilizzare i nuovi mezzi di
comunicazione ai fini di scardinare questa chiusura dell’universo di
pensiero?
Giulio:
Nanni, ti rispondo osservando come negli ultimi anni ciascun attivista
politico sia divenuto al tempo stesso un media attivista, vale a dire è
impegnato a trasmettere immediatamente la propria esperienza al di là
della ristretta cerchia di persone che vi si trovano attorno. Deve
comunicare ciò che fa, altrimenti non esiste. Questa svolta è stata
necessaria per via del cambiamento degli ultimi anni. Sia nelle rivolte
maghrebine, che in piccolo, nelle mobilitazioni degli studenti italiani
di quest’ultimo Dicembre [2010 Ndr], abbiamo assistito chiaramente alla
necessità da parte del movimento in lotta di creare in modo autonomo la
propria rappresentazione mediatica.
Proporrei, a questo punto, un
approfondimento del piano strettamente politico. Con la democrazia di
massa, infatti, comincia a porsi la necessità di una diffusione
capillare di rappresentazioni in ogni ganglio della società. Nessuno
spazio può essere lasciato fuori dal campo del consenso politico. Nelle
nostre democrazie la partecipazione non è resa possibile attraverso la
distribuzione degli strumenti culturali necessari ad essa, ma è imposta,
sul modello del mercato, come inclusione degli individui nella sfera
della comunicazione; alla pari di come si è tirati dentro il circuito
dei consumi, così la politica democratica di oggi è uno spettacolo cui
siamo obbligati ad assistere. Ciascuno è obbligato ad avere un’opinione
su tutto.
Si capisce, ora, come internet si sia
inserito in questo quadro. E di conseguenza è facile concludere come la
partecipazione politica oggi non possa prescindere, per nessuno,
dall’utilizzare questo strumento e dallo stare dentro la rete. Così
chiaramente anche per i movimenti di protesta e di lotta.
La differenza che sussiste oggi rispetto
alla situazione di quaranta anni fa è enorme. Allora un partito politico
importante era in grado di convocare una piazza per una manifestazione;
come è evidente, invece, in questi ultimi anni i partiti hanno perso
progressivamente la capacità di essere avanguardia nei processi di
trasformazione sociale: essi sono costretti ad inseguire i processi che
accadono in società. Dunque, riguardo alle trasformazioni delle forme
della politica, sulla base di quanto detto finora, credo si tratti di un
cambiamento assolutamente maturo, e radicato in profondità nella nostra
società. Se, come si dice, oggi c’è una diffusione
rizomatica del potere (anche
se ciò andrebbe spiegato meglio), allora la resistenza anche deve avere
un carattere capillare e diffuso. Sicuramente internet offre a questo
riguardo opportunità interessanti, che vanno in questa direzione. Detto
questo, rimango fermo nella convinzione che l’elettronica, con i suoi
derivati, ci stia cambiando in un modo radicale, e più di quanto non
immaginiamo. Internet può essere pure lo strumento in cui esprimere e
diffondere su temi specifici un controcanto al potere politico, ma non
ci si deve illudere che la forma
internet non sia tutta dentro la nuova forma dei rapporti sociali
odierni, in cui la comunicazione fra individui è costretta ad essere
fondamentalmente (dentro e fuori da internet) una comunicazione di tipo
virtuale.
La cosa più importante è criticare la
convinzione che oggi la risposta all’insoddisfazione del presente possa
essere sostituire la rappresentazione dominante con un’altra
rappresentazione. Il discorso sul futuro stesso della democrazia, credo,
riguardi il ruolo delle informazioni e delle rappresentazioni nel
determinare la coscienza degli individui.
Si tratterà, infatti, di superare il
monopolio della rappresentazione, e non di sostituire un tipo di
rappresentazione ad un altro. Bisognerà ricostituire l’elemento
dell’esperienza sociale in modo nuovo, o meglio, cercare dove, in quali
contesti e in quali modi essa si vada costituendo ancorandosi ad un
qualche senso di appartenenza. Ritrovare, cioè, dei nobili modi di
sentirsi appartenenti al mondo.
Se ammettiamo possibile ancora, come
alcuni credono, una rivoluzione socialista di tipo classico, dovremmo
chiederci quale sarebbe il primo atto del nuovo potere costituito. Come
prima cosa io immagino che il leader faccia un discorso alla televisione (di stato o meno, non
importa). Così il primo atto rivoluzionario sarebbe necessariamente
integrato – e d’altro canto come potrebbe non esserlo? – nella forma
spettacolare della nostra società. Torna alla memoria quel passo in cui
Marx scrisse della necessità di abbattere l’apparato dello Stato,
piuttosto che di utilizzarlo ai propri fini. In questo caso non sarebbe
solo l’apparato dello Stato in senso classico, ma anche l’apparato delle
reti di comunicazione su cui si fonda il potere diffuso nelle nostre
società. Qualunque cosa dicessi da quella televisione, infatti, io
riprodurrei lo stesso schema formale di giustificazione del potere cui
siamo oggi assuefatti.
Nanni:
Dunque, sostieni che la rivoluzione oggi non può sussistere…
Giulio:
No, credo che questa frase di per sé non significhi nulla. Dico che
bisogna, invece, rendersi conto di come oggettivamente funzioni la
società odierna. E dico che una rivoluzione, intesa nel suo senso
novecentesco, si troverebbe oggi a misurarsi con diverse nuove
questioni, fra cui quella se debba o meno favorire il sistema di
riproduzione della vita fondato sulla separazione di rappresentazione e
realtà.
Anna: Devo dirti che però questa non mi sembra una novità dell’oggi, ma da
sempre esiste questa separazione…
Giulio:
Beh, oggi secondo me esiste una separazione molto più ampia di prima tra
rappresentazione del potere e realtà. Perciò io credo che, pur prendendo
il potere, vera rivoluzione sarà lasciarlo, cioè trasformare l’assetto
costituzionale e reale della società in una democrazia che permetta una
partecipazione cosciente alla politica, eliminando il potere come
separazione, il potere come luogo dei politici, e trasformarlo in una
funzione della società nella quale ciascuno possa alternarsi nel
dedicarsi, in una certa misura, alla gestione del potere. Dunque non
semplicemente prendere, e quindi, occupare il potere ma assumersi il
compito di eliminare la separazione tra il piano della rappresentazione
e quello della realtà, che significa, al contempo, eliminare la netta
separazione fra chi fa politica e chi non la fa. Come scriveva anche
Marx rispetto alla Comune di Parigi, si tratta di trasformare il
rapporto fra rappresentanti e rappresentati, la qual cosa, in chiave più
filosofica, significherebbe trasformare il rapporto fra rappresentazione
e il piano della vita.
Nanni:
Allora forse la rivoluzione dovrebbe essere riuscire ad introdursi nei
centri di gestione mondiale dei server informatici, e staccare la spina
al server di tutti i server…
Giulio:
No, non è una questione da pirati informatici; evidentemente le persone
a cui tu sottrarresti Internet ne sentirebbero immediatamente la
mancanza. Mi sembra evidente che una rivoluzione culturale dovrebbe
dimostrare, piuttosto, che internet non può essere quello che è divenuto
oggi; al tempo stesso, inoltre, dimostrare come lo spettacolo non possa
prendere il posto del teatro della vita; che un bello spettacolo non sia
migliore di nessuna vita, pure se triste o drammatica.
Da questo punto di vista, piuttosto che
soffermarmi su quale specifico atto possa dirsi rivoluzionario, mi
focalizzerei sul comprendere davvero fino a che punto una società della
comunicazione a rete generi nuovi tipi di relazione sociali, e che,
quindi, solo a partire da queste e da come esse trasformino le
personalità, si possa affrontare il tema della politica, ed,
eventualmente, quindi, quello della rivoluzione.
Siamo usciti, infatti, da pochi anni da
quello che è stato definito il
secolo breve, un arco di tempo relativamente esiguo, appunto, ma
assai tumultuoso, al tempo stesso drammatico e frenetico. La società si
è forse trasformata come mai è accaduto in un arco di così pochi
decenni. Per molti versi quel secolo sembra lontano ma l’eredità che ci
lascia è pesante: molti sono i nodi arrivati ai nostri anni senza
soluzione di continuità. Tra questi, su tutti, spicca quello della
tecnologia e delle sue applicazioni ormai in ogni campo della vita. Il
concetto stesso di umano va rapidamente trasformandosi; insieme ad esso,
d’altro canto, i concetti, ad esempio, di interiorità, ideologia,
valore, legame, verità (e si potrebbe continuare) hanno ben poco in
comune con i medesimi termini utilizzati anche solo due o tre
generazioni fa. In questo campo, nel campo diciamo della
spazio-temporalità dell’esperienza, il cambiamento è stato drastico,
rapido, e sembra oggi, a noi, inesorabile. In virtù delle nuove forme di
simbiosi fra uomo e macchina intelligente, il posto dell’uomo nel mondo
è cambiato; così che cambiando il suo posto, è mutata anche la sua
prospettiva sulle cose, su ciò che egli è, può essere, e vuole essere.
Che lo si riconosca o meno, stiamo
andando incontro a qualcosa di radicalmente nuovo. Non intravedo
alternative a tale corso. Meno lo riconosceremo, e più ne saremo
immersi. Meno lo comprenderemo, e più saremo complici nel produrre tale
realtà.
Al di là della superficie, la storia
futura dipenderà prevalentemente da ciò: da quanto il rapporto dell’uomo
con le forme artificiali d’intelligenza rimarrà entro questi binari, o
da quanto se ne discosterà. Che sia per via d’un’azione umana o d’altre
circostanze. Che prenda una direzione o un’altra.
APRILE 2012
[1]
Ci si riferisce a Gramsci,
Quaderni dal carcere.