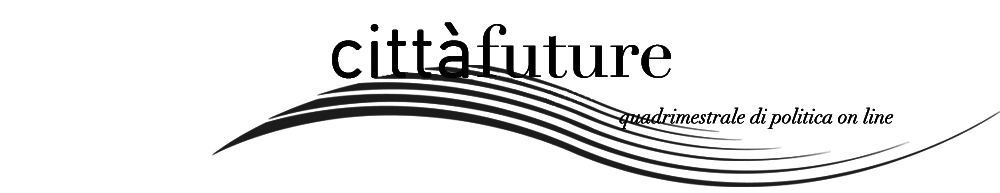Esperienza e rappresentazione
EMOZIONI ED EMOTICON
Mariano Mazzullo
Non c’è dubbio, il mondo moderno è
decisamente un posto pieno di emozioni, o quanto meno ricco di stimoli.
Il nostro variopinto villaggio globale, con il suo
sky-line vertiginoso, il suo
miscuglio multietnico, il bombardamento mediatico, l’estrema
disponibilità e varietà del piacere, non sembra certo un posto per gente
apatica. O non è forse così? Certo, se tra lo stimolo e l’emozione
corrispondente valesse una relazione determinata, gran parte
dell’umanità sarebbe già stesa da tempo sul pavimento, tramortita da
un’incontenibile sindrome di Stendhal collettiva. Ci sono, infatti,
abbastanza occasioni oggi per emozionare seriamente la maggior parte
degli uomini, e non mi riferisco soltanto all’offerta dell’hi-tech,
dell’architettura, dell’ingegneria estrema, dell’industria del sesso,
della tv, del gossip, e dei molteplici mirabilia dei nostri
tempi, mi riferisco anche a fenomeni più “classici”, come le sempreverdi
guerre e rivoluzioni. Hi-tech o vintage, l’emozione è oggi certamente
più a portata di mano, più fruibile, più compressa, convertibile e
riciclabile. Basti pensare per esempio al fenomeno degli “emo”, che
fanno di un’artificiale malinconia la propria moda, o alla condivisione
sui social network del proprio
“stato” quotidiano, condito spesso di particolari sulla cagione dei
propri sentimenti più personali.
L’equazione deterministica però non
funziona, e al mercato dell’emozione non si trova mai il prodotto di
cui si va in cerca. A dispetto di tutta questa colorata offerta
emozionale, piuttosto che estasiata di fronte all’oggetto delle proprie
passioni, l’umanità di oggi non si emoziona più tanto facilmente, o
peggio: cade in depressione per molto meno rispetto ad epoche diverse.
Chi non ha provato sulla propria pelle, nella noia dell’insensatezza e
dell’individualismo insaziabile, a dispetto di tutti i megabyte che
divora davanti agli schermi, la minaccia che si avverasse sul serio il
detto di Baudelaire, che con uno sbadiglio la noia possa inghiottire il
mondo? Si è inceppato qualcosa nel meccanismo del lusso e del benessere
per tutti? Non dovremmo essere il migliore dei mondi possibili (o almeno
la parte del mondo più fortunata), il più felice, il più entusiasta,
ricco di così tanti “canali” in cui trovare il nostro proprio
individuale corrispettivo dell’animo? Non sarà che abbiamo sofisticato
troppo? Non sarà forse che la moltiplicazioni delle possibilità,
l’ipertrofia della libido, l’estrema diversificazione degli oggetti del
piacere ci abbia spinto ad una qual certa disemozione collettiva? Di
sicuro se l’emozione fosse una diretta conseguenza del giusto stimolo,
basterebbe conoscere la corretta formula magica per avvertirla, un po’
d’amicizia, un po’ di gelosia, un pizzico di superbia, ed eccoti come
per magia la cartesiana “passione dell’animo”, partorita tirando le
corde giuste, come una pozione di Harry Potter. Per fortuna le cose non
stanno proprio così, l’emozione corre parallela alla sensazione per un
sentiero abbastanza lungo, ma ad un punto imprecisato del cammino le due
strade divergono, la sensazione giunge meccanicamente alla risposta
nervosa e oggettiva, l’emozione invece scaturisce sempre da un’aggiunta
soggettiva, da un fondo di libertà intangibile, da una sovrapposizione
di livelli esistenziali. È per questo motivo che la soggettività non
sarà mai soddisfatta o delusa dalle stesse cose di cui altri godono, non
lo sarà per sempre, non lo sarà pienamente, poiché l’uomo è uno
strumento infinitamente variabile e refrattario, solo determinate
sequenze interiori, ricordi, esperienze, passioni, riescono a farlo
vibrare emotivamente. È a causa di questa individualità dell’emozione
che il sogno politico-utilitarista di società “felici e contente” si
andrà sempre a scontrare con la resistenza soggettiva ad un’emozione
massificata e uniformata ad una forma di sentimento collettivo. Il gran
numero di individui insoddisfatti, tristi e spenti, in una società che
offre così tanti mezzi e occasioni per essere felici, che amplifica
qualunque momento possieda un potenziale d’impressione sugli animi, è un
esempio abbastanza chiaro di come non sia sufficiente un mondo esterno
ricco di occasioni felici per provare altrettante emozioni positive.
Gioia e tristezza non corrispondono a piacere e dolore, e direi anche
per fortuna, ma è pur sempre vero che l’emozione, sebbene sottratta allo
pseudo-determinismo dei sensi, possiede una sua regolarità, una sua
conformità in diversi soggetti. Si può essere innamorati o annoiati per
diverse cose e per diversi motivi, ma l’effetto patito, qualunque ne sia
la causa, è quasi identico a diverse latitudini e in culture
diversissime.
La domanda più interessane che ci si
possa fare, a questo punto, di fronte alla comunanza di effetti e alla
differenza di cause che le emozioni ci mostrano, sarebbe chiedersi da
dove vengono, perché le patiamo, perché ne siamo affetti, ma soprattutto
perché le manifestiamo, quasi fossimo costretti a darle a vedere.
Probabilmente, diremmo tante cose sensate se affermassimo che l’emozione
è sublimazione di stati fisici elementari, è un portato della nostra
origine animale sorto per una funzione strumentale e difensiva, che
sulla loro manifestazione si svolge una parte importante
dell’interazione ecc. Di tutte queste risposte sensate Darwin ha offerto
un’approfondita e affascinante discussione nel suo studio
sull’espressione delle emozioni, ma per quanto sembri misteriosa e
recondita la loro origine, il vero “mistero dei misteri” non è la loro
causa, che ci si può figurare in modo abbastanza semplice, bensì la loro
espressione, la rappresentazione fisiognomica che l’uomo mette in scena
per manifestarle all’altro. Questo elemento è quello di maggior
interesse nella spiegazione che il grande naturalista inglese fornisce
delle emozioni, sia perché l’espressione non è soltanto un momento
fisiologico, essa infatti coinvolge l’esistenza ben al di là della pura
sopravvivenza – ormai si sorride o si mette il grugno senza che
ciò metta a repentaglio la nostra vita – sia perché il modo in cui una
civiltà esprime l’emozione è particolarmente rappresentativo del modo
che ha di viverle, del concetto che essa possiede di sé stessa come
intersoggettività, come unità, come sostanza. Dobbiamo dire innanzitutto
che l’emozione in una civiltà globalizzata, economicamente e
tecnologicamente avanzata come la nostra, non solo si esprime, ma
soprattutto si rappresenta. Darwin ci illumina con chiarezza sul
primo punto: l’espressione dell’emozione è un atto originariamente
cosciente, praticato per esigenze funzionali alla sopravvivenza,
divenuto successivamente atto riflesso e invertito rispetto alla sua
insorgenza da uno stimolo corrispondente. In sostanza: se prima si
sorrideva per mostrare i denti in segno di difesa e sfida di fronte alle
minacce dei predatori, adesso per il “principio dell’antitesi” si
sorride per indicare un sentimento opposto alla minaccia e alla paura.
Il ragionamento però si mostra utile solo in parte, getta luce sulle
origini dell’espressione e sulla natura di questa simbologia, ma
con l’imporsi del fattore culturale questa provenienza animale
dell’espressione viene scavalcata da altri fattori. Il sorriso, il
grugno, il grido, aggrottare le sopracciglia e quant’altro, nascono
certamente da condizioni interne all’evoluzione, ma (come il meccanismo
dell’evoluzione in generale) si sono resi indipendenti dalla natura,
sono ormai divenuti espressioni-feticci, hanno acquisito un significato
loro proprio, una “seconda natura”. L’uomo può oggi fare a meno di
esprimere le emozioni, anche in contesti dove la natura lo avrebbe
obbligato a farlo. Si può amare o odiare senza darlo a vedere in modo
particolarmente espressivo, «ci sono altri mezzi per ottenere i propri
scopi», così come ci si può difendere da un’aggressione anteponendo un
self-control culturale all’istinto emotivo animale. A guardar
bene tutto ciò non è certo un felice destino per le nostre emozioni,
nate all’aria aperta e finite in cassaforte, ma ciò su cui bisogna
riflettere è che la loro espressione è divenuta principalmente una
rappresentazione. In un mondo pretecnologico, la rappresentazione
dell’emozione era affidata alla spontaneità incontrollata di un sorriso
o alla messa in scena lenta delle opere d’arte, poemi, drammi, ritratti,
il mezzo espressivo era per forza di cose un elemento dell’emozione
stessa: gli attori, i pittori, i poeti, patiscono in parte le emozioni
che rappresentano con le proprie opere. La nostra società è invece
dominata da una impressionante ricchezza di mezzi d’espressione
immediati, il web e le trasmissioni satellitari rendono possibile
comunicare repentinamente le proprie emozioni, quelle di una comunità,
di una famiglia, di una nazione, con un tweet o con infinte forme
di condivisione, come i blog ad esempio. Mi sento triste o
felice? Basta un tweet per rendere partecipe la comunità virtuale
del mio umore, che può modificarsi in tempi record, sobbalzare e
precipitare, restando sempre immediatamente comunicabile.
Ma ciò che è detto col breviloquio del
tweet o con la nuova retorica da fuoco d’artificio dei blogger
può ritenersi una concreta rappresentazione emotiva? Se ci
soffermiamo a pensare a quante cose dette con il cuore, anche in modo
semplice e conciso, vengano fraintese, stravolte o ignorate nella
comunicazione ordinaria, ci si rende subito conto di quanto poco pratico
e relativo sia il mezzo discorsivo come veicolo dell’emozione, privo del
pathos della recitazione
oppure troppo carico del pathos
da messa in scena del blog. L’immediatezza si può prestare bene,
fin troppo bene all’espressione dell’emozione, ma il discorso, breve o
lungo, profondo o superficiale, non sarà mai il mezzo privilegiato da
un’emozione che spinge per fuoriuscire, che vuole essere compresa,
condivisa, vissuta insieme. L’emozione vuole essere colta nel suo
sbocciare, vuole un volto su cui nascere e uno su cui fiorire.
La società ultra-mediata della
tecnologia di massa come può eludere questo primato dell’immediatezza,
del volto che l’emozione richiede per essere compresa? Naturalmente ci
sono molte meno occasioni per il faccia a faccia, quando possiamo
tranquillamente svolgere il nostro lavoro e parlare con un amico davanti
allo stesso schermo, ottimizzando i tempi e con la libertà di non venire
coinvolti. Ma per quanto grande sia la nostra libertà da un
coinvolgimento diretto, quando si interagisce con un amico o con un
gruppo di amici, la comunicazione ha comunque bisogno di manifestare
delle emozioni per esser davvero disinvolta, per far sì che il messaggio
arrivi al destinatario con il giusto tono emotivo. Vogliamo sentire
l’emozione dell’altro quando comunichiamo spontaneamente,
altrimenti ci sembra di parlare a vuoto. Affinché sia franca e informale
essa non può abbandonarsi a perifrasi, alla rima o a trovate
impressionanti, soprattutto nell’estrema brevità a cui la comunicazione
si riduce nei social network o con gli
smartphone. E così, per dare un pizzico di umanità alla
conversazione disumanizzata di soggetti che non si vedono e non si
sentono, che tante volte non sanno molto l’uno dell’altro, o peggio non
si conoscono affatto, tra le numerose funzioni a disposizione degli
utenti è stata inserita con enorme successo una panoplia di faccine
stupite, sorridenti, piagnucolanti e così via, da iniettare
all’occorrenza tra le righe del discorso rapido e diretto del mezzo
informatico. L’emoticon è l’invenzione mediatica per dare emozione
al discorso immediato, al botta e risposta delle
chat, alla frammentazione di
abbreviazioni e slang degli sms, un elemento appartenente al vissuto
inserito all’interno di uno scambio troppo veloce o interrotto. La sua
funzione è chiara e anche poco criticabile, è come se in un’antica
missiva d’amore un innamorato al fronte avesse allegato usualmente alle
sue righe vergate frettolosamente un disegno commovente, un oggetto
rappresentativo, una frase alla moda. La funzione è sempre quella di
umanizzare e semplificare il discorso, fornendo un’impressione diretta
dello stato d’animo di chi scrive. Ma non si tratta solo di questo, o
meglio non solo di questo. La specificità dell’emoticon,
infatti, rientra nel sistema comunicativo immediato delle chat,
degli sms, dello scambio di messaggi istantanei nei social
network, fa parte di un contesto comunicativo assolutamente
specifico e tipico solo di una generazione tecnologica. Il soldato che
dal fronte scrive una lettera d’amore o l’amico che va in vacanza e
spedisce una cartolina non ricorrerebbero mai ad allegare
rappresentazioni emotive al proprio discorso al fine di essere compresi,
almeno non lo farebbero per abitudine, a meno che non siano dei tipi
particolarmente artistici ed eclettici. Il motivo per cui l’emoticon
è usato solo in tipi di discorsi molto immediati, risiede nella quantità
di tempo e di riflessione con cui il discorso viene concepito e
articolato. Quale modo migliore dell’emoticon
per far capire all’amico, che mi chiede in
chat “come stai?”, che non
sono semplicemente stanco per il lavoro, ma che assieme alla stanchezza
si accompagna oggi uno stato di tristezza e abbattimento? Non posso
certo darmi a spiegazioni approfondite sul rapporto che lega insieme
stanchezza e tristezza in quel dato momento della mia vita, dovrei
sprecare troppo tempo e troppa riflessione per una innocua chiacchierata
via internet, che deve essere breve ed efficace, esporsi il meno
possibile a fraintendimenti e interpretazioni.
L’emoticon
così supplisce alla mancanza di tempo e copre gli spazi bianchi lasciati
dal discorso, è certamente un guadagno ma può essere anche una perdita,
in ogni caso un valore che sta all’utente attribuirgli. Fin qui questa
strumentalizzazione dell’emozione come rappresentazione funzionale al
discorso non suscita particolari interrogativi, è un mezzo come un
altro, ci si dice, che aiuta e alleggerisce una conversazione che si
presenta per sua natura come uno svago poco impegnativo. Fa riflettere
molto di più circa questa forma elementare di rappresentazione l’uso
spropositato che se ne fa, un uso che esula da un’utilità reale e
dall’emozione stessa. Cerchiamo di capirci di più e di vedere quali
elementi della nostra umanità questo tipo di rappresentazione racchiuda.
Chiunque sia un frequentatore abbastanza assiduo di chat,
social network, twitter, smartphone e quant’altro, si
potrà rendere facilmente conto di come l’emoticon venga impiegato massicciamente e con gran disinvoltura.
Quasi ogni sentenza nello scambio di messaggi possiede almeno una di
questa faccine, cuoricini, sorrisi, soli splendenti, ecc. e c’è anche
chi, evidentemente ancor prima, e a prescindere dalla tecnologia, non
dotato di una grande attitudine al dialogo o al discorso usa con
prepotenza e costanza più emoticon
che parole. Si tratta di casi particolari di persone più emotive che
discorsive oppure è l’emozione in sé che si vive con più estraneità, con
più semplicità, con minore partecipazione? È vero che l’emoticon
è un salvatempo organizzato, un surrogato virtuale di un più impegnativo
prodotto umano, ma è vero anche che il suo uso massiccio segnala un
rapporto quantomeno strano con l’emozione patita in prima persona,
soprattutto se pensiamo al fatto che si può piangere e disperarsi dietro
ad uno schermo mentre si inoltrano cuoricini e sorrisini che indicano
tutt’altro umore, si può sviare il discorso, portarlo fuori strada,
annullarlo, attraverso un’intromissione di questi feticci artificiali
nella conversazione. Tra parentesi va detto che questa condizione
altamente diffusa, estremo segno della scissione e alienazione, è a dir
poco raccapricciante e suscita la pelle d’oca.
Allora l’emoticon
non è più un’abbreviazione del tempo che l’emozione richiede, non è più
l’allegato personale ad un parlare che per natura si connota come
impersonale, diventa invece la maschera greca di un teatrino dei
sentimenti, dove non si ha tempo per provare vere emozioni. Nell’antico
teatro greco, gli attori usavano indossare delle maschere di ceramica
con delle espressioni fisse, dolore, gioia, stupore, una fissità che
comunica subito una forte impressione nello spettatore, ma serve
soprattutto ad identificare il ruolo, ad assegnare una parte
prestabilita a quel personaggio, una funzione rappresentativa che non è
lasciata alla sua fisiognomica e all’interpretazione del pubblico, ma
che viene assegnata a priori, a monte, chiaramente visibile a tutti e
prima ancora che il dramma venga inscenato.
Il leggero e vaporoso
click dell’emoticon
è un po’ come quella pesante maschera di ceramica, serve ad identificare
il nostro discorso, il senso di lettura da assegnargli, serve a non
farsi fraintendere piuttosto che a comunicare un’emozione, è infatti
usato con più insistenza da persone che non hanno voglia di parlare o di
manifestare i propri sentimenti o da chi li manifesta con troppa
facilità.
A ridosso di questo discorso si impone
una riflessione conclusiva. La crisi del dialogo in cui stiamo vivendo,
il venir sempre meno delle occasioni di scambio dirette fa sì che
l’emozione sia vissuta in un contesto più individuale e soggettivo
piuttosto che sorgere dal rapporto stesso tra due individui. Con
internet e i potenti mezzi di accesso alla comunicazione diretta si sta
lentamente andando incontro ad una inversione funzionale: mentre questi
mezzi nascono come strumenti in cui canalizzare il messaggio in modo più
impersonale, meno antropomorfico, meno soggetto a fraintendimenti, più
diretto e immediato, in realtà stanno diventando una dura barriera
all’espressione dell’umanità che si proponevano di amplificare.
L’emozione viene rimbalzata da uno schermo all’altro sotto forma di
emoticon, ma non appartiene né
all’uno né all’altro dei parlanti, appartiene alla logica della
comunicazione lampo e alla frustrazione cui è soggetta: il bisogno,
sempre e comunque umano, di essere capiti attraverso l’emozione. L’emoticon
perciò non è un’emozione rappresentata telematicamente per una intima e
veloce comprensione reciproca, ma è la rappresentazione di una assenza,
è il riempimento artificiale di un vuoto naturale, è una richiesta di
emozione, la richiesta sublimata e figurata dell’inconscio di un
sentimento vero.
APRILE 2013