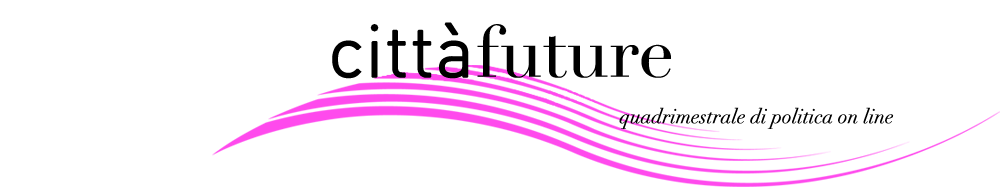PRESENTAZIONE DEL NUMERO
Redazione
Il numero 12 di «Città future» che qui
vi presentiamo sarà l’ultimo in cui gli articoli pubblicati non
rispondono ad un tema generale, ma seguono ancora lo schema della
rivista divisa per rubriche che si è venuto imponendo negli ultimi
numeri. Dividere i pregi dai difetti di quest’impostazione “storica” lo
lasciamo fare ai nostri lettori, riservandoci, piuttosto, il compito di
segnalare loro l’inizio di una nuova stagione, a cui abbiamo deciso
dovrà corrispondere l’inaugurazione di un modo diverso di realizzare i
numeri della rivista, incentrati, da oggi in poi, attorno a dei temi
teorici preventivamente proposti ai nostri collaboratori (e perché no ai
nostri lettori), a cui seguirà una seconda parte dedicata in modo
specifico alle inchieste e all’approfondimento delle “esperienze”
d’alternativa che si pongono oggi sulla scena della società.
Presenteremo tutto ciò comunque in modo
più adeguato nel prossimo numero. Per venire al presente, e cioè al
numero 12 in questione, va messo anzitutto in risalto il contributo
dell’editoriale curato dalla redazione, perché con esso si continua
l’analisi della strategia che le classi e i gruppi dominanti stanno
mettendo in atto nella prospettiva di rinnovare le forme e i modi di
riproduzione del capitale su di una scala globale. In particolare si
mette a fuoco il tema della
gratuità delle merce come elemento sostanziale e simbolico del
rinnovamento del capitalismo agli occhi delle masse. La tecnologia della
comunicazione, dunque, internet sicuramente, ma non solo, mette in luce
meglio di altre forme e di altri settori industriali la prospettiva di
legare la riproduzione del capitale ad un’immagine generosa e, al tempo
stesso, onnipotente del sistema del consumo, il quale non mettendo
limiti, e, cioè, dando tutto con pochissimo a chi gli accorda il proprio
consenso, e che nel momento stesso in cui ci rende utenti senza
chiederci apparentemente un costo per ciò (si pensi a google, facebook,
etc.) in verità lega la nostra vita in modo molto più subdolo al
progetto di arricchimento di alcune poche
corporations dalla dimensione,
come è evidente, del tutto transnazionale.
Di seguito troverete poi un interessante
sviluppo del tema dei luoghi e delle alternative allo sradicamento
dell’esperienza contemporanea in un contributo di Alessandro D’Aloia che
ha il pregio di tenere insieme diversi aspetti della visione critica sul
presente: in esso si tratta, infatti, dal tema della smaterializzazione
dell’esperienza come conseguenza della virtualità, a quello della
migrazione come tratto tipico della contemporaneità, alla questione
della città, al tema del destino del lavoro umano nella nostra società
ipertecnologica.
D’altro canto su questo tema si sofferma
anche il contributo di Mariano Mazzullo che con una disamina del
rapporto fra internet e le nuove generazioni mette a tema da un lato il
rapporto che sussiste fra il presunto superamento della materia, grazie
all’informatica, e il ritorno di tale materialità nella forma della
ristrettezza dei punti di vista sul mondo, dall’altro quello del
rapporto che sussiste fra nuova dimensione informatica, il tema del
lavoro e la connessa espropriazione di valore e di senso, e quello della
proprietà.
Sempre all’interno della rubrica
Esperienza e rappresentazione
troviamo poi i contributi di due nuovi nostri collaboratori con cui
siamo entrati recentemente in contatto. Del primo, Vittorio Lubrano,
pubblichiamo un’attenta ed utile ricognizione della fortuna, o sarebbe
meglio dire sfortuna, del pensiero di G. Debord, pensiero tanto più
celebrato, quanto spesso frainteso, in buona o cattiva fede che sia. Si
ricostruiscono nell’articolo di Lubrano le connessioni e le riprese di
tale pensiero con i pensieri successivi di Agamben, Perniola e Nancy,
non prima di aver riportato alcuni dei tratti caratteristici della
figura del filosofo francese morto suicida nel 1994 a Champot – Bas
lasciando a noi il compito (per chi se la senta naturalmente...) di
sviluppare la comprensione della natura spettacolare del nostro mondo.
Dall’altro canto abbiamo il contributo di Salvatore Marfella, il quale
presentandosi nella forma di una recensione di un classico, va,
tuttavia, al di là di questo genere, e si presenta come una maniera di
riflettere sull’origine della società dello spettacolo e sulle forme
televisive che essa assunse in particolare in Italia, luogo ideale, come
sottolinea Lubrano, agli occhi dello stesso Debord, per analizzare i
fenomeni nuovi dello spettacolo e della spettacolarizzazione della vita.
Tale spunto è approfondito, in particolare, da Marfella attraverso lo
sguardo di Fellini (anche se l’incipit pasoliniano sancisce il tono
dell’intero articolo) e di uno dei suoi ultimi film,
Ginger e Fred del 1985.
Di qui si passa poi ad un altro
contributo di Alessandro D’Aloia, ricavato, da una discussione avuta in
preparazione del
seminario presso l’Istituto Italiano per gli studi filosofici del prossimo Giugno sul
tema della pornografia. Lo si segnala, perché pur trattandosi di temi da
sviluppare, esso punta l’indice su uno degli aspetti inquietanti – e
forse proprio questo ci testimonia trattarsi di qualcosa di profondo,
vale a dire di particolarmente “reale” – della nostra nuova psicologia
determinata dal mondo del social, dove socializzabile e socializzata è
anche (e soprattutto ormai) la pornografia, nella sua forma diretta (la
pornografia in quanto tale) e quella indiretta (tutto il resto, in
quanto esito della pornografizzazione dell’esperienza sensibile tutta).
Per quanto riguarda, invece, le
inchieste in questo numero vi presentiamo un’intervista che non potrà
passare in secondo piano per il tema, e per l’interlocutore incontrato
da Massimo Ammendola. Sul tema attualissimo della terra dei fuochi,
emblema di come si vanno gestendo i rapporti di potere sul nostro
territorio, in un luogo in cui si intersecano politica, stato, affari,
malavita, forza pubblica, ha risposto alle nostre domande il parroco Don
Maurizio Patriciello, già noto ai più per il suo intervento nella
questione e la sua lotta contro la distruzione ecologica (e
antropologica) di un’intera regione dell’Italia.
Sulla medesima questione presentiamo
anche il contributo di Ornella Esposito, che riporta l’esito di un
colloquio con il Prof. Massimo Fagnano, coordinatore di un gruppo di
ricerca articolato in 6 facoltà della Federico II, sulla possibilità di
pensare ad una bonifica eco-compatibile, contrapposta alle costosissime
tecniche chimiche di bonifica, di quei siti che non sono inquinati da
rifiuti tossici, ma solo da agenti organici.
A tale contributo segue poi la risposta
di Alessandro D’Aloia ad alcune questioni poste nello scorso numero dal
nostro collaboratore G. Cosenza, ed in particolare sui temi della destra
e della sinistra, della città, e della questione, problematica, del
rapporto che sussiste ormai nel capitalismo attuale fra vecchie e nuove
forme di schiavismo.
Abbiamo infine, per quanto riguarda le
recensioni, due interessanti presentazioni di libri.
Buona lettura a tutti.
La Redazione.
GENNAIO 2014