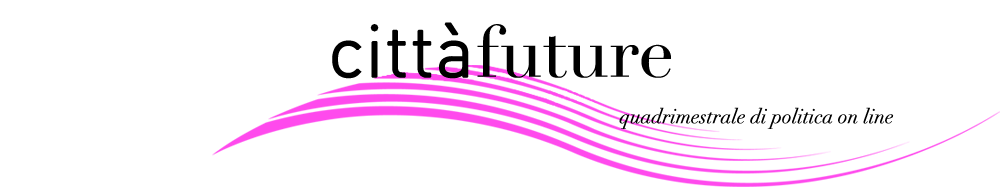Esperienza e rappresentazione
GUIDA ALLE LETTURE DI GUY DEBORD
Vittorio Lubrano
1. Dimenticare Guy Debord
La
Société du spectacle (1967)
ed i
Commentaires sur la société du spectacle
(1988) sono testi rivolti a «coloro che
sono nemici dell’ordine sociale esistente, e che agiscono effettivamente
a partire da questa situazione». In essi, il lettore trova utili
strumenti di decifrazione dello sviluppo che le società del dopoguerra
hanno avuto sino ad oggi. Una chiave interpretativa innovativa che
scolora quelle differenze scontate negli anni sessanta – tra Est e Ovest
del mondo, tra economia pianificata e libero scambio, tra apparato
burocratico e democrazia rappresentativa. Al loro posto emerge un cuore
comune, inesplorato, in cui vanno a confluire diversi processi della
contemporaneità; è questo il bersaglio inevitabile di ogni critica che
voglia dirsi rivoluzionaria.
Cardine di questa svolta prospettica è
la categoria di “spettacolo”. In essa convergono quella serie di
fenomeni particolari dinanzi ai quali restiamo abitualmente perplessi –
l’estetizzazione della politica, le forme di intrattenimento e di
informazione, l’abbondanza di consumi inutili e le nuove forme di
interazione sociale. Solo allungando lo sguardo oltre quelle che paiono
le contraddizioni del presente, l’intero globo si dimostra
caratterizzato da uno sviluppo complessivo – universale – delle forze
economiche e politiche. È il tratto determinante di una nuova fase,
un’epoca storica in cui tutto ciò che si considerava reale e oggettivo
de-significa, lasciando il posto al prolificare di immagini e simulacri.
Una profezia lucida e amara sul mondo
che viene, in cui nulla sembra potersi sottrarre a questa forza
trasformatrice. Non l’economia, non più paga della produzione materiale
con cui soddisfa i nostri bisogni, bensì produttrice essa stessa di
nuovi impulsi e desideri. Un’economia del simbolico che lascia intatta
la miseria di un’esistenza scandita dai ritmi di lavoro. Non la
politica, in simbiosi oramai con forme di intrattenimento e di
fascinazione tese a tratteggiare l’immagine vincente del leader di
turno. Tutto a discapito di una coscienza politica che dal basso sappia
decidere e agire collettivamente. Non la società, rarefatta in monadi di
lavoratori-consumatori, condannati all’alternativa di lavorare per poi
potersi svagare o di svagarsi per poi tornare a lavorare. Il
contrappasso di una vita quotidiana presunta libera e sociale, ma invero
isolata e aggregata artificiosamente (e pensare che Facebook non
esisteva ancora). Non infine l’informazione, distorta da dispositivi
logico-argomentativi che prediligono la sensazionalizzazione
dell’effimero e la critica laterale all’emergere della verità, ridotta
a «momento del falso». La comunicazione non alimenta più il dibattito
nell’opinione pubblica, ma ne diviene l’arma più forte di
disciplinamento.
Sono questi solo alcuni dei temi delle
analisi debordiane, che suonano di stringente attualità in Italia, già
indicata dall’autore stesso, nel 1979, come terreno di sperimentazione
prediletto delle tecniche spettacolari. Chiunque abbia sbirciato tra i
libri di Debord comprende come le sue argomentazioni colgano nel segno
in nazioni come la nostra, e come il suo pensiero sembra poterci aiutare
a orientarci nel presente. È una constatazione che tuttavia cozza con
un’altra.
Debord è un nome poco noto sia dentro
che fuori l’università. Le sue opere giacciono abbandonate sul binario
morto della dimenticanza o su quello ancor più ingrato della libera
reinterpretazione. Un esito paradossale per un intellettuale che pare
tanto utile ad una critica dell’esistente, ma che pochi ancora studiano.
2. I campi di reimpiego
Il lettore che voglia approfondire lo
sguardo debordiano sui processi socio-economici incontra non poche
difficoltà. I suoi testi principali sono stati tradotti da tempo, ma il
suo stile risulta complesso: elitario ed essenziale. Non è incredibile
allontanarsene scoraggiati dopo un primo assaggio. Le due opere
principali, come la filmografia tutta, sono una serie concettosa di tesi
in cui occorre rielaborare di continuo il senso ultimo delle parole, con
letture e riletture che cuciano i nessi invisibili del discorso. Una
prosa diversa può essere rinvenuta negli articoli che scrisse per alcune
riviste, dove il tono irriverente o apertamente polemico lascia
spiazzati circa la serietà delle proposte[1].
Se si cercasse supporto nella
letteratura secondaria, si resterebbe tuttavia colpiti da quanto
l’autore sia sì considerato, ma raramente in quanto filosofo
politico. Esiste una selva confusa di libri che prendono a matrice
Debord per confezionare prodotti editoriali diversificati. È un campo
vasto e poliedrico, riconducibile a tre principali modi di reimpiego
dell’autore: il biografico, lo stilistico e l’estetico.
Il primo di questi può definirsi il
campo della medializzazione biografica dell’autore[2]. Da questo
fuoriescono ricostruzioni della sua vita, girovago sregolato e
intellettuale non convenzionale. Una vita passata tra alcune delle
avanguardie artistiche del tempo – l’Internazionale Lettrista e
l’Internazionale Situazionista – l’amore per la festa, l’alcool e i
suoi eccessi, l’esperienza di regista e i viaggi internazionali sono
fonti di prim’ordine per il ritratto di un intellettuale bohemien.
Alternativo tanto in teoria quanto in pratica.
Se a ciò si aggiunge il suicidio finale
e le rare pubblicazioni dedicate ai cenni autobiografici – fa eccezione
il
Panégyrique
– si intuisce come il mercato di pubblicazioni abbia potuto prendere
questa piega. Un triste epilogo per chi lungo l’intera esistenza s’era
opposto alla propria elevazione a icona dell’intelligenza antagonista.
Un secondo insieme di scritti è invece
quello che riprende il modo di scrivere debordiano per emularne la
sfacciata attitudine libertina[3]. Si tratta di
autori che si vogliono seguaci del defunto situazionismo[4], anime
ribelli che condividono il disgusto per la società dello spettacolo.
Sono scritti che si concentrano prevalentemente sulla ripresa delle
tecniche linguistiche; più sul momento performativo che sui fondamenti
teorici. Sembra venir meno quella fatica concettuale che ogni pensiero
rivoluzionario richiede. Non si discutono nodi problematici irrisolti in
Debord, né si aggiorna la prospettiva critica rispetto ai più recenti
avvenimenti storici. I testi oscillano tra opere d’intrattenimento e
esercizi di fantasia, combinazioni libere che solo superficialmente
collimano col messaggio debordiano. Sono presenti sì l’impulso alla
ribellione mediante la creatività ed il richiamo al gioco, condivisi dal
comune maestro. Manca tuttavia qualcosa. Sembra di leggere Debord, ma
senza Debord.
Quest’ultimo predilige l’opzione per il
ludico, per la sperimentazione linguistica come conseguenza di un
preciso programma di retorica politica. La sua è una vera e propria
battaglia per il recupero delle parole, consunte nei discorsi che la
politica, l’economia o la pubblicità riversano quotidianamente sui
canali comunicativi. Dopo averle sottratte alla loro abituale semantica,
esse vengono proposte in nuove aggregazioni di senso al fine di
rifluidificare una comunicazione democratica altrimenti rattrappita.
«La teoria critica deve comunicarsi nel
proprio linguaggio» è il monito con cui si inaugura la ricerca di uno
stile della rivoluzione che ha tra i suoi risultati più pregevoli, le
tecniche del détournement[5].
Se viene meno lo sfondo teorico che alimenta tali linguaggi, il recupero
di Debord devia verso l’encomio alla stravaganza, alla bizzarria senza
pretese. Per quanto molte delle produzioni in quest’ambito siano
piacevoli da leggere, poco hanno da dirci sullo stato attuale della
società dello spettacolo.
C’è infine un ultimo terreno in cui
l’interesse per Debord ha messo radici. Si tratta degli studi di storia
e critica artistica che lo hanno giustamente fatto oggetto di analisi,
sia in quanto membro di due avanguardie di metà Novecento, sia per le
osservazioni sul ruolo dell’arte, della cultura e dell’urbanistica nella
società contemporanea[6].
L’autore ha cercato tutta la vita di combattere il «pensiero
specializzato del sistema spettacolare», la settorializzazione delle
discipline che, indagando su porzioni ridotte del reale, con linguaggi
specifici e circoscritti, non colgono quelle contraddizioni che
appartengono ad ogni ambito e qualificano un’epoca storica. Ma la sua
appartenenza ai situazionisti e il suo distinguersi quale teorico di
spicco, lo hanno reso – suo malgrado – preda appetibile per gli studiosi
nel campo dell’arte.
Questi ultimi approfondiscono le
intuizioni debordiane e offrono pregevoli contributi scientifici sia
agli epigoni che ai delatori. Resta il pericolo che uno studio mirato al
Debord artista, offra poco sul Debord politico.
Il quadro orientativo che, insomma, si è
brevemente delineato, non dà che un magro contributo al lettore
affascinato da quelle parole tanto aderenti alla nostra quotidianità
quanto perspicaci nella critica. Dinanzi a lui solo tre sentieri, ma
nessuno che introduca al terreno della filosofia politica.
3. Debord in filosofia
Per descrivere l’interessamento che i
filosofi hanno riposto su Debord, si potrebbe opportunamente parlare di
“rimozione”. Nei manuali universitari, nelle “garzantine”, il suo nome
compare raramente o frettolosamente, qualora non sia palesemente omesso.
Come racconta Burgio nel suo saggio dedicato a Debord, persino un testo
degli anni Settanta dedicato alla filosofia francese di orientamento
marxista non ne parla[7].
Ricercare le ragioni della sua eliminazione dagli intellettuali di
riferimento con cui valga la pena confrontarsi, potrebbe sviare il
discorso sulle sabbie mobili delle infinite supposizioni – ambito di
ricerca inesplorato ma decisamente fuorviante rispetto alla mappatura
delle sue letture che si sta qui conducendo. Occorre piuttosto
interrogarsi su quei pochi che ne hanno parlato e vagliare sommariamente
il modo in cui lo hanno fatto.
In Italia è ormai universalmente
riconosciuto il merito di Anselm Jappe che, nel suo
Guy Debord[8], ha
intrecciato sapientemente cenni biografici e retroterra culturale, il
periodo nelle avanguardie e gli scritti postumi, l’analisi delle
proposte teoriche ed il confronto con le fonti. In particolare
quest’ultimo spunto rende pregevole il libro, che non si limita a
rintracciare le radici delle proposte debordiane in autori come Lukàcs o
Lefebvre, a loro volta autori ormai sempre meno considerati, ma ne
evidenzia le differenze che rendono la Società dello Spettacolo
un’opera unica. Non manca anche un bilancio critico che sobriamente
prova a fare il punto su un testo rivoluzionario quaranta anni fa.
Un contributo meno conosciuto è invece
il saggio
Lo scandaloso «pensiero
della storia». Guy Debord e la dialettica di Alberto Burgio, rarissimo esempio di universitario italiano che ha
tentato di sottrarre dall’oblio la figura di Debord. Nel breve saggio,
questi viene riabilitato nel pantheon dei marxisti novecenteschi,
ma soprattutto presentato secondo un aspetto sì centrale ma oggi
raramente considerato. Debord è esplicitamente riconosciuto quale
talentuoso continuatore del pensiero dialettico, erede dello specifico
modo di decifrazione della storia che appartenne a Hegel prima e a Marx
poi. Un metodo che, partendo da una ricognizione dei fenomeni immediati,
li riconduce a determinazioni essenziali seguendo una narrazione di
fondo. Un caso recente ed isolato di riabilitare l’autore, ripensandolo
a fondo nonostante la generale noncuranza.
Sia Burgio sia Jappe sono rare eccezioni
nel mezzo di una letteratura secondaria che si disinteressa dei temi
politici di Debord. Esistono tuttavia casi di anomala attenzione
prestata all’autore. Filosofi – tre per la precisione – che non si sono
limitati ad uno studio esegetico dei suoi testi, ma che hanno cercato di
rielaborare originalmente le sue tesi, con differenti esiti.
Giorgio Agamben ne è l’esempio più
lampante, vista l’affinità filosofica che lo lega al suo maître
a penser. A Debord è infatti dedicato il volume Mezzi senza Fine,
così come un tributo, sia pur minimo, non può essere evitato
nell’introduzione alla celebre opera Homo Sacer.
«I libri di Debord costituiscono
l’analisi più lucida e severa delle miserie e della servitù di una
società – quella dello spettacolo, in cui noi viviamo – che ha esteso
oggi il suo dominio su tutto il pianeta»[9]. Tragedie
come quelle di Timişoara o di Tienanmen sono conferme tangibili
di quello stravolgimento, annunciato con largo anticipo, dei rapporti
tra politica e informazione. Agamben riconosce in Debord il merito di
aver intuito le forme odierne che la politica assume quando si insinua
invadente nella vita quotidiana. Lo spettacolo è la più elevata forma di
un dominio che ha le sue radici in dinamiche interne al paradigma di
sovranità dell’epoca moderna. In particolare sul piano linguistico lo
spettacolo miete i suoi frutti migliori. «Ancor prima delle necessità
economiche e dello sviluppo tecnologico, ciò che sospinge le nazioni
della terra verso un unico destino comune è l’alienazione dell’essere
linguistico»[10].
La quintessenza di quell’estraniazione
che un secolo prima Marx aveva descritto, è di carattere comunicativo.
Gli uomini sono spossessati dal proprio potenziale comunitario, sordi
gli uni agli altri. Il momento aggregante è solo quello dello
spettacolo, che ripristina tramite l’abbondanza di notizie dei media, un
finto legame tra le opinioni.
L’irretimento della coscienza storica in
una rete di chiacchiere[11].
Sono questi i soli accenni a un
sodalizio filosofico che può vantare una conoscenza personale dei due
(testimoniata dall’epistolario) e una comune irriverenza nei confronti
del mainstream filosofico.
Discorso diverso va fatto per Mario
Perniola, studioso e al contempo critico inflessibile dell’opera
debordiana. A lui va attribuito l’indubbio merito di non ignorare
Debord, ma di fissare con precisione gli aspetti problematici delle sue
tesi. Grave errore dell’intero gruppo dei situazionisti è stato –
secondo Perniola – quello di concepirsi sin da principio come
“soggettività estetica”, un Io artistico-poetico dedito a performance
sperimentali che solo secondariamente ha trasbordato nel campo
dell’analisi storica e della militanza politica. È un modo di
concepirsi problematico, che genera una spiacevole conseguenza: il
rischio di un narcisismo autoreferenziale, di un elitarismo snob che mal
si concilia con i propositi del gruppo, una rivoluzione di massa.
Imbrigliato nelle contraddizioni dovute ai suoi stessi presupposti, il
testo di Debord risulta pieno di “ambiguità”. Ambiguo è il punto di
vista del soggetto rivoluzionario – talvolta identificato nel singolo
individuo che sottrae la propria vita quotidiana ai meccanismi del
consumo, talvolta descritto secondo la retorica della lotta di classe.
Ambiguo è il linguaggio adoperato, lacerato tra un discorso tra esperti
– soli detentori della verità – e la necessità di autocritica – che
porterà a una serie di purghe all’interno dell’Internazionale
situazionista. Infine l’ambiguità tra la teoria e la prassi
rivoluzionaria: la tensione tra un gruppo di illuminati, possessori del
sapere critico, ma impotenti ad attuare alcun cambiamento, e la massa di
individui catatonici – unica possibile protagonista di un mutamento
storico, ma al contempo vittima prediletta della riorganizzazione
dell’esistenza ad opera dello spettacolo.
È un verdetto severo nei confronti di
Debord – non approfondibile in questa sede – che si spinge in uno
scritto recentissimo a considerarlo tra gli ideologi di riferimento di
quella deriva della politica italiana conosciuta come “berlusconismo”[12].
Una rielaborazione critica, ma complice
in molti punti, è infine quella svolta da Jean-Luc Nancy nel suo Être
singulier pluriel[13].
Debord e i situazionisti hanno avuto l’indubbio merito di intuire con
largo anticipo ed in controtendenza ai marxismi novecenteschi l’ultima
fase delle logiche espropriative del capitalismo. L’alienazione
lavorativa – descritta a suo tempo dal Marx dei Manoscritti –
oggi si completa mediante l’appropriazione dell’immaginario operata
dallo spettacolo. Questo sottrae all’uomo quel microcosmo finora intonso
di desideri, speranze, emozioni, ma anche cultura, inventiva e capacità
comunicativa. A ciò sostituisce un immaginario pre-configurato, un
serbatoio già pronto di bisogni-consumi, di vogliuzze ed appaganti
simulacri, mercificazione ultima di ciò che restava dello spirito. La
critica anti-capitalista ha spesso sottovalutato le implicazioni
dell’economico nell’ambito del simbolico. Lo spettacolo – e qui è la
sua somma pericolosità – si appropria dell’intero essere sociale proprio
falsando il rapporto che gli uomini hanno da sempre avuto coi simboli –
testimonianze visibili della loro aggregazione. Lo spettacolo al
contrario realizza una «simbolizzazione della produzione stessa».
Lavoratori-consumatori vengono coordinati tecnicamente secondo i comandi
della ragione mercantile. Spariscono frattanto i simboli comunitari,
sostituiti da prodotti industriali senza scopo, il cui presunto senso è
appioppato loro ex post.
Nonostante il riconosciuto valore di
Debord, il suo pensiero è tuttavia prigioniero a sua volta delle logiche
interne alla tradizione dialettica. Questa, secondo Nancy, non pensa
ontologicamente il “con-essere” degli uomini – e su questo tema che
insiste l’autore nel corso del libro. La soluzione politica di Debord
allo stallo contemporaneo – l’ipotesi della rivoluzione – risulta dunque
dalle aporie della dialettica e si rivela infruttuosa.
Si tratta di una posizione intermedia
che, per quanto rivaluti la categoria di “spettacolo” nell’analisi
politica, cerca di indicarne i limiti e di smarcarsene.
Agamben, Perniola e Nancy sono tre
riletture filosofiche di Debord, ma finora le uniche. La forte
diversità che esiste tra le posizioni rivela l’assenza di un dibattito
intento a farle convergere, a confrontarle o smentirle. È un vuoto di
pensiero che oggi andrebbe colmato.
4. Appunti di viaggio
I seppur brevi accenni alle riletture di
Debord consentono di trarre un bilancio provvisorio. Emerge nel generale
disinteresse che la filosofia ha dedicato all’autore solo qualche
eccezione alla regola. Debord, ignorato dai settori della ricerca
specialistica, è stato facile preda di libere rielaborazioni che lo
fanno oggetto di svariate proposte editoriali. Nessuna che però ne
valorizzi i contributi politici.
Gli esempi dell’ultimo paragrafo sono le
uniche riflessioni, svolte da filosofi sui testi debordiani, che
esplicitamente riconsiderano l’autore. Ma al di fuori di queste non
c’è che il deserto.
Il fascino che le tesi della
Société
ancora oggi esercitano sui lettori trovano dinanzi a sé una serie di
pericoli. C’è il rischio di sviare il pensiero debordiano su binari
morbidi che lo presentano quale intellettuale apocalittico, da
leggiucchiare con moderazione, senza esagerare. Un pensiero
intransigente il suo, lamentoso, da non prendere sul serio.
Alla neutralizzazione banalizzante si
aggiunge talvolta la confusione. La sua analisi è spesso rimescolata
grossolanamente a cupi ritratti della contemporaneità, su tutti quello
baudrillardiano, con cui pur esistono elementi in comune, ma anche
divergenze radicali[14].
Un ulteriore pericolo è infine che
quanto predetto più di quaranta anni fa sia stato sì un’accurata
previsione, ma che sia oggi un’inutile predica ridondante, poiché le
dinamiche sociali che vennero colte sul nascere sono ormai affermate ed
evidenti a tutti. Si coglie in questo modo solo un lato di Debord –
l’incredibile lungimiranza – ma si ignorano in blocco le indicazioni su
una via altra possibile per la nostra società, alternativa
all’«ideologia materializzata» dello spettacolo. Una via di
emancipazione, consapevolezza e ludica socialità che per noi, lettori
postumi, resta una sfida ancora aperta.
DICEMBRE 2013
[1]
M. Lippolis (a cura di), Potlach, Nautilus, Torino 1999.
[2] Cfr. A. Merrifield,
Guy Debord, Reaktion Books, London, 2011; V.
Kaufmann,
Guy
Debord: Revolution in the Service of Poetry, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006; C.
Bourseiller,
Vie et mort de Guy Debord, Pascal Galodé Editions, Saint-Malo 2002.
[3]
Cfr. C. Guilbert,
Pour Guy Debord,
Gallimard, Paris, 1996; Toulouse-la-Rose,
Debord contre Debord, Nautilus, Paris, 2010; ma anche
alcuni dei lavori di P. Bertelli,
Apologia del
plagio o
Elogio dell’imbecille che si fece primo ministro, da
http://www.pinobertelli.it/index.php?pb=situazionismo.
[4]
Ultimo, F. Abate col suo movimento politico “Situazionismo e
Libertà”. Lo stesso Gabriele Paolini si è definito talvolta un
situazionista.
[5]
Cfr. G. Debord, Istruzioni per l’uso del détournement
in Potlach,
cit., oltre a A. Burgio,
Lo scandaloso «pensiero della
storia». Guy Debord e
la dialettica
in M. L. Lanzillo e S. Rodeschini,
Percorsi della
dialettica nel Novecento,
Carocci Editore, Roma 2011, cap.6.2.
[6]
Cfr. M. Perniola,
I situazionisti,
cit.; M. Bandini,
L’estetico, il politico. Da
Cobra all’Internazionale situazionista, Costa & Nolan,
Ancona 1999; F. Careri, Walkscapes. Camminare come pratica
estetica, Einaudi, Torino 2006.
[7]
O. Pompeo Faracovi, Il marxismo francese contemporaneo fra
dialettica e struttura, Feltrinelli, Milano 1972.
[8]
A. Jappe,
Guy Debord,
Manifestolibri, Roma 1999, anche nuova ed. 2013.
[9]
G. Agamben, Mezzi senza
fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, Torino 1996,
p.60.
[10]
Ibidem, p.69.
[11]
A queste considerazioni va aggiunto anche il prezioso confronto
con il Debord artista politico, camuffatore di una poetica
d’assalto non assimilabile alla banale sperimentazione.
Cfr.
G. Agamben,
Difference and Repetition: on
Guy Debord’s films
trad. ing. di B. Holmes in T. McDonough,
Guy Debord and the situationist International, The MIT Press, Cambridge 2004.
[12]
M. Perniola,
Berlusconi o il ‘68 realizzato,
Mimesis, Milano, 2011. Per una critica al tardo Debord, noioso
narcisista, si veda anche:
[13]
J. L. Nancy, Être singulier pluriel, Galilée, Paris 1996,
anche in trad. it di Davide Tarizzo, Essere singolare plurale,
Einaudi, Torino 2001.
[14] Cfr. R. Gilman-Opalsky,
Spectacular Capitalism, Minor Compositions,