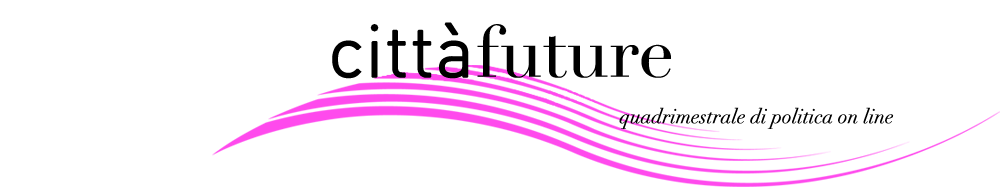Esperienza e rappresentazione
«GINGER E FRED» DI FEDERICO FELLINI: I NUOVI MOSTRI
Salvatore Marfella
A vent’anni dalla scomparsa di Federico
Fellini, quest’articolo propone una rilettura d’una delle ultime opere
del grande regista.
1. La nuova dittatura
Secondo me la televisione è più forte di tutto […] e la sua mediazione
ho paura che finirà per essere tutto […]. I campi di concentramento
dell’Unione Sovietica, la schiavitù nelle democrazie orientali,
l’Algeria. Questa ferocia all’antica naturalmente permane, ma, oltre a
questa vecchia ferocia, c’è una nuova ferocia che consiste nei nuovi
strumenti del potere, una ferocia così ambigua, ineffabile, abile, da
far si che ben poco di buono rimane in ciò che cade sotto la sua sfera.
Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della
banalissima televisione […]. Tutto viene presentato come dentro un
involucro protettore […]. In realtà nulla di sostanziale divide i
comunicati della televisione da quelli della analoga comunicazione
radiofonica fascista, l’importante è una sola cosa, che non trapeli
nulla mai di men che rassicurante […]. Tutto ciò esclude gli spettatori
da ogni partecipazione politica [...]. Non va pronunciata una sola
parola di scandalo, praticamente non può essere pronunciata una sola
parola, in qualche modo, vera[1].
Prima ancora della
nascita dei canali privati e dell’ampliamento esponenziale dell’offerta
della tv cosiddetta generalista, prima ancora dell’era
berlusconiana e delle macerie che questa avrebbe lasciato (e il cui
inventario è ancora ben lungi dall’essere redatto), Pier Paolo Pasolini
individuava con la sua consueta lungimiranza l’irrompere nella società
di un nuovo modello dominante, e preconizzava le nefaste conseguenze che
esso avrebbe prodotto in termini di sudditanza delle masse e di
omologazione culturale. Secondo Pasolini non v’erano dubbi: si trattava
di una nuova forma di sfruttamento, persino più potente e pericolosa di
quelle del passato perché più subdola e strisciante, più nascosta ma
anche più capillare, che avrebbe investito e coinvolto tutti i campi e
tutti gli aspetti della vita sociale e collettiva. Insomma, una sorta di
fascismo “in camicia bianca”, altrettanto rozzo e volgare, ma dal volto
all’apparenza assai meno minaccioso e più bonario, capace di ipnotizzare
il suddito-utente grazie al sorriso brandito al posto del manganello.
Il
durissimo
e profetico atto d’accusa contro la televisione sferrato dal regista di
Accattone ci è sembrato il
miglior apripista al nostro tentativo di analizzare alcuni aspetti
salienti di Ginger e Fred
(1985), il terzultimo lungometraggio di Federico Fellini, a nostro modo
di vedere opera paradigmatica della descrizione dell’invasività della
tv nel corpo sociale e
della metamorfosi antropologica generata dalla cosiddetta “civiltà dei
consumi”. Il disgusto e la volgarità preconizzati da Pasolini, dei quali
il nuovo medium è il
principale portatore, ci sembra trovino nel film di Fellini un perfetto
contrappunto visivo, presentando l’immagine di un Paese ormai avviato
inesorabilmente verso una profonda deriva culturale. Tuttavia
Ginger e Fred riesce ad
evitare le trappole del didascalismo moraleggiante grazie all’infusione
di una serie di simboli e significati di cui, come si vedrà, i due
protagonisti del titolo sono portatori e depositari, in obbedienza
all’immaginario del maestro riminese, solitamente poco incline a
rinunciare al suo gusto barocco ed al suo sguardo visionario in favore
della riflessione politica tout
court.
Difatti, rivisto
oggi, alla luce delle accelerazioni tecnologiche del nuovo millennio e
della nascita di nuovi e potentissimi strumenti di comunicazione ed
informazione (il pensiero va ovviamente ad Internet ed allo sviluppo
della rete), Ginger e Fred
potrebbe apparire agli occhi dei detrattori un’opera un po’ datata, per
certi versi addirittura preistorica, validissimo documento e perfetto
resoconto sugli anni ‘80 e ‘90, ma anche riflessione invecchiata e dagli
schemi un po’ logori su un’Italia televisiva imbarbarita e lobotomizzata
dall’onni-presenza ed onnipotenza del tubo catodico. Per questa ragione,
come cercheremo di illustrare attraverso l’analisi di alcune scene e la
riflessione su alcuni personaggi, la maniera in cui Fellini racconta il
“circo televisivo”, e soprattutto la presenza di un abbondante
sotto-testo, fanno di Ginger e
Fred un film ancora potente, capace di spingersi ben oltre i confini
un po’ angusti della semplice satira contro la moderna e debordiana
società dello spettacolo.
2. Benvenuti
all’Inferno
La scena iniziale del film mostra
l’arrivo di un treno alla stazione. Ne scende una gracile ed anziana
donnetta, Amelia Bonetti, interpretata da Giulietta Masina. Ad
attenderla, la segretaria del Centro Spaziale Televisivo, il grande
studio in cui quella sera si svolgerà la diretta del programma Ed
ecco a voi. Come si apprenderà di lì a poco, si tratta di uno
show in cui vengono presentati alcuni sosia di personaggi famosi,
oltre ad un multiforme bestiario umano capace di stupire il pubblico per
le sue caratteristiche a dir poco singolari. La signora Bonetti è stata
chiamata perché da giovane, molti anni prima, duettava nei teatri di
varietà insieme al compagno Pippo Botticella (Marcello Mastroianni). I
due vestivano con grande successo i panni dei grandi attori e ballerini
di tip-tap Ginger Rogers e Fred Astaire. Al suo arrivo alla stazione,
Amelia è accolta dalla seguente scenografia: un gigantesco zampone di
gomma che pubblicizza i prodotti alimentari dell’azienda
dell’onnipresente Cavalier Fulvio Lombardoni (ogni riferimento a fatti e
persone realmente esistenti non è
puramente casuale), un manifesto pubblicitario che mostra una
ragazza sorridente mentre un würstel sta per infilarsi nelle sue
natiche, un altro su cui campeggia la scritta “ROMA PULITA” proprio
sopra cumuli di nerissimi sacchetti di rifiuti. Amelia sale sul pulmino
che l’accompagnerà all’albergo, accolta da un sorridente gruppetto di
sosia di Lucio Dalla mentre alla
tv si
vede uno spot in cui una marionetta con le fattezze di Dante Alighieri
pubblicizza gli orologi “Betrix” (dall’evidente assonanza col nome
“Beatrice”). Con la comparsa dell’immagine del Sommo Vate, per di più
con le fattezze in un pupazzo che pubblicizza un bene di consumo, il
cerchio sembra chiudersi: Amelia è appena arrivata all’Inferno e il
pulmino guidato da un invisibile Caronte la sta traghettando verso un
viaggio nei vari gironi della Società dello Spettacolo.
3. L’involucro protettore e i nuovi mostri
All’arrivo in albergo Amelia, sentendosi
un po’ persa, chiede notizie del suo partner, ma le viene risposto che
non è ancora arrivato. Prende poi possesso della sua camera. La
tv
mostra significativamente le immagini di un astronauta in crisi di
ossigeno, seguite da quelle in cui un’insegnante dall’accento tedesco
impartisce lezioni di ginnastica a persone anziane, utili a combattere
la vecchiaia, spettro da scacciare via ad ogni costo. Le scene
successive mostrano Amelia che fa la conoscenza di alcune persone che
saranno tra gli ospiti, insieme a lei, della trasmissione Ed ecco a
voi: il sosia siculo di Clark Gable e quelli di Kafka e Marcel
Proust, quelli di Ronald Reagan, Brigitte Bardot, Bette Davis, Telly
Savalas/Kojak e Woody Allen; un transessuale napoletano la cui missione
nella vita è quella di andare nelle carceri a “consolare” i detenuti
(ovviamente servendosi degli strumenti del corpo più che di quelli dello
spirito); un gruppo di nani artisti (tutti significativamente con
accento del Sud); un “vero” mafioso fatto uscire dal carcere apposta per
l’occasione («pure isso a modo suo è “nu divo”», suggerisce qualcuno);
una “banda musicale di centenari”, dall’età di 620 anni in nove; il
“fraticello volante” (un francescano assistito dal dono della
levitazione durante la preghiera); un ammiraglio in pensione;
l’onorevole Tartina, da settimane in sciopero della fame per protesta
contro la caccia agli uccellini; un ingegnere, vittima di un sequestro,
cui hanno mozzato un mignolo e che detiene il primato dei giorni di
prigionia; l’uomo capace di ingravidare con la sola forza dello sguardo;
un imprenditore, fabbricante di mutandine commestibili; una vacca con
diciotto mammelle; un gruppo di barboni veri, prelevati dalla strada,
ospiti della rubrica “Ai margini della metropoli”.
C’è dunque posto per tutti all’interno
del nuovo medium: tutta la realtà viene immersa dentro le sabbie mobili del
pantano televisivo che diventa così un unico, enorme calderone che
comprende, ingloba, assorbe e omologa la più ampia gamma possibile di
sfaccettature del reale: vi hanno spazio la cronaca, la diversità fisica
e quella sessuale, la politica, l’arte, la musica, la letteratura, la
religione, la sessualità a partire fin dall’atto procreativo. Infatti,
l’uomo che ingravida con lo sguardo assurge a simbolo perfetto del mezzo
televisivo, capace di colonizzare la parte più intima dell’individuo
senza bisogno di contatto, per una sorta di contagio oculare. Fellini,
col suo consueto gusto barocco, presenta allo spettatore lo spettacolo
(si fa per dire) di questi “nuovi mostri”, versione distopica e ai
limiti dell’horror dell’umanità: volgari e patetici, abbrutiti e ignoranti, gli
“ospiti” dello show sono pronti a tutto, persino a mettere in mostra il
loro lato più intimo e la più immane tragedia personale, pur di godere
del famoso “quarto d’ora di celebrità” profetizzato da Andy Warhol. Se
un tempo, per creare un grande affresco in cui raffigurare una
molteplicità di figure umane, si ricorreva a tele di grosse dimensioni e
si lavorava sulla profondità di campo (il 3d
è scoperta pittorica prima ancora che invenzione cinematografica) ora è
sufficiente l’inquadratura di un cameraman: l’immagine appiattita dello
schermo televisivo ha rimpiazzato i muri intonsi delle grandi
cattedrali.
4. Amelia e Pippo: la Resistenza
Gettati in quest’arena – catapultati in
un mondo cui non appartengono sia per motivi anagrafici che,
soprattutto, per temperamento – troviamo i due personaggi di Amelia e
Pippo, in arte Ginger e Fred, emblemi di un’umanità diversa, ormai
prossima a svanire. I motivi che li hanno condotti fino a quel punto
sono apparentemente di differente natura. Amelia ha accettato con
riluttanza l’invito a comparire in televisione, convinta dall’insistenza
di amici e familiari, mentre Pippo è stato spinto a partecipare
all’insulso show televisivo da un mero bisogno di danaro. La verità è
che i due ex ballerini di tip-tap, che si sono molto amati in gioventù,
avevano soltanto una gran voglia di rivedersi. Amelia e Pippo sono molto
di più di una coppia di ex artisti di varietà che sta per esibirsi nel
nuovo mondo della televisione.
Spingendo la nostra riflessione “fuori”
e “oltre” il film, è possibile considerare i due personaggi innanzitutto
come un’anomala ed originale riproposizione della famosa coppia formata
dal Clown Bianco e dall’Augusto, due celebri figure di pagliacci
descritte in maniera particolareggiata in un altro film di Fellini,
I clowns (1970), capolavoro
sommerso che secondo chi scrive meriterebbe molta più attenzione di
quella sino ad oggi ricevuta. Per spiegare la differenza tra i due
pagliacci diamo la parola allo stesso Fellini che definiva il Clown
Bianco e l’Augusto nel modo seguente:
Il Clown Bianco è
simbolo d’eleganza, armonia, intelligenza. L’Augusto, al contrario, vive
in conflitto con tale perfezione, si ubriaca vivendo una continua
ribellione […] è il vagabondo, lo straccione, il bimbo capriccioso. Il
Clown Bianco rispecchia le paure del dovere, la repressione. L’Augusto è
tutto ciò che un bambino vorrebbe fare e che gli viene vietato:
rotolarsi a terra, sporcarsi, insomma tutto ciò che la razionalità tende
a vietare: fare boccacce, dire ciò che si pensa e urlarlo a squarciagola[2].
Amelia e Pippo sono difatti molto
diversi, se non complementari: la prima è una donna della media
borghesia, precisa, attenta, responsabile e un po’ vezzosa (con i suoi
cappellini e la sua mantella a scacchi); Pippo è un diseredato, un
proletario (al punto che, mescolatosi coi barboni dello show, viene
scambiato per uno di loro), si definisce un “nomade sessuale”, è fragile
(Amelia scopre che è finito in manicomio dopo che lei lo ha lasciato),
ingenuamente ribelle e dallo spirito anarcoide, arrivando fino ad
elogiare il mafioso perché «è uno che si ribella». Egli si rende conto
dello squallore dello show cui sta per partecipare, considera gli
italiani dei “pecoroni” e, da buon Augusto, vorrebbe urlarlo sul palco
durante la loro esibizione, ma viene dissuaso dal Clown Bianco/Amelia.
Anche Amelia, però, ha il suo moto di ribellione quando, alla domanda
postagli dal finto Clark Gable su quale sosia ella rappresenti, risponde
con fierezza: “Non sono il sosia di nessuno, io!”.
Inoltre non è affatto casuale che il
loro mezzo espressivo sia il tip-tap. Questo tipo di danza, prodotta
inizialmente dai ceti bassi, possiede infatti un’origine antica e una
molteplicità di significati. Come illustra Pippo alla solita giornalista
idiota, che rimane tuttavia affascinata dalla sua spiegazione, il
tip-tap era lo strumento che gli schiavi neri d’America, impossibilitati
a parlare tra loro e a praticare il loro culto religioso, utilizzavano
per mettere in atto i loro rituali, battendo ritmicamente le mani ed i
piedi ed usandoli in sostituzione delle percussioni. Il tip-tap
costituiva quindi in origine il
sound degli ultimi, dei diseredati, degli sfruttati, ma anche dei
ribelli. Si trattava quindi di una sorta di linguaggio per iniziati come
era ad esempio, nel Medioevo, la poesia dei cosiddetti “Fedeli d’Amore”.
Amelia e Pippo sono quindi due eretici che contrappongono la verità
eterodossa del loro essere e l’autenticità del loro repertorio al mondo
dei sosia, dei nani ballerini e della volgarità dentro la quale sono
immersi.
Singolare è il fatto che, ad un certo
punto della loro esibizione, si verifichi un
black-out che manda nel panico
il Centro Spaziale Televisivo ed il mellifluo presentatore. È la scena
cruciale del film. La mancanza di illuminazione consente ad Amelia e
Pippo di vivere il loro personale momento della verità e di confessarsi
il loro reciproco affetto. Amelia chiede a Pippo di essere pronto perché
“la luce potrebbe tornare da un momento all’altro”, ma Pippo, sentendosi
ormai risucchiato nel buio di un mondo dentro il quale ormai per lui non
c’è più posto, si abbandona alla più disperata delle rese: “No, ormai la
luce non torna più!”. Provenienti da un’altra epoca, Amelia e Pippo sono
consapevoli di essere sostanzialmente due reduci del passato. Nonostante
la loro differente estrazione sociale, essi sono entrambi dei reietti,
sopravvissuti di età sepolte il cui
medium comunicativo è ormai, secondo gli standard,
demodè. Oppressi da oscuri
presagi e consci di essere fuori posto e fuori tempo massimo i due
guitti, una volta tornata la luce, portano tuttavia a termine con
successo il loro numero regalando agli ignari spettatori una goccia di
verità nell’oceano delle false identità e della contraffazione, prima di
ritornare nell’oblio.
5. Il passaggio del testimone: il
“firmo”
Il finale del film merita anch’esso una
breve analisi. Ancora una volta, come ne
La Dolce Vita (1960),
Fellini ha fatto compiere allo spettatore un viaggio dentro la
decadenza di una società sempre più in via di decomposizione, una
traversata nel mare della volgarità e della barbarie culturale. Entrando
nel cuore malato della “banalissima televisione”, ed estraendone le
viscere, Fellini ha fatto di essa il simbolo di una società sempre più
falsa e putrescente, emblema di stupidità e conformismo.
Terminato il loro compito – cioè quello
di porsi come baluardo di resistenza contro l’inautenticità del mondo di
cui sono stati, per lo spazio di un giorno, ospiti sgraditi e sgradevoli
– Amelia e Pippo sono ora in stazione: la donna sta aspettando il treno
che la riporterà a casa, l’uomo ha deciso di restare ancora per un po’.
È il momento dei saluti: anche se hanno promesso di rincontrarsi,
entrambi sanno che si tratta del loro congedo definitivo. È un momento
di struggente malinconia interrotto, però, da un brevissimo intermezzo
che sembra aprire uno squarcio di speranza: i due ballerini sono
avvicinati da due adolescenti e da un ragazzo di colore che chiedono
loro l’autografo. Il ragazzo nero, in particolare, si rivolge a Pippo
per farsi mettere “un firmo”. Con questo fulmineo intervallo, con questa
richiesta del “firmo”, il regista prova a sfidare la desolazione creando
una scena che sembra rappresentare una sorta di passaggio del testimone:
la fiaccola della verità e dell’autenticità cambia di mano e viene
idealmente consegnata dai due guitti, ormai giunti al capolinea della
loro esistenza, a due categorie sociali nel quale è obbligatorio credere
per il futuro. La prima categoria è quella dei giovani, la seconda
quella degli immigrati, di coloro che stanno ancora imparando la lingua
del Paese che li ospita e che per questa ragione potrebbero possedere
una minore permeabilità ai modelli dominanti, una sorta di verginità
culturale ed intellettuale da custodire e maneggiare con cura.
In realtà, anche questo generoso
auspicio sembra nascere più dal famoso ottimismo della volontà che
dall’altrettanto famoso pessimismo della ragione. Basterebbe riflettere
in particolare (cosa che non è possibile qui, per ovvie ragioni di
spazio) sulla prima delle due categorie, quella dei giovani, per
osservare come ed in che misura essi siano stati nel corso degli anni
sempre più presi d’assalto da una società che, attraverso la continua
creazione di nuovi status-symbol,
tenta incessantemente di compiere la sua devastante opera di
colonizzazione morale e intellettuale.
D’altronde, mentre al termine del suo
viaggio negli inferi, l’amato Dante usciva “a riveder le stelle”,
nell’ultima sequenza del suo ultimo film –
La voce della luna (1989), opera terminale (in tutti i sensi) –
Fellini ci presenta la Luna che annuncia con voce stridula che è
costretta ad interrompere la sua conversazione col sognatore Ivo
(Benigni), perché è arrivato il momento di mandare la pubblicità. Il
resto non è più silenzio.
DICEMBRE 2013
[1]
P. P. Pasolini, «Corriere della Sera», 9 dicembre 1973.
[2]
F. Fellini, Fare un film,
Einaudi, Torino 1980, p.117.