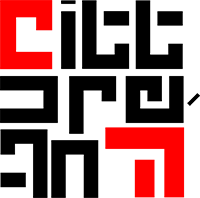Cut up dalla Pedagogia degli oppressi di Paolo Freire e commenti al testo
Alessandro D'Aloia
Il
grande problema sorge quando ci si domanda come potranno gli
oppressi, che “ospitano” in sé l’oppressore, partecipare
all’elaborazione della pedagogia della loro liberazione, dal momento
che sono soggetti a dualismo e inautenticità. Solo nella misura in
cui scopriranno di ospitare in sé l'oppressore, potranno contribuire
alla creazione comune della pedagogia che li libera. […] La
pedagogia dell’oppresso, che non può essere elaborata
dall’oppressore, è uno degli strumenti per questa scoperta critica:
gli oppressi che scoprono sé stessi e gli oppressori che sono
scoperti dagli oppressi, come manifestazione di un processo
disumanizzante. […] Nella prima fase di questa scoperta, quasi
sempre gli oppressi, invece di cercare la liberazione nella lotta e
attraverso di essa, tendono a essere anche loro oppressori, o
oppressi in secondo grado. La struttura del loro pensiero si trova
condizionata dalla contraddizione vissuta nella situazione concreta,
esistenziale, in cui si “formano”. Il loro ideale è realmente essere
uomini, ma per loro essere uomini è essere oppressori, a causa della
contraddizione in cui si sono sempre trovati e il cui superamento
non è loro chiaro. Gli oppressori sono per loro l’unico modello di
umanità.
Con questa affermazione non vogliamo dire che gli oppressi, in tal caso, non sappiano di essere oppressi. Tuttavia, la loro conoscenza di sé stessi come oppressi si trova falsata dal fatto che vivono immersi nella realtà degli oppressori. “Riconoscersi” a questo livello, in opposizione all’altro, non significa ancora lottare per il superamento della contraddizione. Nasce di lì l’aberrazione: uno dei poli della contraddizione non aspira a liberarsi, bensì a identificarsi con il suo opposto. In questo caso, per gli oppressi, “l’uomo nuovo” non è l’uomo che deve nascere dal superamento della contraddizione, con la trasformazione dell’antica situazione di oppressione che ceda il posto a una nuova, di liberazione. Per loro, l’uomo nuovo sono loro stessi, che diventano oppressori degli altri.
Vogliono la riforma agraria, in questo caso, non per liberarsi, ma per divenire proprietari, o più esattamente padroni di nuovi servi.
Perfino le rivoluzioni, che trasformano la situazione concreta di oppressione in un’altra, di liberazione, affrontano questa manifestazione tipica della coscienza oppressa. Molti degli oppressi che partecipano alla rivoluzione, sia direttamente sia indirettamente, sotto l’influenza dei vecchi miti della struttura anteriore pretendono fare della rivoluzione la loro rivoluzione privata. Perdura in essi, in un certo senso, l’ombra dell’oppressore antico. Questo continua a essere purtroppo il loro modello di ciò che è “umanità”.
Uno degli elementi fondamentali nel processo di mediazione oppressi/oppressori è la prescrizione. Ogni prescrizione è l’imposizione di una scelta, esercitata da una coscienza su un’altra. Perciò il significato della prescrizione è alienante, perché trasforma la coscienza di colui che la riceve in una coscienza-ospite dell’oppressore. Il comportamento degli oppressi è una specie di comportamento “prescritto”. Si struttura su criteri estranei, che sono quelli degli oppressori. Gli oppressi, che introiettano l’ombra degli oppressori e seguono i loro criteri, hanno paura della libertà, perché essa, comportando l’espulsione di quest’ombra, esigerebbe che il vuoto da lei lasciato fosse riempito con un altro “contenuto”, quello della loro autonomia, o della loro responsabilità, senza la quale non sarebbero liberi. La libertà, che è una conquista e non un’elargizione, esige una ricerca permanente.
Finché sono influenzati dalla paura della libertà, si rifiutano di rivolgersi ad altri e di ascoltarne l’appello, preferendo essere “aggregati” piuttosto che compagni in una convivenza autentica; preferiscono l’adattamento a cui li obbliga la loro non-libertà a una comunione creatrice, alla quale la libertà porta l’uomo, anche quando essa è solo una ricerca. Subiscono un dualismo che si installa nell’intimo del loro essere. Scoprono che, non essendo liberi, non arrivano a “essere” autenticamente. Vorrebbero “essere”, ma hanno paura.
La trama della loro lotta si delinea tra l’essere se stessi o l’essere duplici. Tra l’espellere o no l’oppressore che sta “dentro” di loro. Tra il superare l’alienazione o rimanere alienati. Tra seguire prescrizioni o fare delle scelte. Tra essere spettatori o attori. Tra agire o avere l’illusione di agire, mentre sono gli oppressori che agiscono. Tra il “parlare” o non avere voce, castrati nel loro potere di creare e ricreare, nel loro potere di trasformare il mondo. È questo il tragico dilemma degli oppressi, che la loro pedagogia deve affrontare.
Per noi, tuttavia, il nocciolo della questione non consiste nell’illuminare le masse, ma nel dialogare con loro sui motivi e le modalità della loro azione. Comunque, il dovere che Lukacs attribuisce al partito rivoluzionario di «illuminare alle masse la loro propria azione» coincide con l’esigenza da noi posta dell’inserzione critica delle masse nella loro realtà attraverso la prassi, per il fatto che nessuna realtà trasforma sé stessa.
La pedagogia dell’oppresso, che cerca la restaurazione della intersoggettività, si presenta come pedagogia dell’Uomo. Al contrario, la pedagogia che, partendo dagli interessi egoistici degli oppressori (egoismo camuffato con apparenze di generosità), fa degli oppressi gli oggetti del suo umanitarismo, mantiene e incarna l’oppressione. Questa è la ragione per cui, come s’è già detto, questa pedagogia non può essere elaborata né praticata dagli oppressori. Sarebbe una contraddizione se gli oppressori non solo difendessero ma praticassero un’educazione liberatrice. Se però la pratica di questa educazione esige che gli oppressi esercitino il potere politico, come realizzare la pedagogia dell’oppresso prima della rivoluzione?
La pedagogia dell’oppresso, come pedagogia umanistica e liberatrice, avrà due momenti distinti. Il primo, in cui gli oppressi scoprono il mondo dell’oppressione e si impegnano nella prassi a trasformarlo; il secondo, in cui, trasformata la realtà oppressiva, questa pedagogia non è più dell’oppresso e diventa la pedagogia degli uomini che sono in processo di permanente liberazione.
Nel momento però in cui il nuovo potere si indurisce come burocrazia dominante, si perde la dimensione umanistica della lotta e non si può più parlare di liberazione. Ecco il perché dell’affermazione fatta in precedenza, per cui il superamento autentico della contraddizione oppressi/oppressori non consiste nel cambio di guardia, nello scambio dei poli; non consiste neppure nel fatto che gli oppressi di oggi, proprio in nome della libertà, passino ad avere nuovi oppressori.
Questa tendenza degli oppressori a rendere senza vita tutto e tutti, che si trova nella loro ansia di possesso, si identifica indiscutibilmente con la tendenza sadica. «Il piacere che nasce dal dominio completo su un altro essere (o su un’altra creatura animata) costituisce l’essenza dell’impulso sadico.
Il sadismo appare così come una delle caratteristiche della coscienza dell’oppressore, nella sua visione necrofila del mondo. Per questo il suo amore è un amore a rovescio, un amore per la morte e non per la vita.
Dichiararsi impegnato con la liberazione e non essere capace di entrare in comunione con il popolo, che si continua a considerare assolutamente ignorante, è un equivoco doloroso.
A un certo momento dell’esperienza esistenziale degli oppressi, si verifica un’attrazione irresistibile verso l’oppressore. Verso il suo stile di vita. Partecipare a questo stile di vita costituisce un’aspirazione irresistibile. Nella loro alienazione vogliono, a ogni costo, somigliare all’oppressore. Imitarlo. Seguirlo. Ciò si verifica soprattutto negli oppressi della classe media, la cui aspirazione è divenire uguali all’uomo “illustre” della cosiddetta classe “superiore”. È interessante osservare come Memmi, in un’analisi assolutamente straordinaria della “coscienza colonizzata”, si riferisce al rifiuto del colonizzato davanti al colonizzatore, rifiuto che però è mescolato a un’attrazione “appassionata” per lui.
A forza di sentirsi dire che sono incapaci, che non sanno nulla, che non possono sapere, che sono malati cronici, indolenti, e che non producono per via di tutto questo, finiscono per convincersi della loro “incapacità”. Parlano di sé stessi come di coloro che non sanno, e del “dottore” come di colui che sa e che si deve ascoltare. Sono loro imposti criteri di sapere convenzionali.
Il fatto è che pensare autenticamente è molto pericoloso. Lo strano umanesimo di questa concezione “depositaria” si riduce al tentativo di fare degli uomini esattamente il loro contrario, degli automi, cioè la negazione della vocazione ontologica a essere di più. Gli esecutori di questa concezione “depositaria”, coscienti o no (perché esiste un certo numero di educatori di buona volontà che ignorano di essere al servizio della disumanizzazione, praticando questo mercato da banchieri) non si accorgono che tali “depositi” sono pieni di contraddizioni […].
La persona necrofila è spinta dal desiderio di trasformare l’organico nell’inorganico, di accostarsi alla vita meccanicamente, come se tutte le persone viventi fossero cose.
«Ama il controllo, e nell’atto di controllare, uccide la vita».
La sua intenzione è esattamente opposta: controllare il pensiero e l’azione, portando gli uomini ad adattarsi al mondo.
Quando gli uomini, per un motivo qualunque, sentono la proibizione di agire, quando si scoprono incapaci di usare le loro facoltà, soffrono. […]. Ma il fatto di non poter agire, che provoca la sofferenza, provoca anche negli uomini la reazione per cui rifiutano la loro impotenza. Allora tentano di ristabilire «la loro capacità di amare» (Fromm). «Possono farlo? Come? Un modo è quello di sottomettersi a una persona o a un gruppo, di identificarvisi.
Questo stesso tipo di reazione forse si può riscontrare negli oppressi, quando sono immersi nei fenomeni “populisti”. La loro identificazione con i “leader” carismatici, attraverso i quali possano sentirsi attuanti, e quindi nell’esercizio del potere, così come la loro ribellione, quando emergono dal processo storico, sono avvolte da questo impeto di ricerca di realizzazione di potere. Per le élite dominanti questa ribellione, che le minaccia, trova la sua medicina in una dominazione ancor più forte, nella repressione, fatta, tra l’altro, in nome della libertà, e nella restaurazione dell’ordine e della pace sociale. Pace sociale che in fondo non è altro che la pace privata dei dominatori.
L’educazione come pratica di dominio, che è l’oggetto di questa critica, conservando la coscienza “naturale” degli educandi, pretende, nell’ambito della sua definizione ideologica (raramente percepita da coloro che la realizzano) addottrinarli, affinché si adattino al mondo dell’oppressione.
Il nostro obbiettivo è fare un richiamo agli autentici umanisti e avvertirli che non possono, nella ricerca della liberazione, servirsi della concezione “depositaria”, sotto pena di contraddire la loro stessa ricerca. Così pure, questa concezione non può diventare eredità della società oppressiva alla società rivoluzionaria, la quale, se mantiene questa concezione “depositaria” dell’educazione, o è caduta in equivoco o si è lasciata “mordere” dalla sfiducia nell’uomo. In qualunque ipotesi, sarà minacciata dallo spettro della reazione.
A questo punto nessuno educa nessuno, e neppure sé stesso: gli uomini si educano in comunione, attraverso la mediazione del mondo.
Nessuno può “essere’’, con autenticità, mentre impedisce che gli altri siano. E questa un’esigenza radicale. L’essere di più ricercato nell’individualismo conduce a un avere di più egoista, che è una forma di essere di meno.
Per il pensare acritico, l’importante è adattarsi a questo oggi normalizzato. Per quello critico, l’importante è la trasformazione permanente della realtà, in vista della permanente umanizzazione degli uomini.
Questa pratica esige che l’accostamento alle masse popolari si faccia, non per portare loro un messaggio “salvifico”, in forma di contenuto da depositarsi, ma per conoscere, nel dialogo con esse, non soltanto l’oggettività in cui si trovano, ma la coscienza che hanno di questa oggettività: i vari livelli di percezione di sé stessi e del mondo, in cui e con cui si trovano.
Ne deriva che il contenuto di un programma di azione, che appartiene ad ambedue, non può essere una scelta esclusiva degli educatori o dei politici, ma di loro e del popolo.
È lo sforzo di proporre agli individui dimensioni significative della loro realtà, la cui analisi critica renda loro possibile riconoscere l’interazione delle sue parti.
In una visione liberatrice, e non più “depositaria” dell’educazione, il contenuto dei programmi non è l’involucro degli obiettivi da imporre al popolo, ma il riflesso delle sue aspirazioni e le sue speranze (perché parte e nasce dal popolo, in dialogo con gli educatori). Dunque la ricerca della tematica è il punto di partenza del processo educativo e della sua capacità di dialogo.
La “coscienza possibile” (Goldmann) sembra che si possa identificare con quello che Nicolai chiama “soluzioni praticabili non percepite” (che è poi il nostro “possibilità ancora inedite di azione”) in opposizione alle “soluzioni praticabili percepite” e alle “soluzioni effettivamente realizzate”, che corrispondono alla “coscienza reale” o effettiva di Goldmann.
Gli individui “immersi” nella realtà con la sola sensibilità dei propri bisogni, ne emergono, e così raggiungono la ragione dei loro bisogni. In questo modo potranno superare molto più rapidamente il livello della “coscienza reale” e attingere quello della “coscienza possibile”. Se tale è l’obiettivo dell’educazione “problematizzante” che difendiamo, l’investigazione tematica, che ne è lo strumento, non più sottrarsi a questo obiettivo.
Gli uomini sono esseri di prassi. Sono esseri del “che-fare”, mentre gli animali sono esseri del puro “fare”. Gli animali non “vedono” il mondo. Vi si immergono. Gli uomini, al contrario, in quanto esseri del “che-fare”, ne emergono e, oggettivandolo, possono conoscerlo e trasformarlo col loro lavoro.
Gli uomini invece sono esseri del “che-fare”, perché il loro “che-fare” è azione e riflessione. È prassi. È trasformazione del mondo. Se il “che-fare” è prassi, il fare dell’uomo deve avere una teoria che necessariamente lo illumini. Il “che-fare” è teoria e pratica. È riflessione e azione.
La famosa affermazione di Lenin: «Senza teoria rivoluzionaria non ci può essere movimento rivoluzionario» significa precisamente che non si fa rivoluzione col verbalismo, e nemmeno con l’attivismo, ma con la prassi, cioè con la riflessione e l’azione, che influiscono sulle strutture in trasformazione. Lo sforzo rivoluzionario che ne consegue non può avere nella sua leadership uomini del che-fare e nelle masse oppresse uomini ridotti al puro fare.
Non è possibile che la leadership consideri gli oppressi puri e semplici esecutori delle sue determinazioni, attivisti cui si neghi la riflessione sul proprio fare. Gli oppressi, nell’illusione di fare qualcosa (attraverso l’azione della leadership) continuano a essere manipolati, ed esattamente da coloro che non dovrebbero farlo, in ragione della natura della loro funzione. Perciò, quando la leadership nega la vera prassi agli oppressi, nega anche la sua.
Se l’impegno della leadership è veramente quello della liberazione, il suo “che-fare” (azione e riflessione) non può esistere senza l’azione e la riflessione degli altri.
Una leadership rivoluzionaria, che non sia dialogica con le masse, o mantiene “l’ombra” del dominatore “dentro” di sé, e non è rivoluzionaria, o si trova in un grosso equivoco, e diviene prigioniera di un settarismo indiscutibilmente morboso; anche in questo caso non è rivoluzionaria. Può arrivare al potere, ma dubitiamo di una rivoluzione che risulti da questo “che-fare” anti-dialogico.
Tra l’altro il dualismo esistenziale può favorire la nascita di un clima di settarismo che porta facilmente alla strutturazione di “burocrazie” che corrodono la rivoluzione. Se le masse prendono coscienza, nel corso del processo, di questa ambiguità, può accadere che accettino la propria partecipazione al potere con uno spirito di rivincita più che di rivoluzione. Possono inoltre aspirare alla rivoluzione come a un mezzo di dominazione e non come a un cammino di liberazione. Possono visualizzare la rivoluzione come la loro rivoluzione privata, ciò che ancora una volta rivela una delle caratteristiche degli oppressi, di cui si è parlato nel primo capitolo di questo saggio.
La vera rivoluzione, prima o poi, deve aprire il dialogo coraggioso con le masse; la sua legittimità si trova in questo dialogo, e non nel ristagno o nella menzogna. Non può temere le masse, la loro espressività, la loro partecipazione effettiva, al potere. Non può negarle. Non può sottrarsi a una resa dei conti con esse, a dire loro i successi, gli errori, gli equivoci, le difficoltà. Siamo convinti che, quanto prima comincia il dialogo, più rivoluzione ci sarà. Questo dialogo, come esigenza radicale della rivoluzione, risponde a un’altra esigenza radicale, quella degli uomini, che non possono “essere” fuori della comunicazione, perché sono “comunicazione”. Ostacolare la comunicazione significa trasformarli quasi in cose, e questo è compito e obiettivo degli oppressori, non dei rivoluzionari.
Cioè, la leadership ha negli oppressi i soggetti dell’azione liberatrice, e nella realtà la mediazione dell’azione trasformatrice di ambedue. In questa teoria dell’azione, esattamente perché è rivoluzionaria, non è possibile parlare di attore al singolare né di attori al plurale, ma di attori nella inter-soggettività, nell’intercomunicazione.
Molti, perché attaccati a una visione meccanicistica, pensano che la trasformazione della realtà si può fare in termini meccanici: essi non percepiscono l’ovvia verità che la situazione concreta, in cui gli uomini stanno, condiziona la loro coscienza del mondo, e questa a sua volta condiziona il loro atteggiamento e la loro maniera di affrontarla. Cioè pensano che la trasformazione della realtà si può fare senza problematizzare questa falsa concezione del mondo o senza che l’azione rivoluzionaria approfondisca la sia pur meno falsa coscienza degli oppressi. Non esiste realtà storica (altra affermazione ovvia) che non sia umana. Non c’è storia senza gli uomini, come non c’è una storia per gli uomini, ma una storia di uomini che, fatta da loro, al tempo stesso li fa, come disse Marx.
Chi può pensare senza le masse (e non può permettersi il lusso di non pensare ad esse), è l’élite dominante; […] Pensare con esse sarebbe il superamento della loro contraddizione. Pensare con loro significherebbe non dominare più. Perciò l’unica forma di pensare giusto dal punto di vista degli oppressori è non lasciare che le masse pensino, il che vuol dire: non pensare con esse.
“Benché sembri magnifico in teoria il progetto di dare istruzione alle classi lavoratrici, sarebbe nocivo alla loro morale e alla loro felicità; insegnerebbe a disprezzare la loro missione nella vita, invece di farne buoni servi per l’agricoltura e altri impieghi; invece di insegnare loro ad essere subordinati, li renderebbe ribelli e refrattari, come si rivelò evidente nelle contee manifatturiere; li renderebbe capaci di leggere libercoli sediziosi, libri perversi e pubblicazioni contro la cristianità: li renderebbe arroganti verso i loro superiori, e in pochi anni diverrebbe necessario, per la legislazione, dirigere contro di essi il braccio forte del potere». In fondo, quello che MrGiddy, citato da Niebhur, voleva, è simile a ciò che vogliono i MrGiddy di oggi, cioè che le masse non pensino.
Alcuni pensano, a volte con retta intenzione, ma in base a equivoci, che giacché il processo dialogico è lento (il che non è vero) si deve fare la rivoluzione senza comunicazione, attraverso comunicati, e dopo che si è fatta, allora svolgere un ampio sforzo educativo. Anche perché, dicono, non è possibile fare educazione prima della presa del potere. Educazione liberatrice. Nelle affermazioni di coloro che pensano così ci sono alcuni punti fondamentali. Credono (ma non tutti) alla necessità del dialogo con le masse, ma non che sia possibile prima della conquista del potere. Quando affermano che non è possibile un tipo di comportamento educativo-critico prima della conquista del potere, negano il carattere pedagogico della rivoluzione, come azione culturale, che si prepara ad essere rivoluzione culturale. D’altra parte, confondono il senso pedagogico della rivoluzione con la nuova educazione che deve essere inaugurata dopo la conquista del potere. […] la conquista del potere è solo un momento, anche se decisivo. In quanto processo, il “prima” della rivoluzione si trova nella società oppressiva ed è solo apparente.
Ecco perché la conquista del potere è appena un momento decisivo di un processo che continua. Quindi, in una visione dinamica e non statica della rivoluzione, essa non ha un prima e un dopo assoluti. […] Generata in determinate condizioni obiettive, essa cerca il superamento della situazione oppressiva con l’instaurazione di una società di uomini in processo di permanente liberazione. Il senso pedagogico, dialogico, della rivoluzione, che ne fa anche una “rivoluzione culturale”, deve accompagnarla in tutte le sue fasi. È questo un mezzo efficace per evitare che il potere rivoluzionario si istituzionalizzi, stratificandosi nelle forme di una “burocrazia” contro-rivoluzionaria, perché la contro-rivoluzione è caratteristica anche dei rivoluzionari che diventano reazionari.
Si deve riconoscere al processo rivoluzionario il suo carattere eminentemente pedagogico. Di una pedagogia che formula problemi e non deposita nozioni in banca.
Nel processo di manipolazione quasi sempre le sinistre si sentono tentate dal “giro intorno al potere”, e dimenticando i loro incontri con le masse, in funzione dell’organizzazione, si perdono in un “dialogo” impossibile con le élite dominanti. E finiscono per essere manovrate da queste élite e cadono in un gioco di gruppi dirigenti, che chiamano realismo...
La manipolazione, nella teoria dell’azione anti-dialogica, deve anestetizzare le masse popolari affinché non pensino, allo stesso modo della conquista, al cui servizio essa si trova. Le famiglie e le scuole, elementari medie superiori di livello universitario, che non esistono per aria, ma nel tempo e nello spazio, non possono sfuggire alle influenze delle condizioni strutturali obiettive. Funzionano in gran parte dentro le strutture di dominazione, come agenzie formatrici di futuri “invasori”. I rapporti padri-figli, nelle famiglie, riflettono generalmente le condizioni oggettivo-culturali della totalità di cui fanno parte. E se queste condizioni sono autoritarie rigide dominatrici, penetrano nelle famiglie che favoriscono il clima di oppressione. Quanto più si sviluppano questi rapporti di tipo autoritario tra genitori e figli, tanto più i figli, nella loro infanzia, introiettano l’autorità paterna.
Bambini deformati in un ambiente senza amore, oppressivo, frustrati nella loro potenza, come direbbe Fromm, se non riescono nella gioventù a orientarsi nel senso di una ribellione autentica, o si adagiano nelle dimissioni complete della volontà, alienati all’autorità e ai miti che questa autorità usa per “formarli”, o potranno poi assumere forme di azione distruttiva. Questa influenza della famiglia prosegue nell’esperienza della scuola. In essa gli educandi scoprono presto che, così come in famiglia, per avere qualche soddisfazione devono adattarsi ai precetti stabiliti verticalmente. E uno di questi precetti è non pensare. Introiettando l’autorità paterna attraverso un tipo rigido di rapporti che la scuola accentua, la loro tendenza, quando divengono dei professionisti, è di seguire i modelli rigidi in cui si sono formati, perché dentro di loro si installa la paura della libertà. Ciò, insieme alla loro posizione classista, spiega forse il motivo per cui un gran numero di professionisti aderisce a un’azione anti-dialogica (Questo forse aiuta a spiegare l’anti-dialogicità di coloro che, pur convinti della loro scelta rivoluzionaria, continuano tuttavia a non avere fiducia nel popolo, temendo la comunione con esso. Senza accorgersene, mantengono ancora dentro di sé l’oppressore. In realtà temono la libertà finché ospitano dentro di sé il “signore”.). Qualunque sia la loro specializzazione che li mette in contatto col popolo, la loro convinzione quasi incrollabile è che compete loro “trasferire” o portare o consegnare al popolo le loro nozioni e le loro tecniche.
I professionisti, a livello universitario o no, in qualunque specializzazione, sono uomini cresciuti sotto la “sovra-determinazione” di una cultura oppressiva che li ha portati al dualismo. Anche se venissero dalle classi popolari, la loro deformazione in fondo sarebbe la stessa, o addirittura peggiore. Tuttavia questi professionisti sono necessari alla riorganizzazione della nuova società. Ci sembra che non solo potrebbero ma dovrebbero essere recuperati dalla rivoluzione, dal momento che un gran numero tra loro, anche se feriti dalla “paura della libertà” e incerti nell’adesione a una azione umanizzante, in realtà si trovano più che altro in equivoco.
Nella misura in cui la coscientizzazione, nella “rivoluzione culturale” e attraverso di essa, diviene più profonda, nella prassi creatrice della società nuova gli uomini vanno disvelando le ragioni della permanenza delle “sopravvivenze” mitiche, che in fondo sono realtà forgiate nell’antica società. Potranno allora liberarsi più rapidamente da questi spettri che costituiscono sempre un problema serio per ogni rivoluzione, perché ostacolano l’edificazione della nuova società. Attraverso queste “sopravvivenze” la società oppressiva continua a “invadere”, e a questo punto invade la stessa società rivoluzionaria. È questa una terribile “invasione”, perché non è fatta direttamente dall’antica élite dominante (che si riorganizzasse eventualmente per questo) ma dagli uomini che hanno preso parte alla rivoluzione. “Ospiti” dell’oppressore, resistono come lui farebbe, di fronte a misure fondamentali che necessariamente vengono prese dal potere rivoluzionario. Come esseri dualisti però, accettano anche, in funzione delle “sopravvivenze”, il potere che diviene burocrazia e che li reprime violentemente.
Questo potere burocratico, violentemente repressivo, può essere a sua volta spiegato attraverso ciò che Althusser chiama «riattivazione di elementi antichi», ogni volta che circostanze speciali lo favoriscono nella nuova società. Per tutto ciò difendiamo il processo rivoluzionario come azione culturale dialogica che si prolunga in “rivoluzione culturale” con la presa del potere. […] Nella rivoluzione culturale infine, la rivoluzione, sviluppando la pratica del dialogo permanente tra leadership e popolo, consolida la partecipazione di quest’ultimo al potere.
Perciò le soluzioni puramente riformiste che queste società affrontano, pur se a volte bastano a spaventare i settori più reazionari delle sue élite, non arrivano a risolvere le contraddizioni interne. Quasi sempre, se non sempre, queste soluzioni riformiste sono suggerite dalla stessa metropoli, come risposta nuova che il processo storico impone, ma nel senso di mantenere la sua egemonia. È come se la metropoli dicesse: «Facciamo le riforme, prima che le società dipendenti facciano la rivoluzione». E per raggiungere questo scopo, la società metropolitana non ha altre strade che non siano la conquista, la manipolazione, l’invasione economica e culturale (a volte militare) della società dipendente.
[…] ripetiamo ciò che siamo andati affermando nel corso di questo saggio: l’impossibilità che la leadership rivoluzionaria usi gli stessi processi anti-dialogici di cui si servono gli oppressori per opprimere.
Nel suo diario della lotta in Bolivia, Guevara si riferisce varie volte alla mancata partecipazione dei contadini. Quando cerchiamo di spiegare questa paura e questa poca efficienza dei contadini, scopriamo in essi, in quanto coscienze dominate, l’oppressore “introiettato”.
Nella teoria dell’azione dialogica, non c’è posto per la conquista delle masse agli ideali rivoluzionari, ma per la loro adesione.
La leadership deve confidare nella potenzialità delle masse, che non può trattare come oggetti della sua azione. Deve confidare che esse siano capaci di impegnarsi nella ricerca della loro liberazione, ma deve diffidare, sempre diffidare, dell’ambiguità degli uomini oppressi. Diffidare degli uomini oppressi, non è propriamente diffidare di loro in quanto uomini, ma diffidare dell’oppressore “ospitato” dentro di loro.
Guevara mette in rilievo in questo racconto la comunione col popolo come il momento decisivo per la trasformazione di quella che era stata una «decisione spontanea e un po’ lirica», in una forza di valore definitivo e più serena. E spiega che, a partire da quella esperienza di comunione, i contadini senza accorgersene divennero gli “artefici” della ideologia rivoluzionaria.
La comunione provoca la collaborazione, che porta la leadership e le masse a quella fusione cui accenna il grande leader scomparso.
[…] se per dividere è necessario mantenere l’io dominato “aderente” alla realtà oppressiva, mitizzandola, il primo passo per unire è la demitizzazione della realtà.
[…] se per dividere è necessario mantenere l’io dominato “aderente” alla realtà oppressiva, mitizzandola, il primo passo per unire è la demitizzazione della realtà
Commenti al testo
Con questa affermazione non vogliamo dire che gli oppressi, in tal caso, non sappiano di essere oppressi. Tuttavia, la loro conoscenza di sé stessi come oppressi si trova falsata dal fatto che vivono immersi nella realtà degli oppressori. “Riconoscersi” a questo livello, in opposizione all’altro, non significa ancora lottare per il superamento della contraddizione. Nasce di lì l’aberrazione: uno dei poli della contraddizione non aspira a liberarsi, bensì a identificarsi con il suo opposto. In questo caso, per gli oppressi, “l’uomo nuovo” non è l’uomo che deve nascere dal superamento della contraddizione, con la trasformazione dell’antica situazione di oppressione che ceda il posto a una nuova, di liberazione. Per loro, l’uomo nuovo sono loro stessi, che diventano oppressori degli altri.
Vogliono la riforma agraria, in questo caso, non per liberarsi, ma per divenire proprietari, o più esattamente padroni di nuovi servi.
Perfino le rivoluzioni, che trasformano la situazione concreta di oppressione in un’altra, di liberazione, affrontano questa manifestazione tipica della coscienza oppressa. Molti degli oppressi che partecipano alla rivoluzione, sia direttamente sia indirettamente, sotto l’influenza dei vecchi miti della struttura anteriore pretendono fare della rivoluzione la loro rivoluzione privata. Perdura in essi, in un certo senso, l’ombra dell’oppressore antico. Questo continua a essere purtroppo il loro modello di ciò che è “umanità”.
Uno degli elementi fondamentali nel processo di mediazione oppressi/oppressori è la prescrizione. Ogni prescrizione è l’imposizione di una scelta, esercitata da una coscienza su un’altra. Perciò il significato della prescrizione è alienante, perché trasforma la coscienza di colui che la riceve in una coscienza-ospite dell’oppressore. Il comportamento degli oppressi è una specie di comportamento “prescritto”. Si struttura su criteri estranei, che sono quelli degli oppressori. Gli oppressi, che introiettano l’ombra degli oppressori e seguono i loro criteri, hanno paura della libertà, perché essa, comportando l’espulsione di quest’ombra, esigerebbe che il vuoto da lei lasciato fosse riempito con un altro “contenuto”, quello della loro autonomia, o della loro responsabilità, senza la quale non sarebbero liberi. La libertà, che è una conquista e non un’elargizione, esige una ricerca permanente.
Finché sono influenzati dalla paura della libertà, si rifiutano di rivolgersi ad altri e di ascoltarne l’appello, preferendo essere “aggregati” piuttosto che compagni in una convivenza autentica; preferiscono l’adattamento a cui li obbliga la loro non-libertà a una comunione creatrice, alla quale la libertà porta l’uomo, anche quando essa è solo una ricerca. Subiscono un dualismo che si installa nell’intimo del loro essere. Scoprono che, non essendo liberi, non arrivano a “essere” autenticamente. Vorrebbero “essere”, ma hanno paura.
La trama della loro lotta si delinea tra l’essere se stessi o l’essere duplici. Tra l’espellere o no l’oppressore che sta “dentro” di loro. Tra il superare l’alienazione o rimanere alienati. Tra seguire prescrizioni o fare delle scelte. Tra essere spettatori o attori. Tra agire o avere l’illusione di agire, mentre sono gli oppressori che agiscono. Tra il “parlare” o non avere voce, castrati nel loro potere di creare e ricreare, nel loro potere di trasformare il mondo. È questo il tragico dilemma degli oppressi, che la loro pedagogia deve affrontare.
Per noi, tuttavia, il nocciolo della questione non consiste nell’illuminare le masse, ma nel dialogare con loro sui motivi e le modalità della loro azione. Comunque, il dovere che Lukacs attribuisce al partito rivoluzionario di «illuminare alle masse la loro propria azione» coincide con l’esigenza da noi posta dell’inserzione critica delle masse nella loro realtà attraverso la prassi, per il fatto che nessuna realtà trasforma sé stessa.
La pedagogia dell’oppresso, che cerca la restaurazione della intersoggettività, si presenta come pedagogia dell’Uomo. Al contrario, la pedagogia che, partendo dagli interessi egoistici degli oppressori (egoismo camuffato con apparenze di generosità), fa degli oppressi gli oggetti del suo umanitarismo, mantiene e incarna l’oppressione. Questa è la ragione per cui, come s’è già detto, questa pedagogia non può essere elaborata né praticata dagli oppressori. Sarebbe una contraddizione se gli oppressori non solo difendessero ma praticassero un’educazione liberatrice. Se però la pratica di questa educazione esige che gli oppressi esercitino il potere politico, come realizzare la pedagogia dell’oppresso prima della rivoluzione?
La pedagogia dell’oppresso, come pedagogia umanistica e liberatrice, avrà due momenti distinti. Il primo, in cui gli oppressi scoprono il mondo dell’oppressione e si impegnano nella prassi a trasformarlo; il secondo, in cui, trasformata la realtà oppressiva, questa pedagogia non è più dell’oppresso e diventa la pedagogia degli uomini che sono in processo di permanente liberazione.
Nel momento però in cui il nuovo potere si indurisce come burocrazia dominante, si perde la dimensione umanistica della lotta e non si può più parlare di liberazione. Ecco il perché dell’affermazione fatta in precedenza, per cui il superamento autentico della contraddizione oppressi/oppressori non consiste nel cambio di guardia, nello scambio dei poli; non consiste neppure nel fatto che gli oppressi di oggi, proprio in nome della libertà, passino ad avere nuovi oppressori.
Questa tendenza degli oppressori a rendere senza vita tutto e tutti, che si trova nella loro ansia di possesso, si identifica indiscutibilmente con la tendenza sadica. «Il piacere che nasce dal dominio completo su un altro essere (o su un’altra creatura animata) costituisce l’essenza dell’impulso sadico.
Il sadismo appare così come una delle caratteristiche della coscienza dell’oppressore, nella sua visione necrofila del mondo. Per questo il suo amore è un amore a rovescio, un amore per la morte e non per la vita.
Dichiararsi impegnato con la liberazione e non essere capace di entrare in comunione con il popolo, che si continua a considerare assolutamente ignorante, è un equivoco doloroso.
A un certo momento dell’esperienza esistenziale degli oppressi, si verifica un’attrazione irresistibile verso l’oppressore. Verso il suo stile di vita. Partecipare a questo stile di vita costituisce un’aspirazione irresistibile. Nella loro alienazione vogliono, a ogni costo, somigliare all’oppressore. Imitarlo. Seguirlo. Ciò si verifica soprattutto negli oppressi della classe media, la cui aspirazione è divenire uguali all’uomo “illustre” della cosiddetta classe “superiore”. È interessante osservare come Memmi, in un’analisi assolutamente straordinaria della “coscienza colonizzata”, si riferisce al rifiuto del colonizzato davanti al colonizzatore, rifiuto che però è mescolato a un’attrazione “appassionata” per lui.
A forza di sentirsi dire che sono incapaci, che non sanno nulla, che non possono sapere, che sono malati cronici, indolenti, e che non producono per via di tutto questo, finiscono per convincersi della loro “incapacità”. Parlano di sé stessi come di coloro che non sanno, e del “dottore” come di colui che sa e che si deve ascoltare. Sono loro imposti criteri di sapere convenzionali.
Il fatto è che pensare autenticamente è molto pericoloso. Lo strano umanesimo di questa concezione “depositaria” si riduce al tentativo di fare degli uomini esattamente il loro contrario, degli automi, cioè la negazione della vocazione ontologica a essere di più. Gli esecutori di questa concezione “depositaria”, coscienti o no (perché esiste un certo numero di educatori di buona volontà che ignorano di essere al servizio della disumanizzazione, praticando questo mercato da banchieri) non si accorgono che tali “depositi” sono pieni di contraddizioni […].
La persona necrofila è spinta dal desiderio di trasformare l’organico nell’inorganico, di accostarsi alla vita meccanicamente, come se tutte le persone viventi fossero cose.
«Ama il controllo, e nell’atto di controllare, uccide la vita».
La sua intenzione è esattamente opposta: controllare il pensiero e l’azione, portando gli uomini ad adattarsi al mondo.
Quando gli uomini, per un motivo qualunque, sentono la proibizione di agire, quando si scoprono incapaci di usare le loro facoltà, soffrono. […]. Ma il fatto di non poter agire, che provoca la sofferenza, provoca anche negli uomini la reazione per cui rifiutano la loro impotenza. Allora tentano di ristabilire «la loro capacità di amare» (Fromm). «Possono farlo? Come? Un modo è quello di sottomettersi a una persona o a un gruppo, di identificarvisi.
Questo stesso tipo di reazione forse si può riscontrare negli oppressi, quando sono immersi nei fenomeni “populisti”. La loro identificazione con i “leader” carismatici, attraverso i quali possano sentirsi attuanti, e quindi nell’esercizio del potere, così come la loro ribellione, quando emergono dal processo storico, sono avvolte da questo impeto di ricerca di realizzazione di potere. Per le élite dominanti questa ribellione, che le minaccia, trova la sua medicina in una dominazione ancor più forte, nella repressione, fatta, tra l’altro, in nome della libertà, e nella restaurazione dell’ordine e della pace sociale. Pace sociale che in fondo non è altro che la pace privata dei dominatori.
L’educazione come pratica di dominio, che è l’oggetto di questa critica, conservando la coscienza “naturale” degli educandi, pretende, nell’ambito della sua definizione ideologica (raramente percepita da coloro che la realizzano) addottrinarli, affinché si adattino al mondo dell’oppressione.
Il nostro obbiettivo è fare un richiamo agli autentici umanisti e avvertirli che non possono, nella ricerca della liberazione, servirsi della concezione “depositaria”, sotto pena di contraddire la loro stessa ricerca. Così pure, questa concezione non può diventare eredità della società oppressiva alla società rivoluzionaria, la quale, se mantiene questa concezione “depositaria” dell’educazione, o è caduta in equivoco o si è lasciata “mordere” dalla sfiducia nell’uomo. In qualunque ipotesi, sarà minacciata dallo spettro della reazione.
A questo punto nessuno educa nessuno, e neppure sé stesso: gli uomini si educano in comunione, attraverso la mediazione del mondo.
Nessuno può “essere’’, con autenticità, mentre impedisce che gli altri siano. E questa un’esigenza radicale. L’essere di più ricercato nell’individualismo conduce a un avere di più egoista, che è una forma di essere di meno.
Per il pensare acritico, l’importante è adattarsi a questo oggi normalizzato. Per quello critico, l’importante è la trasformazione permanente della realtà, in vista della permanente umanizzazione degli uomini.
Questa pratica esige che l’accostamento alle masse popolari si faccia, non per portare loro un messaggio “salvifico”, in forma di contenuto da depositarsi, ma per conoscere, nel dialogo con esse, non soltanto l’oggettività in cui si trovano, ma la coscienza che hanno di questa oggettività: i vari livelli di percezione di sé stessi e del mondo, in cui e con cui si trovano.
Ne deriva che il contenuto di un programma di azione, che appartiene ad ambedue, non può essere una scelta esclusiva degli educatori o dei politici, ma di loro e del popolo.
È lo sforzo di proporre agli individui dimensioni significative della loro realtà, la cui analisi critica renda loro possibile riconoscere l’interazione delle sue parti.
In una visione liberatrice, e non più “depositaria” dell’educazione, il contenuto dei programmi non è l’involucro degli obiettivi da imporre al popolo, ma il riflesso delle sue aspirazioni e le sue speranze (perché parte e nasce dal popolo, in dialogo con gli educatori). Dunque la ricerca della tematica è il punto di partenza del processo educativo e della sua capacità di dialogo.
La “coscienza possibile” (Goldmann) sembra che si possa identificare con quello che Nicolai chiama “soluzioni praticabili non percepite” (che è poi il nostro “possibilità ancora inedite di azione”) in opposizione alle “soluzioni praticabili percepite” e alle “soluzioni effettivamente realizzate”, che corrispondono alla “coscienza reale” o effettiva di Goldmann.
Gli individui “immersi” nella realtà con la sola sensibilità dei propri bisogni, ne emergono, e così raggiungono la ragione dei loro bisogni. In questo modo potranno superare molto più rapidamente il livello della “coscienza reale” e attingere quello della “coscienza possibile”. Se tale è l’obiettivo dell’educazione “problematizzante” che difendiamo, l’investigazione tematica, che ne è lo strumento, non più sottrarsi a questo obiettivo.
Gli uomini sono esseri di prassi. Sono esseri del “che-fare”, mentre gli animali sono esseri del puro “fare”. Gli animali non “vedono” il mondo. Vi si immergono. Gli uomini, al contrario, in quanto esseri del “che-fare”, ne emergono e, oggettivandolo, possono conoscerlo e trasformarlo col loro lavoro.
Gli uomini invece sono esseri del “che-fare”, perché il loro “che-fare” è azione e riflessione. È prassi. È trasformazione del mondo. Se il “che-fare” è prassi, il fare dell’uomo deve avere una teoria che necessariamente lo illumini. Il “che-fare” è teoria e pratica. È riflessione e azione.
La famosa affermazione di Lenin: «Senza teoria rivoluzionaria non ci può essere movimento rivoluzionario» significa precisamente che non si fa rivoluzione col verbalismo, e nemmeno con l’attivismo, ma con la prassi, cioè con la riflessione e l’azione, che influiscono sulle strutture in trasformazione. Lo sforzo rivoluzionario che ne consegue non può avere nella sua leadership uomini del che-fare e nelle masse oppresse uomini ridotti al puro fare.
Non è possibile che la leadership consideri gli oppressi puri e semplici esecutori delle sue determinazioni, attivisti cui si neghi la riflessione sul proprio fare. Gli oppressi, nell’illusione di fare qualcosa (attraverso l’azione della leadership) continuano a essere manipolati, ed esattamente da coloro che non dovrebbero farlo, in ragione della natura della loro funzione. Perciò, quando la leadership nega la vera prassi agli oppressi, nega anche la sua.
Se l’impegno della leadership è veramente quello della liberazione, il suo “che-fare” (azione e riflessione) non può esistere senza l’azione e la riflessione degli altri.
Una leadership rivoluzionaria, che non sia dialogica con le masse, o mantiene “l’ombra” del dominatore “dentro” di sé, e non è rivoluzionaria, o si trova in un grosso equivoco, e diviene prigioniera di un settarismo indiscutibilmente morboso; anche in questo caso non è rivoluzionaria. Può arrivare al potere, ma dubitiamo di una rivoluzione che risulti da questo “che-fare” anti-dialogico.
Tra l’altro il dualismo esistenziale può favorire la nascita di un clima di settarismo che porta facilmente alla strutturazione di “burocrazie” che corrodono la rivoluzione. Se le masse prendono coscienza, nel corso del processo, di questa ambiguità, può accadere che accettino la propria partecipazione al potere con uno spirito di rivincita più che di rivoluzione. Possono inoltre aspirare alla rivoluzione come a un mezzo di dominazione e non come a un cammino di liberazione. Possono visualizzare la rivoluzione come la loro rivoluzione privata, ciò che ancora una volta rivela una delle caratteristiche degli oppressi, di cui si è parlato nel primo capitolo di questo saggio.
La vera rivoluzione, prima o poi, deve aprire il dialogo coraggioso con le masse; la sua legittimità si trova in questo dialogo, e non nel ristagno o nella menzogna. Non può temere le masse, la loro espressività, la loro partecipazione effettiva, al potere. Non può negarle. Non può sottrarsi a una resa dei conti con esse, a dire loro i successi, gli errori, gli equivoci, le difficoltà. Siamo convinti che, quanto prima comincia il dialogo, più rivoluzione ci sarà. Questo dialogo, come esigenza radicale della rivoluzione, risponde a un’altra esigenza radicale, quella degli uomini, che non possono “essere” fuori della comunicazione, perché sono “comunicazione”. Ostacolare la comunicazione significa trasformarli quasi in cose, e questo è compito e obiettivo degli oppressori, non dei rivoluzionari.
Cioè, la leadership ha negli oppressi i soggetti dell’azione liberatrice, e nella realtà la mediazione dell’azione trasformatrice di ambedue. In questa teoria dell’azione, esattamente perché è rivoluzionaria, non è possibile parlare di attore al singolare né di attori al plurale, ma di attori nella inter-soggettività, nell’intercomunicazione.
Molti, perché attaccati a una visione meccanicistica, pensano che la trasformazione della realtà si può fare in termini meccanici: essi non percepiscono l’ovvia verità che la situazione concreta, in cui gli uomini stanno, condiziona la loro coscienza del mondo, e questa a sua volta condiziona il loro atteggiamento e la loro maniera di affrontarla. Cioè pensano che la trasformazione della realtà si può fare senza problematizzare questa falsa concezione del mondo o senza che l’azione rivoluzionaria approfondisca la sia pur meno falsa coscienza degli oppressi. Non esiste realtà storica (altra affermazione ovvia) che non sia umana. Non c’è storia senza gli uomini, come non c’è una storia per gli uomini, ma una storia di uomini che, fatta da loro, al tempo stesso li fa, come disse Marx.
Chi può pensare senza le masse (e non può permettersi il lusso di non pensare ad esse), è l’élite dominante; […] Pensare con esse sarebbe il superamento della loro contraddizione. Pensare con loro significherebbe non dominare più. Perciò l’unica forma di pensare giusto dal punto di vista degli oppressori è non lasciare che le masse pensino, il che vuol dire: non pensare con esse.
“Benché sembri magnifico in teoria il progetto di dare istruzione alle classi lavoratrici, sarebbe nocivo alla loro morale e alla loro felicità; insegnerebbe a disprezzare la loro missione nella vita, invece di farne buoni servi per l’agricoltura e altri impieghi; invece di insegnare loro ad essere subordinati, li renderebbe ribelli e refrattari, come si rivelò evidente nelle contee manifatturiere; li renderebbe capaci di leggere libercoli sediziosi, libri perversi e pubblicazioni contro la cristianità: li renderebbe arroganti verso i loro superiori, e in pochi anni diverrebbe necessario, per la legislazione, dirigere contro di essi il braccio forte del potere». In fondo, quello che MrGiddy, citato da Niebhur, voleva, è simile a ciò che vogliono i MrGiddy di oggi, cioè che le masse non pensino.
Alcuni pensano, a volte con retta intenzione, ma in base a equivoci, che giacché il processo dialogico è lento (il che non è vero) si deve fare la rivoluzione senza comunicazione, attraverso comunicati, e dopo che si è fatta, allora svolgere un ampio sforzo educativo. Anche perché, dicono, non è possibile fare educazione prima della presa del potere. Educazione liberatrice. Nelle affermazioni di coloro che pensano così ci sono alcuni punti fondamentali. Credono (ma non tutti) alla necessità del dialogo con le masse, ma non che sia possibile prima della conquista del potere. Quando affermano che non è possibile un tipo di comportamento educativo-critico prima della conquista del potere, negano il carattere pedagogico della rivoluzione, come azione culturale, che si prepara ad essere rivoluzione culturale. D’altra parte, confondono il senso pedagogico della rivoluzione con la nuova educazione che deve essere inaugurata dopo la conquista del potere. […] la conquista del potere è solo un momento, anche se decisivo. In quanto processo, il “prima” della rivoluzione si trova nella società oppressiva ed è solo apparente.
Ecco perché la conquista del potere è appena un momento decisivo di un processo che continua. Quindi, in una visione dinamica e non statica della rivoluzione, essa non ha un prima e un dopo assoluti. […] Generata in determinate condizioni obiettive, essa cerca il superamento della situazione oppressiva con l’instaurazione di una società di uomini in processo di permanente liberazione. Il senso pedagogico, dialogico, della rivoluzione, che ne fa anche una “rivoluzione culturale”, deve accompagnarla in tutte le sue fasi. È questo un mezzo efficace per evitare che il potere rivoluzionario si istituzionalizzi, stratificandosi nelle forme di una “burocrazia” contro-rivoluzionaria, perché la contro-rivoluzione è caratteristica anche dei rivoluzionari che diventano reazionari.
Si deve riconoscere al processo rivoluzionario il suo carattere eminentemente pedagogico. Di una pedagogia che formula problemi e non deposita nozioni in banca.
Nel processo di manipolazione quasi sempre le sinistre si sentono tentate dal “giro intorno al potere”, e dimenticando i loro incontri con le masse, in funzione dell’organizzazione, si perdono in un “dialogo” impossibile con le élite dominanti. E finiscono per essere manovrate da queste élite e cadono in un gioco di gruppi dirigenti, che chiamano realismo...
La manipolazione, nella teoria dell’azione anti-dialogica, deve anestetizzare le masse popolari affinché non pensino, allo stesso modo della conquista, al cui servizio essa si trova. Le famiglie e le scuole, elementari medie superiori di livello universitario, che non esistono per aria, ma nel tempo e nello spazio, non possono sfuggire alle influenze delle condizioni strutturali obiettive. Funzionano in gran parte dentro le strutture di dominazione, come agenzie formatrici di futuri “invasori”. I rapporti padri-figli, nelle famiglie, riflettono generalmente le condizioni oggettivo-culturali della totalità di cui fanno parte. E se queste condizioni sono autoritarie rigide dominatrici, penetrano nelle famiglie che favoriscono il clima di oppressione. Quanto più si sviluppano questi rapporti di tipo autoritario tra genitori e figli, tanto più i figli, nella loro infanzia, introiettano l’autorità paterna.
Bambini deformati in un ambiente senza amore, oppressivo, frustrati nella loro potenza, come direbbe Fromm, se non riescono nella gioventù a orientarsi nel senso di una ribellione autentica, o si adagiano nelle dimissioni complete della volontà, alienati all’autorità e ai miti che questa autorità usa per “formarli”, o potranno poi assumere forme di azione distruttiva. Questa influenza della famiglia prosegue nell’esperienza della scuola. In essa gli educandi scoprono presto che, così come in famiglia, per avere qualche soddisfazione devono adattarsi ai precetti stabiliti verticalmente. E uno di questi precetti è non pensare. Introiettando l’autorità paterna attraverso un tipo rigido di rapporti che la scuola accentua, la loro tendenza, quando divengono dei professionisti, è di seguire i modelli rigidi in cui si sono formati, perché dentro di loro si installa la paura della libertà. Ciò, insieme alla loro posizione classista, spiega forse il motivo per cui un gran numero di professionisti aderisce a un’azione anti-dialogica (Questo forse aiuta a spiegare l’anti-dialogicità di coloro che, pur convinti della loro scelta rivoluzionaria, continuano tuttavia a non avere fiducia nel popolo, temendo la comunione con esso. Senza accorgersene, mantengono ancora dentro di sé l’oppressore. In realtà temono la libertà finché ospitano dentro di sé il “signore”.). Qualunque sia la loro specializzazione che li mette in contatto col popolo, la loro convinzione quasi incrollabile è che compete loro “trasferire” o portare o consegnare al popolo le loro nozioni e le loro tecniche.
I professionisti, a livello universitario o no, in qualunque specializzazione, sono uomini cresciuti sotto la “sovra-determinazione” di una cultura oppressiva che li ha portati al dualismo. Anche se venissero dalle classi popolari, la loro deformazione in fondo sarebbe la stessa, o addirittura peggiore. Tuttavia questi professionisti sono necessari alla riorganizzazione della nuova società. Ci sembra che non solo potrebbero ma dovrebbero essere recuperati dalla rivoluzione, dal momento che un gran numero tra loro, anche se feriti dalla “paura della libertà” e incerti nell’adesione a una azione umanizzante, in realtà si trovano più che altro in equivoco.
Nella misura in cui la coscientizzazione, nella “rivoluzione culturale” e attraverso di essa, diviene più profonda, nella prassi creatrice della società nuova gli uomini vanno disvelando le ragioni della permanenza delle “sopravvivenze” mitiche, che in fondo sono realtà forgiate nell’antica società. Potranno allora liberarsi più rapidamente da questi spettri che costituiscono sempre un problema serio per ogni rivoluzione, perché ostacolano l’edificazione della nuova società. Attraverso queste “sopravvivenze” la società oppressiva continua a “invadere”, e a questo punto invade la stessa società rivoluzionaria. È questa una terribile “invasione”, perché non è fatta direttamente dall’antica élite dominante (che si riorganizzasse eventualmente per questo) ma dagli uomini che hanno preso parte alla rivoluzione. “Ospiti” dell’oppressore, resistono come lui farebbe, di fronte a misure fondamentali che necessariamente vengono prese dal potere rivoluzionario. Come esseri dualisti però, accettano anche, in funzione delle “sopravvivenze”, il potere che diviene burocrazia e che li reprime violentemente.
Questo potere burocratico, violentemente repressivo, può essere a sua volta spiegato attraverso ciò che Althusser chiama «riattivazione di elementi antichi», ogni volta che circostanze speciali lo favoriscono nella nuova società. Per tutto ciò difendiamo il processo rivoluzionario come azione culturale dialogica che si prolunga in “rivoluzione culturale” con la presa del potere. […] Nella rivoluzione culturale infine, la rivoluzione, sviluppando la pratica del dialogo permanente tra leadership e popolo, consolida la partecipazione di quest’ultimo al potere.
Perciò le soluzioni puramente riformiste che queste società affrontano, pur se a volte bastano a spaventare i settori più reazionari delle sue élite, non arrivano a risolvere le contraddizioni interne. Quasi sempre, se non sempre, queste soluzioni riformiste sono suggerite dalla stessa metropoli, come risposta nuova che il processo storico impone, ma nel senso di mantenere la sua egemonia. È come se la metropoli dicesse: «Facciamo le riforme, prima che le società dipendenti facciano la rivoluzione». E per raggiungere questo scopo, la società metropolitana non ha altre strade che non siano la conquista, la manipolazione, l’invasione economica e culturale (a volte militare) della società dipendente.
[…] ripetiamo ciò che siamo andati affermando nel corso di questo saggio: l’impossibilità che la leadership rivoluzionaria usi gli stessi processi anti-dialogici di cui si servono gli oppressori per opprimere.
Nel suo diario della lotta in Bolivia, Guevara si riferisce varie volte alla mancata partecipazione dei contadini. Quando cerchiamo di spiegare questa paura e questa poca efficienza dei contadini, scopriamo in essi, in quanto coscienze dominate, l’oppressore “introiettato”.
Nella teoria dell’azione dialogica, non c’è posto per la conquista delle masse agli ideali rivoluzionari, ma per la loro adesione.
La leadership deve confidare nella potenzialità delle masse, che non può trattare come oggetti della sua azione. Deve confidare che esse siano capaci di impegnarsi nella ricerca della loro liberazione, ma deve diffidare, sempre diffidare, dell’ambiguità degli uomini oppressi. Diffidare degli uomini oppressi, non è propriamente diffidare di loro in quanto uomini, ma diffidare dell’oppressore “ospitato” dentro di loro.
Guevara mette in rilievo in questo racconto la comunione col popolo come il momento decisivo per la trasformazione di quella che era stata una «decisione spontanea e un po’ lirica», in una forza di valore definitivo e più serena. E spiega che, a partire da quella esperienza di comunione, i contadini senza accorgersene divennero gli “artefici” della ideologia rivoluzionaria.
La comunione provoca la collaborazione, che porta la leadership e le masse a quella fusione cui accenna il grande leader scomparso.
[…] se per dividere è necessario mantenere l’io dominato “aderente” alla realtà oppressiva, mitizzandola, il primo passo per unire è la demitizzazione della realtà.
[…] se per dividere è necessario mantenere l’io dominato “aderente” alla realtà oppressiva, mitizzandola, il primo passo per unire è la demitizzazione della realtà
Commenti al testo
Il
povero Cristo
ha visto com'è l'uomo
che il povero Cristo
mangia verze e patate
e intanto chi gli è sopra
si gode oro e alloro
e ammucchia per sé solo
ricchezze smisurate
ma appena gliele ha tolte
non divide in uguaglianza
ma del padrone apprende
il pensiero e l'arroganza
(Vinicio Capossela – Il povero Cristo, in Ballate per uomini e bestie)
ha visto com'è l'uomo
che il povero Cristo
mangia verze e patate
e intanto chi gli è sopra
si gode oro e alloro
e ammucchia per sé solo
ricchezze smisurate
ma appena gliele ha tolte
non divide in uguaglianza
ma del padrone apprende
il pensiero e l'arroganza
(Vinicio Capossela – Il povero Cristo, in Ballate per uomini e bestie)
Nell’articolo La
rivoluzione nasce all’asilo sostenevo come fosse necessario
cercare nella pedagogia le risposte ai fallimenti della politica, ai
tradimenti delle rivoluzioni (o al tradimento permanete della
rivoluzione). Successivamente ho incontrato, fortunatamente, un
testo che conferma e rafforza l’intuizione di volgere lo sguardo
lateralmente ai testi “politici” per comprendere meglio la politica
delle azioni umane, un po’ come continuare a manovrare dal posto di
guida ma cacciando la testa fuori dal finestrino per avere una
visuale più ampia. Così ho incontrato Paolo Freire, questo pedagogo
brasiliano molto conosciuto e autorevole negli anni ’60 e ’70, in
qualche modo classificato come appartenente al filone della
cosiddetta “Pedagogia Critica”, in cui ritroviamo anche Ivan Illich,
Don Milani, Danilo Dolci i quali, insieme a Montessori, condividono
una forte impronta cattolica e che ci ha lasciato diversi testi tra
cui La
Pedagogia degli oppressi, che qui viene smontato e
ri-assemblato secondo il percorso delle mie personali sottolineature
del testo originario. Con questo incontro ho scoperto che il
rapporto tra pedagogia e politica è stato già oggetto di analisi e
di sperimentazione concreta, anche se poi nuovamente eclissato,
secondo un destino comune al pensiero di molti autori seminali, i
quali vanno perciò continuamente riscoperti. Leggendo Freire si ha
subito chiara la percezione di come non vi sia nel suo pensiero
separazione alcuna tra la sfera dell’agire quotidiano e quella della
politica. In Freire non ha senso concepire la politica e la
pedagogia come entità separate, per cui lavorare giorno per giorno
nell’insegnamento e vale a dire vivere il processo in cui i soggetti
prendono coscienza di sé, corrisponde a fare politica senza
ulteriori specificazioni. Dal punto di vista della pedagogia di
Freire infatti non esiste possibilità di sottrarsi al proprio
compito di “umanizzazione”, non esiste tregua lungo il proprio
“che-fare” quotidiano, al massimo si tratta di passare da una
“guerra di posizione ad una guerra di movimento”, per dirla con
Gramsci, quando la politica evolve, finalmente, verso un momento
rivoluzionario. Infatti dato che la rivoluzione è un momento della
politica essa è un momento della pedagogia dell’oppresso (che è poi
la pedagogia della liberazione degli oppressi). Ecco allora una
prospettiva del tutto ribaltata: non più la liberazione come
semplice conseguenza della rivoluzione (che vuol dire poi anche che
se non si vive sull’orlo di una rivoluzione non si può allora
lottare veramente per la liberazione), ma la rivoluzione come
continuazione necessaria del processo di liberazione, come momento
di formalizzazione, e non certo di conclusione, di un lavoro già in
essere, di un’opera già in costruzione. L’azione liberatrice che la
pedagogia degli oppressi deve attuare da subito è imprescindibile
dato che una fase rivoluzionaria che dovesse maturare senza questa
consapevole preparazione non avrebbe nessuna possibilità di liberare
gli oppressi cancellando dalla storia l’oppressione, ma solo di
trasformare i vecchi oppressi in nuovi oppressori. Il processo
culturale, per sua natura molto complesso e lungo, sotteso al
percorso di liberazione non è in alcun modo eludibile nel processo
“rivoluzionario” e pensare di poter rivoluzionare il mondo senza
curarsi di rivoluzionare l’inconscio, prima ancora che la coscienza,
è una semplificazione che non ci si può più concedere. Per
utilizzare delle metafore si potrebbe dire che rivoluzionare la
società senza averla preventivamente predisposta al cambiamento
equivale a seminare un raccolto in un terreno mai coltivato e
neanche preventivamente arato, o come costruire un edificio, anche
bello, ma senza averne prima gettato le fondamenta. D’altra parte
aver arato per bene il terreno o aver gettato buone fondamenta non
garantisce di per sé un buon raccolto o la costruzione di un
bell’edificio, non rende scontato l’esito dell’opera, per cui non è
possibile in nessun modo ritenere che la rivoluzione possa esaurirsi
nel processo culturale, ma solo che questa non può prescindere da
quello. Educare l’uomo alla propria libertà (L’educazione come
pratica della libertà è il titolo di un altro testo di Freire,
molto assonante con Educare alla libertà di Montessori)
equivale in Freire a educarlo, di fatto, alla rivoluzione, dal
momento che questa libertà non può manifestarsi compiutamente nella
società degli oppressori. La prospettiva rivoluzionaria assume
dunque una dimensione di lungo termine, che lungi dall’essere una
rinuncia, diviene un informare qualsiasi atto quotidiano nella
direzione della preparazione delle condizioni per cui non solo una
rivoluzione possa avvenire ma possa anche vincere effettivamente. In
questo sguardo gli eventi futuri possono strabordare dai limiti
esistenziali del singolo, esorbitare rispetto al limitatissimo
numero di decenni utili nella vita politica delle persone e
necessariamente assumere i passaggi generazionali come proprio tempo
di azione. Ma ciò che si può cercare di lasciare in eredità alle
generazioni in formazione non può essere ancora un’altra teoria,
un’altra dottrina, il rispetto per un certo tipo di morale, ma
soprattutto un modo di essere e di sentire radicalmente
incompatibile con la “visione necrofila del mondo”. La rivoluzione
non la si prepara moltiplicando l’impegno nelle riunioni politiche,
o nei movimenti finalizzati a ricreare luoghi per poter fare
riunioni politiche, alla fine infischiandosene di come nel frattempo
crescono e si formano le nuove generazioni, perdendo di volta in
volta l’appuntamento con l’unico evento fondamentale per la
rivoluzione e cioè quella manciata di anni in cui le personalità
prendono forma imparando ad assecondare o a fuggire tutto ciò che
puzza, anche lontanamente, di morte prematura. La “visione necrofila
della vita” è una perversione esistenziale immanente all’esistenza
di chi pensando di non poter vivere appieno la propria vita, per
convinzione di inadeguatezza generalizzata (potremmo dire per falsa
consapevolezza di sé) indotta dalle pratiche “educative”
depositarie, comincia a sviluppare un’ammirazione per tutto ciò che
nega anche agli altri di poterlo fare, in un’accettazione e
proliferazione della castrazione socializzata di ogni impulso
vitalistico, la quale ricorda molto da vicino l’analisi che Deleuze
e Guattari conducono dettagliatamente nel loro Anti-Edipo
circa le dinamiche di edipizzazione dell’inconscio. La rivoluzione
la si prepara dunque addestrando l’inconscio a fuggire la
castrazione e la puzza di morte, non (solo) insegnando alla
coscienza la distinzione razionale, e dottrinaria, tra giustizia e
ingiustizia sociale. Freire ci chiama ad un lavoro di addestramento
dell’istinto (di classe) ad annusare con efficacia la differenza tra
il cadaverico ed il feromonico per capire come orientarsi verso la
vita nei percorsi dell’esistenza. La formazione del carattere
personale non si basa sulle acquisizioni della coscienza, che rende
l’uomo capace di ragionare ed argomentare una scelta, ma sui
meccanismi inconsci che precedono e regolano la scelta degli
argomenti da utilizzare per spiegare le proprie convinzioni e che
investe una già avvenuta adesione alle fonti da cui trarre le
proprie argomentazioni. C’è un’adesione inconscia a tutto un
universo culturale che precede l’analisi e la teorizzazione del
nostro posto al mondo. Quest’adesione, ci suggerisce Montessori, ma
anche Deleuze e Guattari, avviene nel periodo in cui la persona non
è ancora in grado di teorizzare sulla propria posizione al mondo,
non ne è ancora cosciente, e tuttavia già manifesta verso le
imposizioni della vita sociale un’aderenza, che porterà ad una
visione sostanzialmente paranoica, o una resistenza, che all’opposto
porterà ad una ricerca continua di vie di fuga (tendenza definita
“shizo” nell’Anti-Edipo) dalla repressione cui l’inconscio è
inevitabilmente sottoposto nella società capitalista. Tutto questo
panorama di “visioni”, che per Deleuze e Guattari sono “pre-consce”
e per Montessori “caratteriali”, prescindono dalle scelte
ideologiche del soggetto, il quale troverà strategie varie per
adattare scelte ideologiche, anche incoerenti, alla propria visione
di fondo. Ed è sulla formazione di questa visione di fondo che la
pedagogia ha un potere che la rende imprescindibile per la politica.
Per questo motivo l’azione rivoluzionaria lungi che dai suoi luoghi
storici quali l’attivismo militante, i partiti politici, le
organizzazioni di massa, la disciplina militare e via dicendo, deve
cercare il proprio contesto naturale nei luoghi di formazione (di
educazione) dei soggetti, principalmente nella scuola, non
escludendo con ciò anche altri momenti di crescita collettiva, nei
quali concretizzandosi, secondo Freire, in azione educatrice non
autoritaria, non “depositaria” ma “dialogica” (informata al dialogo,
allo scambio, alla comunione) formi il soggetto critico in
opposizione al soggetto oppresso, quest’ultimo incapace di autonomia
esistenziale e incline all’eterodirezione, oltre che desideroso di
essa. Sarebbe infatti alquanto bizzarro pensare che un termine come
“educazione” possa intendersi per un pedagogo metaforicamente e non
implicare nessuna riflessione sul referente principale dell’azione
educativa ovvero il bambino. Ecco quindi che i soldati di questa
lotta non possono essere i militanti di questa o quella
organizzazione rivoluzionaria, di questo o quel sindacato, di questo
e quel partito, fatto da persone che anche sinceramente aspiranti ad
essere uomini hanno ormai dell’uomo un’idea del tutto sbagliata e
che finiscono per fare della rivoluzione la “propria rivoluzione
personale”. Diceva Montessori che “Desiderare di trasformare gli
uomini adulti è vano” e ancora più esplicitamente che “Se si aspira
realmente a condizioni migliori, a una maggiore luce di civiltà nel
popolo, bisogna pensare al bambino per ottenere i risultati a cui si
mira. […] Per esercitare un’influenza sulla società è necessario
orientarsi verso l’infanzia”. È allora chiaro che l’esercito della
liberazione è formato dai bambini, proprio quella parte della
società alla quale, in generale, non si dà alcun tipo di credito
nella teoria rivoluzionaria. I bambini nella politica semplicemente
non esistono ed è esattamente questo loro oblio in quanto soggetti
ad assicurare il permanere dell’oppressione quale tratto
caratteristico della società capitalistica (una società che ammette,
anzi impone, il liberismo economico ma non ammette di essere
libertaria). E tanto per fornire un indizio di come la politica non
formalmente di destra (attualmente), ma anche “rivoluzionaria”, o
d’opposizione al capitale (in passato), sia modellata su quella
dominante e ad essa conforme, basti indagare che importanza abbiano
i bambini per essa. Nessuna parte politica si cura davvero di cosa
accade nelle scuole, posto che ha da tempo rinunciato a curarsi di
cosa accade nelle famiglie. Nessuno si preoccupa di capire quale
modello di umanità venga fornito ai nuovi soggetti, i quali vengono
formati in continuazione, permanentemente appunto, da un’istituzione
apposita al centro di continue riforme sempre attentamente laterali
al soggetto stesso dell’istituzione. Ma è chiaro che non potrebbe
essere altrimenti, perché per fornire un diverso modello di umanità
bisognerebbe ammettere a se stessi di essere purtroppo già “una
storia sbagliata” e questo minerebbe alla base la pretesa di poter
essere in grado di educare i nuovi uomini, nella concezione per la
quale con l’insegnamento si trasmette (e “deposita”) il sapere nel
suo nuovo contenitore. Significherebbe per i dirigenti scolastici,
gli insegnanti, il personale amministrativo, i collaboratori
scolastici e così via, ammettere per prima cosa la profonda
inadeguatezza di se stessi di fronte al compito che la scuola
assegna loro. Anche per questo Freire sostiene che il percorso
formativo sia tale per tutte le parti in gioco. Esso non può
riguardare solo i bambini, che nel modello di cultura “depositario”
devono conformarsi alla prescrizione sociale, ma riguardare anche
gli insegnanti che, nel modello “dialogico”, devono rifondare se
stessi in questo medesimo percorso. La formazione è un percorso
aperto dall’esito non scontato, in cui le persone apprendono a
valutare criticamente le conseguenze del proprio agire piuttosto che
diventare depositari di una morale prescritta e prescrittiva.
Estremizzando il discorso si potrebbe dire che nessuna politica può
aspirare ad essere intimamente rivoluzionaria se non si cura di come
la società formi i propri componenti e dal momento che l’infanzia
costituisce il periodo fondamentale di questo processo di formazione
si può facilmente comprendere come la politica non possa aspirare a
migliorare il mondo senza curarsi di quale pedagogia venga applicata
nelle scuole e soprattutto in quelle dell’infanzia. Beninteso
Freire, che ha svolto la sua opera sul campo in un periodo e in un
paese che aveva necessità impellente di alfabetizzare anche masse di
adulti completamente privi di scolarizzazione, non pone l’accento
sull’infanzia come fa Montessori, ma probabilmente solo perché posto
di fronte ad una peculiare situazione concreta di emergenza
pedagogica. Tuttavia il suo pensiero costituisce un tassello
fondamentale per giungere alla conclusione che la politica non possa
più fare a meno dei bambini se vuole davvero incidere sulla realtà.
Bisogna riflettere sul fatto che i “nuovi uomini” non bisogna più
immaginarli come quelli che si formeranno a partire da un’ipotetica
rivoluzione in poi, ma quelli che concretamente e in continuazione
si formano purtroppo in questa “storia sbagliata” che tutti stiamo
già vivendo e che si può già cominciare a correggere anche se non si
vedono rivoluzioni imminenti dietro l’angolo.
Concetto di comunione
Il processo di formazione del soggetto è intimamente sociale. Nessuno si forma da solo. Per Freire però il termine “comunione” che frequentemente risuona nel suo discorrere non si limita alla semplice constatazione di questo fatto. Nel suo vocabolario comunione indica un essere “uniti” qualitativamente differente dall’essere “aggregati”. Si tratta di un progetto di unione sul quale conformare una nuova cultura sociale. Una cultura in cui la comunione tra gli individui renda la società un unico corpo, in prospettiva. La comunione va comunque esperita e sperimentata proprio a partire dall’educazione e nel rapporto di insegnamento/apprendimento che essendo di reciproco scambio implica un coinvolgimento, anche emotivo, non unidirezionale. Essere in comunione implica un sentire insieme che va al di là del sostenere le medesime idee, implica un rapporto tra i soggetti che nella società degli oppressori è confinato alla (e allo stesso tempo mortificato nella) famiglia, ma che virtualmente non ha confini. La scuola è, soprattutto oggi, il primo luogo in cui viene superato il confine familiare e nel quale sarebbe possibile lavorare su un senso di unione diverso da quello familistico e parallelamente su un significato del termine “comunione” alternativo a quello religioso, anche se probabilmente è proprio dall’ambito religioso che Freire lo mutua, anche se lo declina in senso schiettamente sociale. Pare che la comunione nella visione di Freire rappresenti l’anticipazione concreta e dal forte potere pedagogico della società senza oppressione. Ed in effetti a pensarci bene comunione e comunismo hanno la stessa radice. Questa comunione è allora la forma in cui è possibile anticipare al presente rapporti sociali non ancora esistenti ma non per mettere in scena velleitarie fughe in avanti quanto per sprigionare quel forte potere pedagogico, che queste forme aggregative posseggono, finalizzato ad informare l’adesione dei soggetti a visioni di fondo nelle quali le persone si incontrano e non si scontrano, si vedono quali parti di un tutto che non riconosce confini, né angusti né immensi. Se si riflette meglio sul concetto di comunione si può facilmente notare come esso contenga tutto un programma, anzi un intero progetto di società, quando appena ci si soffermi sul suo potenziale significato sociale liberato dal simbolismo eucaristico in cui è stato per secoli relegato. Viene quasi da pensare che la simbolizzazione religiosa della comunione tra gli umani ed il divino sia stata appositamente elaborata per ipotecare religiosamente un concetto che può, in potenza, opporsi e distruggere il primato della differenza tra gli esseri. Se appena ci si sforza di immaginare con questo termine non l’eucarestia ma letteralmente una comunione tra persone e tra corpi, ci si può immediatamente rendere conto di come esso rappresenti, in prospettiva, lo stadio di evoluzione sociale successivo a quello della famiglia. Allora non si tratta solo di rompere l’unidirezionalità del discorso didattico tradizionale mediante la comunione di idee, intenti ed emozioni che si può ottenere a scuola con un’entità, irriducibile all’individualità del singolo soggetto, come la classe ma si tratta di prendere questa entità, che è al di là della famiglia, a modello di una società che può ormai provare a rinunciare alla famiglia come sua unità elementare. Rompere l’unità della famiglia non per regredire dalla claustrofobia familiare a quella, probabilmente peggiore oltre che asociale, dell’individuo, ma per allargare il concetto di famiglia al di là dei suoi tradizionali limiti imposti dal patriarcato (sorto, come Engels insegna, con la proprietà privata). Comunione quindi come metodologia didattica, ma anche e soprattutto come obiettivo sociale con precise implicazioni politiche tanto attuali (questioni di genere) quanto in prospettiva (forme di aggregazione sociali comunitarie). Se noi abbiamo oggi la capacità di immaginare cosa possa davvero sorgere da una comunione dei corpi liberata da tutte le antiche paure e divisioni, forse possiamo intravedere il nuovo mondo che ci aspetta e rifondare la speranza in un avvenire diverso per l’umanità rispetto a quello sempre più triste a cui altrimenti ed inevitabilmente andremo incontro.
OTTOBRE 2021
Concetto di comunione
Il processo di formazione del soggetto è intimamente sociale. Nessuno si forma da solo. Per Freire però il termine “comunione” che frequentemente risuona nel suo discorrere non si limita alla semplice constatazione di questo fatto. Nel suo vocabolario comunione indica un essere “uniti” qualitativamente differente dall’essere “aggregati”. Si tratta di un progetto di unione sul quale conformare una nuova cultura sociale. Una cultura in cui la comunione tra gli individui renda la società un unico corpo, in prospettiva. La comunione va comunque esperita e sperimentata proprio a partire dall’educazione e nel rapporto di insegnamento/apprendimento che essendo di reciproco scambio implica un coinvolgimento, anche emotivo, non unidirezionale. Essere in comunione implica un sentire insieme che va al di là del sostenere le medesime idee, implica un rapporto tra i soggetti che nella società degli oppressori è confinato alla (e allo stesso tempo mortificato nella) famiglia, ma che virtualmente non ha confini. La scuola è, soprattutto oggi, il primo luogo in cui viene superato il confine familiare e nel quale sarebbe possibile lavorare su un senso di unione diverso da quello familistico e parallelamente su un significato del termine “comunione” alternativo a quello religioso, anche se probabilmente è proprio dall’ambito religioso che Freire lo mutua, anche se lo declina in senso schiettamente sociale. Pare che la comunione nella visione di Freire rappresenti l’anticipazione concreta e dal forte potere pedagogico della società senza oppressione. Ed in effetti a pensarci bene comunione e comunismo hanno la stessa radice. Questa comunione è allora la forma in cui è possibile anticipare al presente rapporti sociali non ancora esistenti ma non per mettere in scena velleitarie fughe in avanti quanto per sprigionare quel forte potere pedagogico, che queste forme aggregative posseggono, finalizzato ad informare l’adesione dei soggetti a visioni di fondo nelle quali le persone si incontrano e non si scontrano, si vedono quali parti di un tutto che non riconosce confini, né angusti né immensi. Se si riflette meglio sul concetto di comunione si può facilmente notare come esso contenga tutto un programma, anzi un intero progetto di società, quando appena ci si soffermi sul suo potenziale significato sociale liberato dal simbolismo eucaristico in cui è stato per secoli relegato. Viene quasi da pensare che la simbolizzazione religiosa della comunione tra gli umani ed il divino sia stata appositamente elaborata per ipotecare religiosamente un concetto che può, in potenza, opporsi e distruggere il primato della differenza tra gli esseri. Se appena ci si sforza di immaginare con questo termine non l’eucarestia ma letteralmente una comunione tra persone e tra corpi, ci si può immediatamente rendere conto di come esso rappresenti, in prospettiva, lo stadio di evoluzione sociale successivo a quello della famiglia. Allora non si tratta solo di rompere l’unidirezionalità del discorso didattico tradizionale mediante la comunione di idee, intenti ed emozioni che si può ottenere a scuola con un’entità, irriducibile all’individualità del singolo soggetto, come la classe ma si tratta di prendere questa entità, che è al di là della famiglia, a modello di una società che può ormai provare a rinunciare alla famiglia come sua unità elementare. Rompere l’unità della famiglia non per regredire dalla claustrofobia familiare a quella, probabilmente peggiore oltre che asociale, dell’individuo, ma per allargare il concetto di famiglia al di là dei suoi tradizionali limiti imposti dal patriarcato (sorto, come Engels insegna, con la proprietà privata). Comunione quindi come metodologia didattica, ma anche e soprattutto come obiettivo sociale con precise implicazioni politiche tanto attuali (questioni di genere) quanto in prospettiva (forme di aggregazione sociali comunitarie). Se noi abbiamo oggi la capacità di immaginare cosa possa davvero sorgere da una comunione dei corpi liberata da tutte le antiche paure e divisioni, forse possiamo intravedere il nuovo mondo che ci aspetta e rifondare la speranza in un avvenire diverso per l’umanità rispetto a quello sempre più triste a cui altrimenti ed inevitabilmente andremo incontro.
OTTOBRE 2021