
Transizioni La Città dell'Uomo
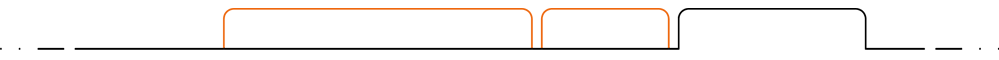
La rubrica sulla città riguarda il problema dello spazio e la sua
marginalità da quando esso non rappresenta più un oggetto di critica e
di riflessione. Ma le “rubriche” della rivista mirano a configurarsi
come gruppi di studio attorno ai loro oggetti di interesse, da qui la
proposta, a chiunque ritenga la problematica spaziale uno degli elementi
centrali per l’esercizio attivo da parte dell’uomo sul proprio ambiente
di vita, di dare il proprio contributo di studio e proposta alla
formazione di un insieme di persone impegnate sul tema. La proposta non
si rivolge solo a chi sente di possedere una formazione in qualche
disciplina specifica di conformazione spaziale, ma anche a chi,
provenendo da altri tipi di formazione e sensibilità crede di poter
arricchire i punti di vista sulla spazialità contemporanea e le sue
trasformazioni in atto, anche con sguardi trasversali. La crisi del
significato del termine “città”, che opera già da parecchi decenni, si
amplifica nell’epoca della smaterializzazione dello spazio e della
conseguente proiezione della soggettività individuale in una spazialità
sempre più virtuale ed ego-centrata in cui la relazione con l’altro
risulta soppressa. Si tratta di un processo irreversibile? Si potrebbe
cominciare a discutere da qui...
Prospettive della ricerca
La cattura del soggetto all’interno di uno spazio reale o virtuale preconfezionato e non modificabile costituisce uno dei modi attraverso i quali l’espressione dei singoli, condannati ad un’esperienza ridotta a quella di puri spettatori di un mondo concepito sempre da altri e sempre più alieno, è impedita. La città materiale se conserva un senso, lo fa in ragione del suo essere opera collettiva, testo aperto, in cui i singoli, iscrivendo il proprio contributo parziale, contribuiscono anche alla costruzione di se stessi. Se non si dà possibilità di espressione non si dà soggettività. In che modo è possibile, nella situazione attuale riconquistare il ruolo attivo di ognuno nella conformazione del proprio ambiente e attraverso di esso alla definizione non alienata di sé? Quali strumenti è possibile immaginare per la messa a frutto di pratiche di riappropriazione spaziale e del proprio “diritto alla città” in un’epoca in cui lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione ed interrelazione contribuiscono, paradossalmente, proprio all’isolamento dell’individuo? Come concepire strumenti aperti di governo dell’ambiente in una fase di crisi (terminale?) delle vecchie forme di democrazia che hanno condotto alla situazione attuale? Che tipo di spazialità potrebbe sortire da forme di partecipazione capaci di amplificare enormemente la creatività sociale? La questione dello spazio non pone, in fondo, il problema del ripensamento dello sforzo creativo dell’uomo, fin’ora dirottato in occupazioni tanto dannose quanto sterili, in nome di un’accumulazione del tutto de-territorializzata?
Articoli già presenti sulla rivista: False città; Ricordi della periferia napoletana; Spazio ed espressione: partecipazione urbanistica, esperienza chiusa o possibilità aperta?; TAV: ci sono due maniere di tracciare una strada (…e una ferrovia); KIKU, piattaforma web per l'auto-ricostruzione de L'Aquila; La fine dell'anti-città? Benevolo e Boeri sul destino dell'urbanesimo; Città Future. ovvero il futuro della città; Virt-reality show. Simulacri in città; David Harvey, «Il capitalismo contro il diritto alla città». Urbanità e marxismo; La decostruzione della città.
Testi classici di riferimento: Hans Bernoulli, La città e il suolo urbano (1951); Aldo Rossi, L’architettura della città (1966); Henri Lefebvre, Il diritto alla città (1968); Henri Lefebvre, La rivoluzione urbana (1970); Henri Lefebvre, La produzione dello spazio (1974); Vezio De Lucia, Se questa è una città (1989);
Testi più recenti oggetto di analisi: David Harvey, Il capitalismo contro il diritto alla città, David Harvey, La crisi della modernità (2002), Mike Davis, Città morte (2004), Stefano Boeri, L’anti-città (2011); Leonardo Benevolo, La fine della città (2011); Leonardo Benvolo, Il tracollo dell’urbanistica italiana (2012).
Membri del gruppo di ricerca: il gruppo è da formare
Link di interesse: Babel2 abitare critico; Eddyburg, urbanistica, politica, società; Kiku la priattaforma informatica per la ricostruzione de L'Aquila; Paolo Soleri, Una città per salvare l'uomo (documentario), Pasolini e... la forma della città.
Prospettive della ricerca
La cattura del soggetto all’interno di uno spazio reale o virtuale preconfezionato e non modificabile costituisce uno dei modi attraverso i quali l’espressione dei singoli, condannati ad un’esperienza ridotta a quella di puri spettatori di un mondo concepito sempre da altri e sempre più alieno, è impedita. La città materiale se conserva un senso, lo fa in ragione del suo essere opera collettiva, testo aperto, in cui i singoli, iscrivendo il proprio contributo parziale, contribuiscono anche alla costruzione di se stessi. Se non si dà possibilità di espressione non si dà soggettività. In che modo è possibile, nella situazione attuale riconquistare il ruolo attivo di ognuno nella conformazione del proprio ambiente e attraverso di esso alla definizione non alienata di sé? Quali strumenti è possibile immaginare per la messa a frutto di pratiche di riappropriazione spaziale e del proprio “diritto alla città” in un’epoca in cui lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione ed interrelazione contribuiscono, paradossalmente, proprio all’isolamento dell’individuo? Come concepire strumenti aperti di governo dell’ambiente in una fase di crisi (terminale?) delle vecchie forme di democrazia che hanno condotto alla situazione attuale? Che tipo di spazialità potrebbe sortire da forme di partecipazione capaci di amplificare enormemente la creatività sociale? La questione dello spazio non pone, in fondo, il problema del ripensamento dello sforzo creativo dell’uomo, fin’ora dirottato in occupazioni tanto dannose quanto sterili, in nome di un’accumulazione del tutto de-territorializzata?
Articoli già presenti sulla rivista: False città; Ricordi della periferia napoletana; Spazio ed espressione: partecipazione urbanistica, esperienza chiusa o possibilità aperta?; TAV: ci sono due maniere di tracciare una strada (…e una ferrovia); KIKU, piattaforma web per l'auto-ricostruzione de L'Aquila; La fine dell'anti-città? Benevolo e Boeri sul destino dell'urbanesimo; Città Future. ovvero il futuro della città; Virt-reality show. Simulacri in città; David Harvey, «Il capitalismo contro il diritto alla città». Urbanità e marxismo; La decostruzione della città.
Testi classici di riferimento: Hans Bernoulli, La città e il suolo urbano (1951); Aldo Rossi, L’architettura della città (1966); Henri Lefebvre, Il diritto alla città (1968); Henri Lefebvre, La rivoluzione urbana (1970); Henri Lefebvre, La produzione dello spazio (1974); Vezio De Lucia, Se questa è una città (1989);
Testi più recenti oggetto di analisi: David Harvey, Il capitalismo contro il diritto alla città, David Harvey, La crisi della modernità (2002), Mike Davis, Città morte (2004), Stefano Boeri, L’anti-città (2011); Leonardo Benevolo, La fine della città (2011); Leonardo Benvolo, Il tracollo dell’urbanistica italiana (2012).
Membri del gruppo di ricerca: il gruppo è da formare
Link di interesse: Babel2 abitare critico; Eddyburg, urbanistica, politica, società; Kiku la priattaforma informatica per la ricostruzione de L'Aquila; Paolo Soleri, Una città per salvare l'uomo (documentario), Pasolini e... la forma della città.